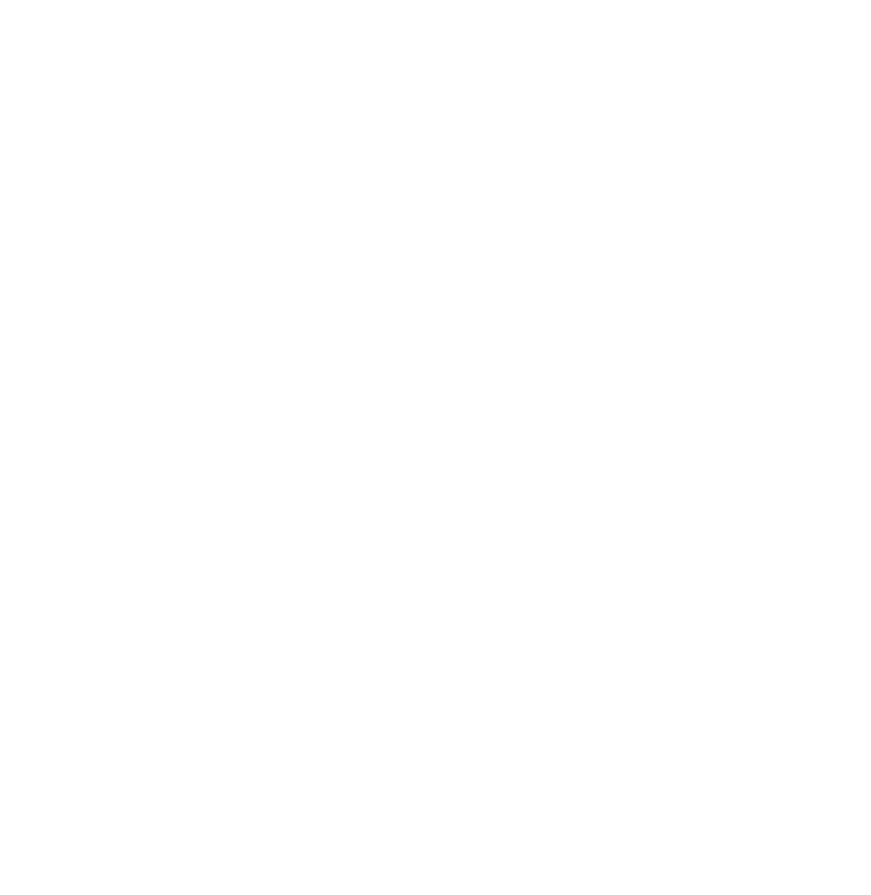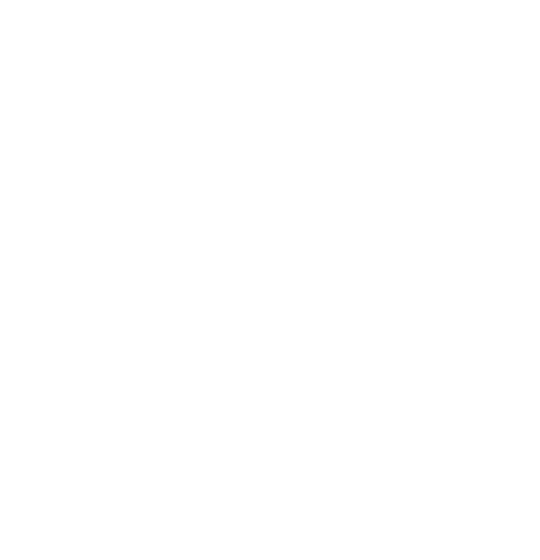Pubblichiamo qui il discorso integrale di Paolo Ruffini alla Conferenza dei Media Cattolici di Atlanta
21 giugno 2024
Prima di tutto, permettetemi di dirvi quanto sono felice di essere qui, come collega tra colleghi, e di poter partecipare a questo evento con voi, stavolta per alcuni giorni e non solo per alcune ore come è accaduto l'anno scorso.
Per quanti ancora non mi conoscono: sono uno di voi, sono un giornalista. Ho lavorato per i media laici per la maggior parte della mia vita professionale – prima per due giornali, poi per la nostra radio pubblica nazionale italiana e poi ancora per la televisione pubblica e per quella commerciale. Solo 10 anni fa sono stato chiamato a dirigere la televisione cattolica di proprietà della Conferenza Episcopale Italiana. Da 6 anni lavoro per la Santa Sede.
Nei miei primi anni qui ho imparato quanto sorprendentemente feconda possa essere la nostra testimonianza nell'ambiente laico (anche se sappiamo che è imperfetta ... perché siamo tutti esseri umani). Siamo chiamati ad essere sale e lievito ovunque lavoriamo e ad esserlo con umiltà.
In questi ultimi 10 anni ho imparato quanto sia importante avere un nostro sistema di comunicazione che sia aggiornato, creativo e bello esteticamente. Dovrebbe essere un'alternativa attraente, radicata in un modo diverso di cercare e condividere ciò che è vero, buono e giusto.
È stato bello connettersi con tutti voi, di persona, qui ad Atlanta. Connettersi l'uno con l'altro è fondamentale per costruire la nostra comunione come Chiesa.
La nostra cattolicità risiede proprio in questa comunione di diversità sotto la guida di Pietro e dei suoi successori. Comunicare la bellezza della Chiesa significa testimoniare questa unità, che ci connette a tutti coloro con cui stiamo comunicando. Ogni giorno dovremmo interrogarci su come essere fedeli a questo mandato.
Al contempo, sappiamo una cosa: per rendere testimonianza i nostri sforzi e mezzi e le nostre capacità non sono sufficienti. È per questo motivo che Gesù chiese ai discepoli di aspettare la venuta dello Spirito prima di iniziare a parlare. Affidarsi solo a noi stessi è una tentazione e dobbiamo riconoscerla come tale. Per testimoniare il mistero pasquale, abbiamo bisogno dello Spirito Santo.
La Chiesa non è fondata sull'arroganza di Babele (che produce disordine e disperde le persone – cf. Gn 11, 9), ma sull'umiltà di Pietro, per il quale Gesù ha pregato Dio Padre con queste parole: "Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano; ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga", come leggiamo nel Vangelo secondo Luca (22, 32).
Come ha osservato san Giovanni Paolo II, queste parole assicurano a Simone e ai suoi successori che Gesù pregherà per loro in modo particolare. La missione che Gesù affida a Pietro riguarda la Chiesa nei secoli e la successione delle generazioni umane. E in queste parole è annunciata la missione affidatagli, che è quella di confermare i suoi fratelli e le sue sorelle nella fede.
È solo attraverso il dono dell'amore, conferito dallo Spirito Santo, è solo attraverso la sequela di Pietro, che la Chiesa rimane salda e che la costruzione della comunione nella diversità è possibile. Questo è il servizio che ci è affidato, un servizio che dobbiamo svolgere con umiltà, testimoniando con l'esperienza della comunione ciò che ci rende "un cuore solo e un’anima sola".[1]
Siamo chiamati a rendere questa testimonianza durante una crisi di numerosi mezzi di comunicazione tradizionali, in un periodo di cambiamento epocale... Stiamo vivendo in un ambiente sempre più polarizzato e tossico che non solo minaccia le radici della democrazia, ma influisce anche sul nostro essere membri di un unico corpo ecclesiale.
Attualmente, la preoccupazione fondamentale riguardo alla comunicazione non è legata alla tecnologia, ma a ciò che sta al suo centro e le nostre domande dovrebbero quindi essere: Come possiamo rendere la nostra comunicazione uno strumento non solo di connessione, ma di comunione? Come può la comunione dare senso alla comunicazione e aiutarci a narrare la verità? Come possiamo trovare un dinamismo di speranza, un dinamismo del bene, il dinamismo della redenzione in tutto ciò che narriamo?
Dovremmo guardare a queste domande attraverso la lente del Vangelo. Permettetemi, dunque, di fare un passo indietro cominciando con un episodio evangelico. Dal momento che tra poche settimane ospiterete un congresso eucaristico, ho scelto uno degli episodi che meglio si collega a questo evento.
Lo conosciamo tutti. Narra dei due discepoli di Gesù che sono sulla strada per Emmaus. L’abbiamo ascoltato talmente tante volte che difficilmente gli prestiamo più attenzione. Tuttavia, credo che possa aiutarci nella nostra riflessione.
Comincia dalla resurrezione di Gesù. Il Vangelo narra che "in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio…. di nome Emmaus". Quello stesso giorno è il giorno in cui Gesù sarà glorificato, ma questi due discepoli ancora non lo sanno! Stanno conversando mentre camminano: hanno bisogno di elaborare tutte le cose che sono accadute. Stanno lasciando il luogo dove il loro Maestro ha fallito la propria missione ed è stato ucciso come il peggiore dei criminali e sono pieni di delusione e paura. Mentre continuano a discutere, Gesù stesso si avvicina e cammina con loro, ma i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo. Quando chiede loro “Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?”, reagiscono proprio come faremmo noi se incontrassimo qualcuno che non sa della notizia più importate e recente (come se non fosse informato, ad esempio, di un terremoto, un attacco terroristico o qualcosa di simile). Si potrebbe dire che Gesù personifica il fenomeno dell'evitamento delle notizie (sembra che gli Stati Uniti abbiano uno dei tassi più alti al mondo di evitamento delle notizie, con oltre il 40% degli americani che affermano di evitarle di proposito.....).
Solo uno straniero potrebbe fare una domanda del genere, quindi gli chiedono: "Sei l'unico forestiero a Gerusalemme a non sapere di ciò che vi è accaduto in questi giorni?"
E Gesù, che ha effettivamente vissuto in prima persona "tutto ciò che vi è accaduto", continua con le Sue domande. Vuole che raccontino la loro versione della storia di quanto Gli è accaduto! Agisce - potremmo dire - come un buon giornalista, che permette alla storia di dispiegarsi e di essere chiaramente delineata. Fare le domande giuste è alla base di un buon giornalismo.
Mentre continuano a parlare, apprendiamo qual è il loro problema più grande: lo "hanno crocifisso... noi speravamo che fosse lui a liberare Israele". Comprendiamo che la loro speranza è stata infranta e che il loro schema narrativo è quindi intriso di delusione e di disperazione. È uno schema che distorce la realtà e oscura la verità.
E solo a questo punto Gesù narra la Sua storia, infrangendo il loro schema di disperazione, definendo sciocca la loro narrazione ed esponendo un punto di vista completamente diverso ricorrendo alle Scritture: "Non bisognava che il Messia sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?"
I due non hanno ancora riconosciuto quel pellegrino che cammina con loro, ma sono interessati alla Sua versione e sono disposti a continuare ad ascoltarlo: "Resta con noi - dicono - perché si fa sera e il giorno già volge al declino".
Apprezzano la Sua prospettiva piena di speranza. Rappresentano anche bene l'atteggiamento degli utenti dei media contemporanei. Nel recente Digital News Report pubblicato pochi giorni fa dal Reuters Institute, possiamo leggere - e cito - che "nell'esaminare i bisogni degli utenti relativamente alle notizie, i nostri dati suggeriscono che i giornalisti forse si concentrano troppo sull'aggiornare le persone circa le principali notizie senza dedicare abbastanza tempo a fornire prospettive diverse sui problemi o a raccontare storie che possano offrire una base per un eventuale ottimismo".
Gesù sta effettivamente offrendo loro una prospettiva diversa, una base per l'ottimismo, per la speranza!
La storia continua con Gesù che prende il pane, rende grazie e lo spezza... ed è solo a questo punto che i discepoli ricordano e riconoscono il loro compagno di viaggio come Gesù. L'effetto che il racconto di Gesù ha su di loro è che i loro cuori "ardono". "Non ci ardeva forse il cuore mentre conversava con noi lungo il cammino e ci spiegava le Scritture?" dicono. E il secondo risultato è che questo cambiamento di prospettiva cambia anche la direzione del loro viaggio. Ritornano a Gerusalemme, alla comunità dove possono testimoniare ciò che è accaduto durante il loro incontro con il Signore risorto.
Il momento cruciale è quando Gesù spezza il pane davanti a loro. "... Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi " (Luca 24, 31-32).
Vengono loro aperti gli occhi. Capiscono perché ricordano la prima volta che questo è accaduto, all'istituzione dell'Eucaristia. Questa storia è anche la nostra storia. Questa storia si ripete ogni volta che il pane viene spezzato e partecipiamo all'Eucaristia.
Partecipare alla liturgia eucaristica significa condividere il nostro cammino con Gesù. È lì che Egli ci nutre con la Santa Comunione, che ci permette di essere in comunione con Lui e tra di noi, ed è sempre lì che Egli ci consente di modificare le nostre narrazioni. Partecipare all'Eucaristia ci rende capaci di riconoscere il Signore che cammina con noi in mezzo ai fallimenti e alle delusioni delle nostre vite. Ci rende capaci di tornare sempre alla nostra comunità. Ci permette di riscoprire che - grazie all'incontro con il Signore - tutto è stato redento. Ci consente di testimoniare la Speranza.
Trasformare le narrazioni esistenti in narrazioni piene di speranza, riconoscere il dinamismo del bene, accendere i cuori e orientarli verso la comunione con gli altri; testimoniare utilizzando un tipo di narrazione diverso, generativo e creativo... Questi sono modi per diffondere la buona novella e dare un'interpretazione cristiana a qualsiasi cosa accada nel mondo. In questo senso possiamo anche dire che l'Eucaristia nutre davvero la comprensione della nostra vocazione di comunicatori.
La connessione tra l'Eucaristia e la comunicazione è già stata splendidamente spiegata in Communio et Progressio n. 11, dove leggiamo che
“La piena comunicazione comporta la vera donazione di se stessi sotto la spinta dell'amore; ora la comunicazione del Cristo è realmente spirito e vita. Con l'istituzione dell'Eucaristia, Cristo ci consegnò la più alta forma di comunione che potesse venire partecipata agli uomini. Nell'Eucaristia si realizza infatti la comunione fra Dio e l'uomo e perciò la più intima e perfetta forma di unione fra gli uomini stessi.”
Tutta la nostra comunicazione è radicata in questo dono eucaristico di sé, che è proprio di Cristo, è la base della nostra comunione e ci orienta sempre verso la speranza. Ecco perché la nostra comunicazione non è e non può essere solo trasmissione di informazioni né solo una forma di marketing e pubblicità.
Papa Francesco dice spesso che "E la nostra comunicazione dev’essere testimonianza. Se voi volete comunicare soltanto una verità senza la bontà e la bellezza, fermatevi, non fatelo. Se voi volete comunicare una verità più o meno, ma senza coinvolgervi, senza testimoniare con la propria vita, con la propria carne quella verità, fermatevi, non fatelo. C’è sempre la firma della testimonianza in ognuna delle cose che noi facciamo."[2]
Comunicare significa accompagnarsi a vicenda nella comprensione. Comunicare significa condividere, costruire ponti con parole, immagini, storie.
Comunicare significa costruire una comunità, che non deve essere concepita come un gruppo chiuso di credenti che la pensano tutti allo stesso modo, ma come un ambiente accogliente per ciascuno, un ecosistema aperto dove ognuno si percepisce al servizio degli altri. La comunicazione ha davvero il potere di tessere la comunione, di connettere le persone, di farle partecipare a un'esperienza, di liberarle dall'isolamento e di aiutarle a riconoscersi come parte di una comunità più grande.
Molte e varie organizzazioni offrono numerose iniziative che forniscono - insieme con una storia concreta - la possibilità per il lettore di rapportarsi con loro e di esserne coinvolto. Anche le redazioni dei media possono dare un grande contributo con i loro progetti speciali che mirano a cambiare le narrazioni stereotipate. È incoraggiante individuare sforzi per superare ambienti polarizzati. C'è un'iniziativa, ad esempio, che implica raccontare storie sulla comunicazione. Si svolge intorno a un tavolo, al quale sono invitate a cena due persone che hanno opinioni completamente diverse su qualcosa. Si chiama "Dining across the divide" (Cenare oltre la divisione) e il sottotitolo è "Can breaking bread together help bridge differences?"[3] (Mangiare insieme può aiutare a colmare le differenze?)
Come Chiesa possiamo certamente offrire un modo diverso di narrare storie sui migranti, ad esempio, per porre fine ai pregiudizi, al discorso di odio e per promuovere l'integrazione. Possiamo raccontare storie e cambiare le narrazioni sui rifugiati insieme con i rifugiati: la Chiesa vive con gli emarginati. Fanno parte della Chiesa quindi la Chiesa può narrare storie non SUGLI emarginati, ma CON loro.
Alcune iniziative hanno persino fornito un "Kit di Narrazione Positiva", una serie di campagne di comunicazione di successo che condividono una narrazione positiva sulla migrazione e sull'integrazione, quale fonte di ispirazione per le autorità locali che desiderano sviluppare le proprie iniziative di comunicazione.
Nel Dicastero per la Comunicazione stiamo cercando di fornire almeno alcuni esempi di questo tipo di narrazione attraverso Vatican News e L'Osservatore Romano con progetti come "Voci di Migranti" o il "Progetto Pentecoste" che condividono storie motivanti sull’opera nascosta delle suore in 10 lingue diverse. Queste suore condividono le loro esperienze dal basso. Sono racconti di persone che accompagnano altre persone. Nessuno è in una posizione migliore per condividere una storia di chi è personalmente coinvolto nelle esperienze e nella sofferenza altrui. Questi sono solo alcuni esempi di come rendere la nostra comunicazione uno strumento concreto di comunione e speranza, cercando di connettere le persone tra loro.
Ho scoperto con piacere che il Digital News Report conferma la nostra profonda convinzione di cristiani. Uno dei modi in cui gli editori hanno cercato di risolvere il problema dell'evitamento delle notizie è stato mediante un modello basato sui "bisogni degli utenti", dove le storie che aggiornano le persone sulle ultime notizie sono integrate da altre che educano, ispirano, forniscono prospettive, connettono o intrattengono.
Questo potrebbe essere il momento migliore possibile per i comunicatori cattolici. Le persone si sentono esauste per l’enorme quantità di notizie, la cui natura negativa le fa sentire ansiose e impotenti. Aspettano che noi, comunicatori cattolici, offriamo loro una prospettiva diversa, per connetterle fra loro e invitarle a partecipare a una storia di speranza.
Tuttavia, come conciliare tutto questo con la sfida emergente delle intelligenze artificiali? Come affrontare questa crescita esponenziale dei sistemi di IA senza perdere la nostra umanità, ma anzi maturando come esseri umani?
Come sapete, la preoccupazione per l'IA è stata il tema principale del Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno e anche del suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Inoltre, solo una settimana fa, al Forum Intergovernativo del G7 in Italia, che verrà ricordato come la prima volta nella storia in cui un pontefice ha partecipato all'evento, il Papa ha tenuto un discorso programmatico sull'IA riferendosi ad essa come ad uno strumento affascinante e tremendo. Il fatto che sia stato invitato ci mostra quanto il mondo desideri un cambiamento di paradigma.
Il titolo del Messaggio di Papa Francesco per l'ultima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore” ci pone di fronte all’interrogativo: cos'è la vera intelligenza? Cos'è la vera sapienza?
La sua risposta è: “...Non possiamo pretendere questa sapienza dalle macchine. Benché il termine intelligenza artificiale abbia ormai soppiantato quello più corretto, utilizzato nella letteratura scientifica, machine learning, l’utilizzo stesso della parola “intelligenza” è fuorviante. Le macchine possiedono certamente una capacità smisuratamente maggiore rispetto all’uomo di memorizzare i dati e di correlarli tra loro, ma spetta all’uomo e solo a lui decodificarne il senso.”
L'intelligenza che è veramente “generativa” è solo quella che proviene dall’ "ardere" del cuore (cf. Lc 24, 32). È da questa esperienza di incontro personale che possono essere prese le decisioni più sagge e costruttive, come nel caso dei nostri discepoli sulla via di Emmaus.
“Non possiamo delegare la creazione di siffatte esperienze agli algoritmi, che si basano sul calcolo delle probabilità, che non sono, di fatto, né intelligenti né artificiali. La cosiddetta intelligenza artificiale generativa non è veramente "generativa". Cerca nei big data per trovare informazioni e mette insieme tutti i risultati, ma non sviluppa nuove analisi o concetti. Non fornisce la possibilità di una riflessione autentica, "rischia di ridursi a una ripetizione di nozioni, che verranno sempre di più valutate come inoppugnabili, semplicemente in ragione della loro continua riproposizione" [4]
E c'è di più... È stato dimostrato, ad esempio, che quando il sistema dietro l'IA non ha abbastanza informazioni per rispondere a una domanda, inventa le risposte, generando risposte inesatte o completamente fuorvianti, contando sul fatto che potrebbero essere probabilisticamente corrette. In gergo chiamiamo questi errori "allucinazioni". Infatti, quando l'intelligenza artificiale non ha elementi sufficienti per fare il suo calcolo potrebbe comportarsi proprio come farebbe uno studente impreparato, che non vuole fare una brutta figura davanti all'insegnante e tenta di dare risposte probabili invece che vere... solo per evitare di ammettere che non sa la risposta – poiché non è intelligente.
Il potere illimitato dell'intelligenza artificiale risiede nella sua capacità di tradurre tutto in calcoli. Ma possiamo davvero risolvere tutto facendo correlazioni statistiche? Quale delle decisioni di Dio descritte nella Sacra Scrittura si basa sulla logica del calcolo statistico? Ci sono cose che semplicemente non possono essere calcolate, perché non possono essere rapportate a numeri.
Le domande che il Papa pone alla fine del suo Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali non sono questioni astratte o marginali. Sono una denuncia del pensiero dominante a cui pongono un limite, perché ci sono cose che non possono essere misurate, cose che non possono essere comprate: relazioni, cura, compassione, collaborazione. Si tratta di qualità che il paradigma riduzionista, tecnicista, utilitaristico della tecnologia non prevede/considera.
Chiedere come tutelare la professionalità e la dignità dei lavoratori significa da un lato rivendicare l'importanza di una professione e della formazione che essa comporta e, dall'altro, rimettere l'uomo al centro.
Garantire l’interoperabilità delle piattaforme significa che a tutti viene restituita la loro libertà e che stiamo richiedendo un modello economico diverso.
Parlare della responsabilità delle piattaforme significa esplorare il confine tra le responsabilità dell'individuo e quelle della piattaforma che, attraverso un sistema di algoritmi, diffonde ciò che egli o ella scrive. E così via...
Questi non sono problemi irrisolvibili, ma richiedono impegno per una libertà e una saggezza autentiche.
La domanda è in che modo questo strumento renderà le relazioni tra individui più forti e le comunità più unite, o se aumenterà la solitudine di coloro che sono già soli, privandoci ciascuno del calore che solo una comunicazione vis-à-vis può fornire.
La questione sta nel sapere se sia possibile o impossibile sviluppare un'intelligenza artificiale che porti più uguaglianza e che non costruisca invece nuove caste basate proprio sul dominio informativo accettando come inevitabili nuove forme di sfruttamento e diseguaglianza basate sul possesso di algoritmi e sull'estrazione di dati dalla miniera inesauribile delle nostre vite.
Sta anche nel fissare o meno regole e limiti, per esempio, per gli algoritmi di indicizzazione e deindicizzazione dei motori di ricerca che sono capaci di esaltare o cancellare persone e opinioni, storie e culture secondo criteri che non hanno nulla a che fare con la verità.
Quindi, la questione di fondo non riguarda le macchine, ma gli esseri umani. Ci sono e ci saranno sempre cose che la tecnologia non può sostituire. Come la libertà. Come il miracolo dell'incontro tra le persone. Come la sorpresa dell'imprevisto. Come la Conversione. Lo sprazzo di genio. Cose come l'amore gratuito.
Papa Francesco conclude il suo Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali con queste parole: “Spetta all’uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi oppure nutrire di libertà il proprio cuore, senza il quale non si cresce nella sapienza.”
Sta a noi riscoprire l'immenso dono della Santa Eucaristia, come nutrimento della nostra comunione. E della nostra comunicazione.
Ora più che mai ciò di cui abbiamo bisogno è trovare un approccio alla tecnologia che sia etico, antropologico e basato sulla sapienza per rovesciare il teorema che è giusto chiedere tutto ciò che è possibile invece di chiedere come rendere possibile ciò che è giusto.
È solo la comunione, che è una connessione fondata sull'amore, che può renderci meno soli, che può renderci felici, e che può durare nel tempo. È il fondamento di tutta la comunicazione. Ed è questa comunione che la Chiesa è chiamata a costruire, anche mediante l'intelligenza artificiale, per stabilire una rete di comunicazione basata sulla comunione che ci unisce, sulla verità che ci rende liberi, sull'amore che spiega tutto.
Ecco il terreno su cui renderemo testimonianza, come comunicatori, come rete di comunicatori, come giornalisti, come cercatori di una verità che ci trascende, che nasce dalla relazione e dalla comunione.
------
[1] cf. At 3:43 – Popa Francesco, Udienza generale (21 agosto 2019). https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2019/documents/papa-francesco_20190821_udienza-generale.html
[2] Popa Francesco, Discorso Del Santo Padre Francesco ai Partecipanti all'assemblea Plenaria del Dicastero per la Comunicazione 23 Settembre 2019). https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190923_dicastero-comunicazione.html
[3] Iniziativa che il Guardian sta promuovendo da più di un anno – ogni settimana una nuova storia.
[4] Popa Francesco, Discorso in occasione della sessione del G7 sull'intelligenza artificiale - Borgo Egnazia (Puglia) (14 giugno 2024)