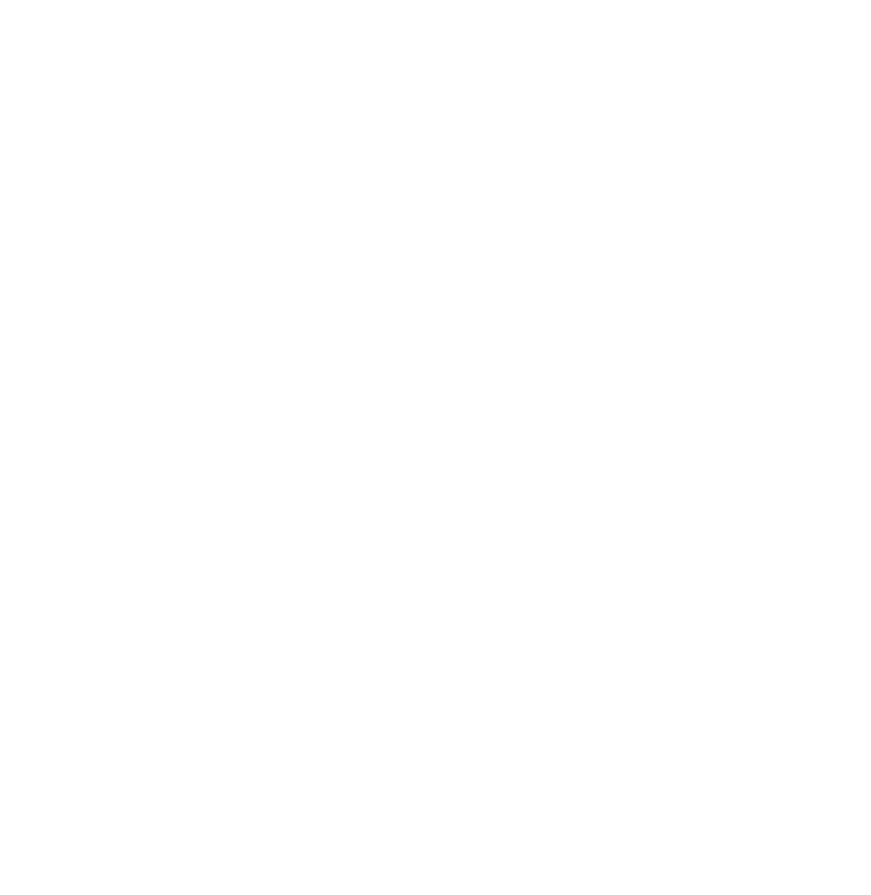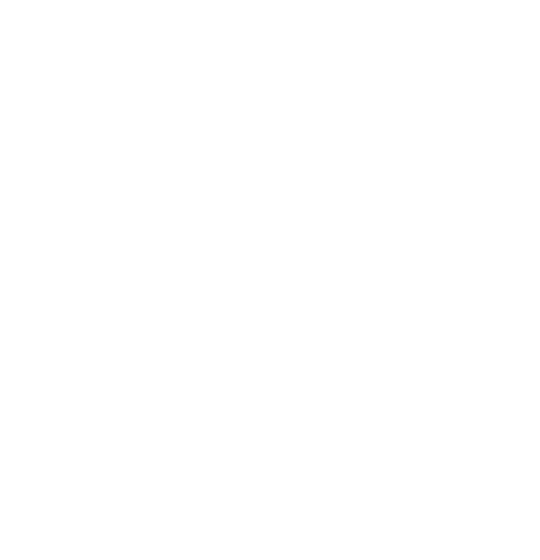di Giuliano Giulianini
Tra le molte persone degne di nota che questo anno giubilare ha condotto a Roma c'è Colum McCann. Scrittore e giornalista irlandese naturalizzato statunitense, ha partecipato al Giubileo della Comunicazione per promuovere il valore della narrazione per la pace sociale. McCann teorizza che le storie altrui, tanto più lontane dalla propria esperienza, una volta ascoltate e fatte proprie siano l’antidoto al cinismo, al razzismo, all'individualismo e perciò al conflitto in qualunque contesto. La sua organizzazione, Narrative4, entra nelle scuole, soprattutto di Stati Uniti, Messico, Inghilterra, Irlanda e Nigeria; ma anche a Bogotà, Singapore, Shanghai... e a Tel Aviv. Lo scopo è far incontrare i ragazzi, stimolarli a condividere esperienze attraverso storie, non solo tragiche ma anche di solitudine, paura, riscatto, impegno. Il passo successivo è che ognuno empatizzi con la mentalità e la cultura dell'altro, e ne riconosca infine la comune umanità: «dare un volto al nemico», come ci ha detto nell'intervista che segue. Nel momento più aspro del conflitto israelo-palestinese — quando gli orrori della cronaca e la violenta radicalizzazione delle opinioni sembrano soverchiare qualunque ipotesi di dialogo civile o comprensione reciproca — ci si chiede se esistano strade alternative che non si limitino alle condanne, all’ostracismo, alle sanzioni e agli interventi militari. All’urgenza del dialogo per superare gli odi tra i due popoli, McCann ha dedicato “Apeirogon”, romanzo dalla struttura tormentata e multiforme come la realtà di quella terra. Il libro racconta per frammenti estemporanei le vite parallele di Bassam Aramin e Rami Elhanan: un attivista palestinese e un pubblicitario israeliano. Esistenze legate indissolubilmente dall’esperienza della tragica morte di due figlie: Abir, una bambina di 10 anni, colpita fuori da scuola dalla fucilata di una guardia di confine israeliana appena maggiorenne; e Smadar, un’adolescente dilaniata dall'esplosione di un attentatore suicida palestinese mentre era in centro con le amiche.
Storie personali, interni familiari, dibattiti in pubblico, confidenze tra amici; narrazioni in cui il privato confluisce nel contesto storico. Scene di vita raccolte e romanzate dall'autore, tratte da ricordi, interviste, conferenze, testimonianze che i due padri, spesso insieme, da anni concedono in giro per il mondo; nella speranza di stemperare l’odio con l’empatia, la diffidenza con la conoscenza, i ciechi rancori con il dialogo. Nel continuo racconto che i due, ormai fratelli, ripetono sempre uguale e sempre diverso ad ogni occasione, Abir “fragranza di fiore” e Smadar “grappolo della vigna” diventano incarnazioni dei due popoli, accomunate non solo da un destino insensato, ma anche da radici culturali che si intuiscono simili, come i significati dei loro nomi nelle rispettive lingue.
C’è un adesivo sulla carena della moto con cui Rami Elahan viaggia da un incontro e l’altro, superando varchi, check point e posti di blocco improvvisati; una scritta in caratteri ebraici non facile da esibire in una terra contesa, dove i pacifisti sono per lo più malvisti e spesso minacciati da entrambe le parti: «Non finirà finché non parliamo».
McCann, qual è il ruolo della narrazione nel progresso umano e sociale?
Credo che le storie siano ciò che ci tiene insieme. Come esistono per la Scienza le forze debole, forte, nucleare e di gravità che tengono insieme la materia, la comprensione reciproca è rinsaldata dal potere delle storie. Da dieci anni Narrative4 riunisce giovani, principalmente dai 16 ai 18 anni, provenienti da contesti diversi: irlandesi, inglesi, originari di diverse parti degli Stati Uniti, del Messico, dell'Italia... Lo scopo è raccontarsi storie e cercare di capirsi a vicenda, attraverso il potere della narrazione: non promuovere un'idea, una filosofia o una nozione, ma una storia personale.
Pensa che ciò possa funzionare anche con culture, religioni ed emisferi diversi? Questa formula potrebbe mettere in contatto una ragazza pakistana e un ragazzo irlandese?
Non solo lo penso: so che funziona; l’ho visto funzionare. Mi piace l’esempio che ha fatto. Piuttosto che riunire persone dal sud e dal nord dell'Irlanda, preferiamo mettere in contatto, ad esempio, un ragazzo irlandese con un giovane italiano, o un nord irlandese con un ragazzo di Haiti. In questo modo creeremo una sorta di forza culturale: un’idea globale in cui riconosciamo le differenze tra noi, ma anche le nostre somiglianze. È una cosa incredibilmente importante da fare. L’abbiamo visto funzionare ad esempio tra ragazzi di diversa estrazione negli Stati Uniti, in Sud Africa, in Nigeria e di fatto ovunque l’abbiamo sperimentato. Ciò che abbiamo riscontrato nelle scuole dove siamo stati è che i punteggi dei test salgono, i livelli di assenteismo e di violenza scendono; semplicemente perché le persone possono, in un certo senso, iniziare a guardarsi l’un l’altra, diventare più umane, e le differenze si fanno più sfumate. L’unico modo che hanno i governi per mandare i loro giovani in guerra è rendere il nemico senza volto; ma se mostriamo quel volto è molto, molto difficile che i giovani facciano proprio quell’impegno. Questo è l’obiettivo: dare un volto al nemico.
Funziona anche con conflitti ormai radicati, come tra russi e ucraini, israeliani e palestinesi? Che cosa può ottenere la narrazione contro le armi, la politica, l'economia e la diplomazia? Il messaggio di dialogo tra “nemici” del suo libro è stato anche criticato, e tacciato di utopico sentimentalismo occidentale.
Una storia può impedire a un missile di volare e colpire? Ovviamente no. Quindi, probabilmente, nell’immediatezza della guerra non è praticabile. Però la narrazione opera in maniera molto potente prima, e soprattutto dopo: quando la vita riprende e bisogna iniziare a guarire. Mi piace l’idea che si apra un dibattito e che la gente dica: questo funziona e questo no; ma so che non è debolezza o sentimentalismo affermare che dobbiamo comunicare tra di noi. L’unica differenza o distanza tra te e me è una storia. Una storia personale. Alcuni potrebbero pensare che questa sia una pia illusione, tirare fuori i violini e cose del genere. Va bene, lo accetto; ma preferisco di gran lunga parlare col cuore in mano piuttosto che essere un cinico. Penso che i cinici siano dei sentimentali, e che il cinismo sia facile; mentre la speranza è molto, molto più difficile.
Ci sono differenze nella narrazione del giornalismo e della letteratura? Hanno ruoli e scopi diversi?
Non credo che abbiano un ruolo diverso. Gli scrittori sono scrittori e i comunicatori sono comunicatori. Non attribuisco una posizione privilegiata al romanziere, al poeta o al drammaturgo; e il giornalismo è altrettanto potente. La questione è raccontare la storia in modo appropriato, veritiero, con quante più sfaccettature e punti di vista possibili. Spesso, come giornalisti, semplicemente non abbiamo il tempo di raccontarla; ma penso che non ci sia alcun livello, classificazione o gerarchia nel mondo della narrazione.
(Da L'Osservatore Romano, lunedì 1° settembre 2025)