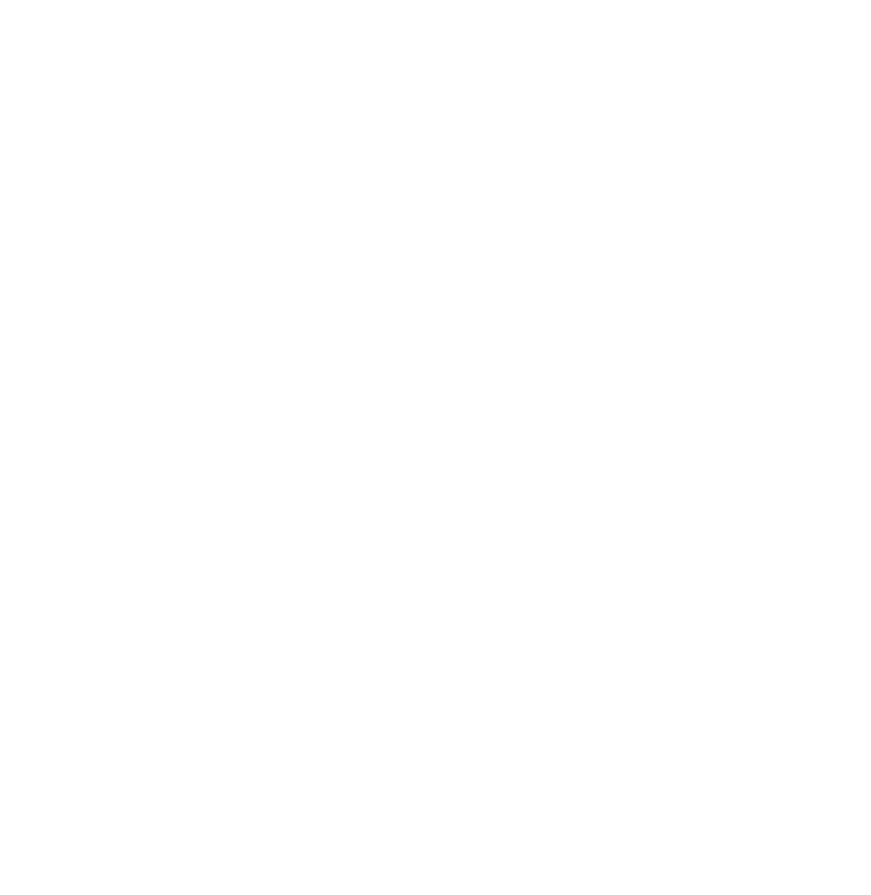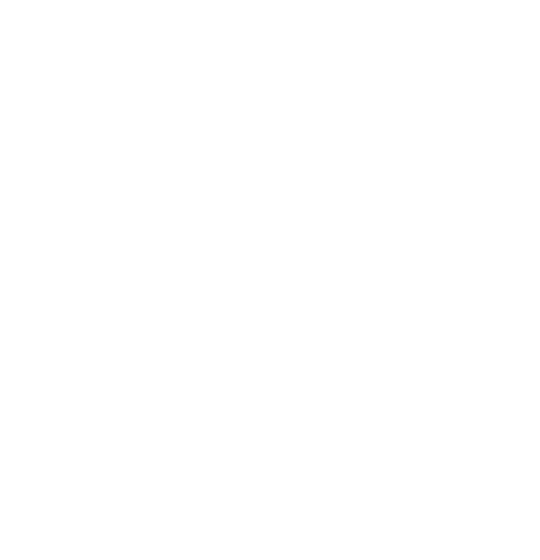«Nelle tante telefonate che ci siamo fatti in questi 22 mesi, molte volte ci siamo augurati di poterci a incontrare alla fine della guerra a Gaza o a Roma, ma non avrei mai pensato di incontrarci qui, in questo ospedale». Suhail Abu Dawod, 19 anni, ci guarda sorpreso dal suo letto in ospedale, con i suoi occhi grandi e spalancati, attaccato a decine di tubi e tubicini. Giovedì, durante l’attacco israeliano alla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, è rimasto gravemente ferito dalle molte schegge che gli sono entrate in varie parti del corpo.
Le stesse schegge che hanno ucciso i tre parrocchiani ricordati ieri all’Angelus da Papa Leone. Poco dopo l’inizio della guerra, il parroco padre Gabriel Romanelli ci fece conoscere Suhail. Era tra i più bravi della scuola, ci disse, si era maturato con voti altissimi, era attivissimo in parrocchia, e aveva confidato a padre Gabriel di voler continuare i suoi studi nella teologia per poter intraprendere la via del sacerdozio. E poi scriveva bene. In inglese. Ci mandò un primo pezzo in cui descriveva la quotidianità dei 600 cristiani sfollati dalle loro case bombardate e asserragliati dentro le mura del compound della parrocchia.
Quel pezzo piacque molto, per cui ne seguì un secondo, poi un terzo, e così diventò una rubrica: “Vi scrivo da Gaza”. Piaceva lo stile di questo ragazzo che sapeva rimanere sempre positivo, sempre speranzoso, sempre mite, pur scrivendo sotto le bombe. Se non fosse che quando lo chiamavamo al telefono potevamo sentire distintamente il rumore delle esplosioni intorno alla parrocchia, avremmo potuto immaginare che si trovasse in un oasi di pace. Quando lo raggiungiamo in ospedale, ci informiamo subito sulle sue condizioni di salute. «Oggi va meglio — ci spiega —. Ieri sono stato operato. Un’operazione lunga, c’erano molte schegge dentro la mia pancia da togliere. Poi ce n’era una molto grande nella schiena, e una nella gamba destra. Prima di operarmi il dolore era insostenibile e ho perso molto sangue, ma non ho mai perso conoscenza.
Dopo l’esplosione, i primi due a soccorrermi sono stati padre Gabriel e padre Yousef, poi è arrivata mia madre». La mamma, Randa, è uscita con lui da Gaza e ora gli è accanto con uno sguardo tenerissimo. Non capisce cosa stiamo dicendo in inglese, ma sorride contenta di vedere Suhail parlare con i suoi amici che vengono da lontano. Gli mostriamo i ritagli di tanti giornali che parlano di lui. «Ma io preferisco scriverci sul giornale piuttosto che essere la notizia. Ricordi l’ultimo articolo che ho scritto per “L’Osservatore Romano”? Ricordi come finiva? L’amore è più forte della guerra». E ce lo ripete due volte in italiano. «Non vedo l’ora di poter ricominciare a scrivere per “L’Osservatore Romano”». Sono anche altri i suoi desideri per quando sarà guarito. «Due cose. Vorrei poter venire a studiare a Roma, per iniziare la formazione necessaria per seguire la mia vocazione. E ora vorrei avere accanto a me mio padre, mio fratello e mia sorella, che sono rimasti a Gaza. Spero di riabbracciarli presto, e vorrei che li conosceste anche voi».
Non vogliamo affaticarlo, ma gli proponiamo, se si sente, due videochiamate: una è per un prete, suo carissimo amico, che è a Roma ma che ha conosciuto a Gaza, e l’altra è con padre Romanelli. Con entrambi si commuove, e gli occhi gli si inumidiscono. Uscendo dall’ospedale, prima di tornare a Gerusalemme, volgiamo lo sguardo verso sud: Gaza è solo a pochi chilometri da qui. E ripensiamo ancora alla chiusa di Suhail: è vero, l’amore è più forte della guerra. E non c’è dubbio: vincerà.
Roberto Cetera su L'Osservatore Romano