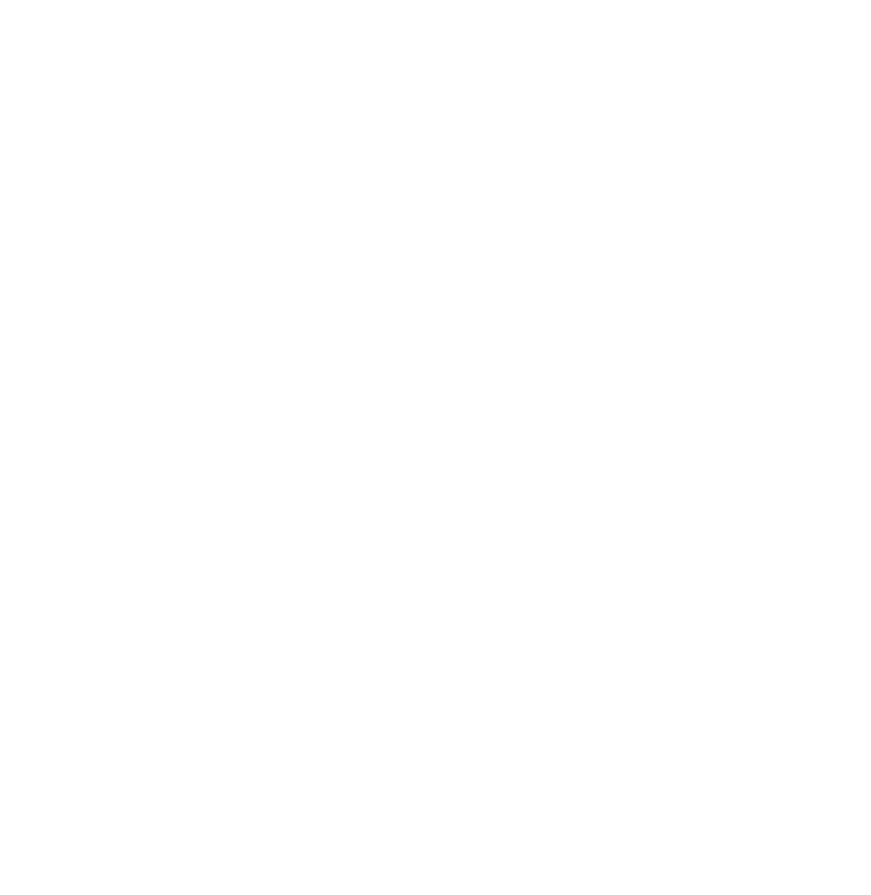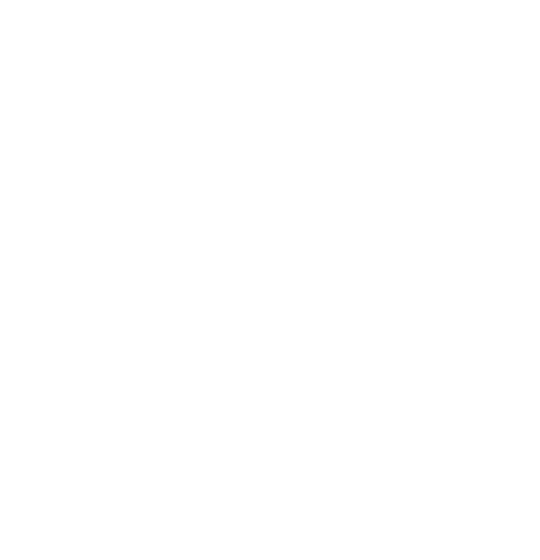di José Manuel Vidal
Primo laico nominato prefetto di un dicastero vaticano nel 2018, Paolo Ruffini (Palermo, 1956) è lo "zar della comunicazione" del Vaticano, ma non si vanta di ciò, consapevole che il Giubileo "sfida noi giornalisti a un esame di coscienza e ci obbliga a un atto di umiltà".
Dopo una lunga esperienza nel giornalismo, Ruffini afferma, nel giorno di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che la comunicazione vaticana è (o cerca di essere) uno "strumento al servizio della comunione ecclesiale" e una "piattaforma di condivisione", seguendo la dinamica comunicativa del Papa, basata sulla "prossimità", ma senza "cedere a chi semina divisione, odio, fake news, veleno".
Crede anche che un buon professionista dell’informazione religiosa abbia il dovere di fare domande scomode, di portare alla luce ciò che non va. In altre parole, ha il dovere di indagare, denunciare situazioni di ingiustizia, corruzione e abusi, anche all'interno della Chiesa. Ma anche il dovere di non rimanere prigioniero della narrazione del male. Tutto questo, evitando di cadere nella trappola dell’interpretazione ideologica, dello spirito di divisione e della ricerca facile di capri espiatori, spiega il prefetto curiale, forte di una vita dedicata all’informazione religiosa.
Cosa dice il Giubileo ai professionisti dell’informazione religiosa?
Ci dice che possiamo e dobbiamo sperare e costruire una comunicazione migliore attraverso questa stessa speranza. Ci dice che una comunicazione fondata sulla condivisione autentica della verità, e sulla capacità di vedere le cose nella loro interezza, nella prospettiva della salvezza, è il terreno fertile da seminare. Ci dice che noi stessi siamo la speranza di un futuro migliore. Ma anche che dobbiamo riscoprire il senso più bello e profondo della comunicazione: la fiducia nell'altro, il dono di sé, la relazione. Il Giubileo ci sfida a un esame di coscienza. E ci obbliga a un atto di umiltà. Ci parla dell'importanza dei giornalisti, dei comunicatori, della loro vocazione, del ruolo essenziale che hanno – che abbiamo – nel coltivare la memoria e dare significato a ogni narrazione. Ma ci ricorda anche che la comunicazione riguarda tutti. Papa Francesco ci chiede di essere testimoni e promotori di una comunicazione di speranza, capace di curare le ferite dell’umanità di oggi, costruendo ponti dove troviamo muri.
Un punto fondamentale, secondo Ruffini, è l’invito del Papa a raccontare storie di bene e a raccontare bene anche il male, senza lasciarsi affascinare e intrappolare da esso; a innescare dinamiche di bene; a superare l’indifferenza verso i più deboli, gli «scartati». Troppo spesso, l’indifferenza sembra dominare il mondo di oggi, persino nell’informazione.
Come giudica la comunicazione del Vaticano?
La nostra missione, in un mondo oscurato e diviso, è tessere una rete di bene. Siamo Chiesa, al servizio del Papa nel suo servizio a tutta la Chiesa. Non si può comprendere il Dicastero per la Comunicazione senza considerare la natura missionaria della Chiesa e la riforma della Curia romana, a cui il Papa ha chiesto una conversione sinodale, pastorale e missionaria. Dal 2015, anno della creazione del Dicastero per la Comunicazione, abbiamo imparato che la comunicazione funziona se è intessuta di relazioni, se riesce a generare dinamiche di bene, se non si riduce a una mera trasmissione di informazioni, ma costruisce un protagonismo collettivo. Questo è la comunione. Non possiamo trincerarci nel paradigma «Roma locuta est». Né possiamo cedere a chi semina divisione, odio, fake news, veleno.
La comunicazione non è una sovrastruttura. Ancora meno può esserlo nella Chiesa...
La nostra vuole essere una comunicazione di servizio. Un servizio, prima di tutto, alla Chiesa e al Papa. Mi piace pensare che la comunicazione "mediatica" vaticana sia percepita come uno strumento al servizio della comunione ecclesiale e della cultura dell’incontro nel mondo. Una piattaforma di condivisione. Papa Francesco lo ha detto più volte: il principio che deve guidare i media della Santa Sede è il principio missionario: per questo, i media vaticani parlano oggi più di 50 lingue – inclusa la lingua dei segni – e sviluppano la loro informazione attraverso tutti i mezzi offerti dalle nuove tecnologie. In questo Giubileo vogliamo essere un grande spazio di speranza, capace di accogliere le esperienze di tanti comunicatori nel mondo impegnati per un futuro migliore.
Quali sono le virtù comunicative che fanno sì che il Papa rompa gli schemi anche in questo campo?
Anche nella comunicazione, Papa Francesco si concentra sulle relazioni umane. La sua non è una comunicazione studiata a tavolino, né una strategia di marketing. È una comunicazione profondamente relazionale. Al centro della sua comunicazione c’è sempre la persona. Questa capacità innata di entrare in relazione con gli altri, chiunque essi siano, e di trasmettere messaggi significativi per tutti – credenti e non credenti – fa di lui un comunicatore straordinario. A ciò si aggiungono il suo coraggio, la sua creatività, virtù innate che gli permettono di rompere gli schemi e arrivare direttamente al cuore della gente.
Giornalismo: servizio o business?
Negli ultimi anni, gli interessi economici sono diventati sempre più dominanti nel sistema dell'informazione. La competizione per attirare nuovo pubblico ha purtroppo spinto molti media a concentrarsi su contenuti sensazionalistici e polarizzanti a scapito della qualità e dell'informazione. E soprattutto della verità. Il Papa stesso ci ha spesso ricordato che un'informazione libera, professionale e non ideologizzata è un bene per le società e un pilastro del sistema democratico di un Paese. Sono certo che questo Giubileo della Comunicazione ci aiuterà anche a riflettere sull'importanza di un'informazione di qualità, sul ruolo imprescindibile dei professionisti e su come tutti noi - non solo i professionisti - siamo chiamati a essere testimoni della verità, tessitori di comunione. E su quanto bene possano fare i media che si concentrano sui fatti e sulle persone, piuttosto che sulle strumentalizzazioni e sulle opinioni stereotipate.
Il mondo di oggi può morire di sovraccarico di informazioni?
Certamente, questo è uno dei grandi problemi del mondo di oggi, non solo del sistema informativo. Oggi siamo letteralmente immersi in un oceano di dati, informazioni e notizie che spesso si rivelano fake news. Con l'accesso a una quantità quasi illimitata di notizie attraverso internet e i social media, le persone sono costantemente bombardate da informazioni di cui a malapena comprendono il significato. Uno dei rischi che corriamo, quindi, è di sapere molto più di prima ma di non capirne il significato, di non sapere più come interpretare la realtà. Ancora una volta, abbiamo bisogno di media che possano offrire un valore aggiunto al pubblico, alle comunità. Credo che anche se molti pensano che il giornalismo possa essere sostituito dalle nuove tecnologie, a partire dall'intelligenza artificiale, ci sarà sempre bisogno di giornalisti che, consumando le suole delle loro scarpe come ha detto lui, raccontino la vita delle persone e dei popoli. Sanno vedere il cuore delle persone, l'essenza delle cose.
La missione di un buon giornalista è denunciare ciò che non va (anche nella Chiesa) e proporre soluzioni?
Certo che sì. Un buon giornalista ha il dovere di indagare, di denunciare le situazioni di ingiustizia, corruzione e abuso, anche all'interno della Chiesa. Ma ha anche il dovere di non rimanere imprigionato nella storia del male. Perché il male non ha già vinto. Ci sono sempre prospettive di bene. Il giornalismo delle soluzioni ci sfida a cercarlo. Ricordo che in più di un'occasione Papa Francesco ha ringraziato i giornalisti che avevano ascoltato le vittime di abusi e portato così alla luce scandali e violazioni troppo a lungo insabbiati. E molte volte ci ha anche chiesto di non fermarci a una narrazione superficiale, ma di scavare più a fondo, di vedere con il cuore. Quindi, sì, il giornalista ha il dovere di fare domande scomode, di denunciare ciò che non va. Penso che un giornalista, soprattutto se credente, abbia anche il dovere di provocare un dibattito pubblico. Non fermarsi alla denuncia, ma provocare anche un dibattito su questioni rilevanti per la vita della società e della Chiesa.
Abbiamo bisogno di un giornalismo più professionale (basato sui fatti) e meno ideologico (basato sulle opinioni) anche nell'informazione religiosa?
Non c'è dubbio. È fondamentale che il giornalismo, e questo vale anche per l'informazione religiosa, si basi su fatti verificabili e informazioni veritiere, evitando, come dicevo prima, di cadere nella trappola dell'interpretazione ideologica, dello spirito di divisione, della facile ricerca di capri espiatori. Mi piace ricordare quanto detto da Papa Francesco nell'incontro con gli operatori dei media il 17 marzo 2013, subito dopo la sua elezione: “Gli eventi ecclesiali rispondono a una logica che non è principalmente quella delle categorie, per così dire, mondane, e proprio per questo non è facile interpretarli e comunicarli a un pubblico vasto e variegato. La Chiesa, infatti, pur essendo certamente anche un'istituzione umana, storica, con tutto ciò che questo comporta, non è di natura politica, ma essenzialmente spirituale: è il “Popolo di Dio”. Credo che queste parole del Papa, pronunciate dodici anni fa, siano più che mai attuali, anche oggi, per aiutare a capire lo stile, l'approccio e la prospettiva che devono caratterizzare il lavoro di un giornalista che si occupa di informazione religiosa.