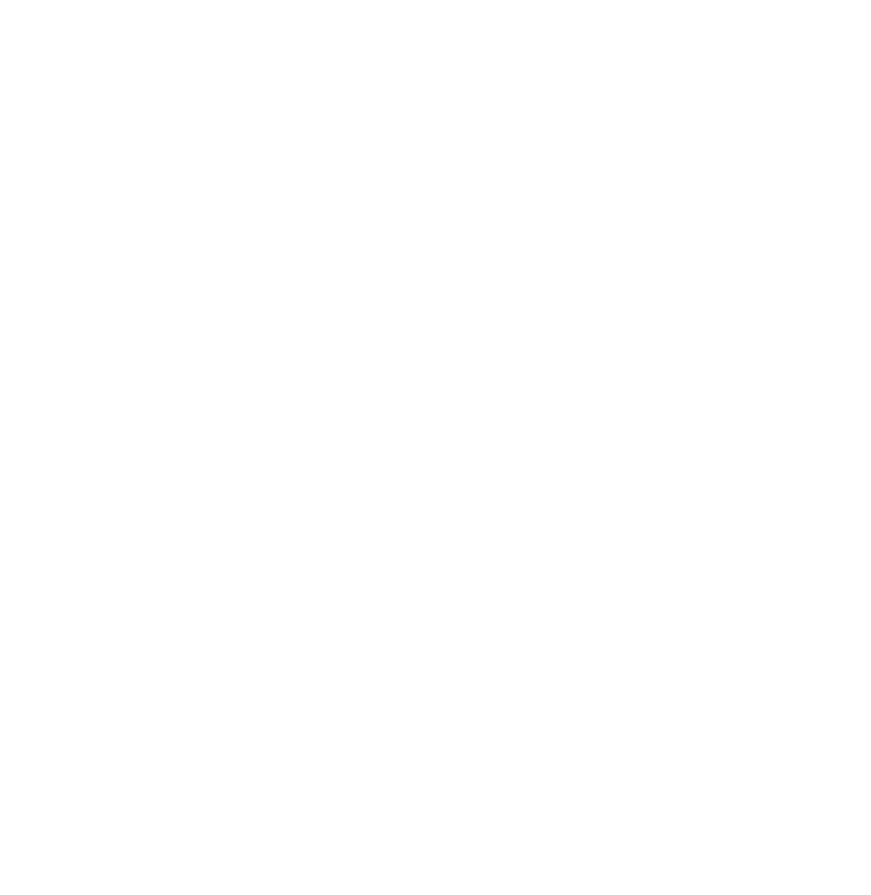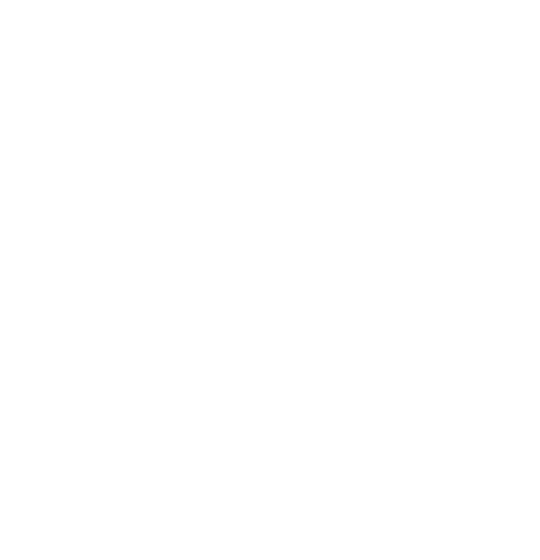Insieme con Gesù, non come salvatori ma come salvati
Omelia nella festa dei santi apostoli Simone e Giuda Plenaria del Dicastero per la Comunicazione
Il racconto del santo vangelo che abbiamo appena ascoltato (cf. Lc 6,12-19) ci ha riferito anzitutto di una chiamata fatta da Gesù e, quindi, di una missione conferita a quelli che aveva convocato; prima ancora, però, ci ha riferito che egli «se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio». C’è poi un secondo atto, che vede la presenza di due gruppi: un gran numero di discepoli e una moltitudine che giunge dalla Giudea e da città pagane. Tutti cercano di toccare Gesù e sono, a loro volta, come investiti in forma tangibile dalla sua misericordia. Il testo oggi proclamato si ferma qui; noi sappiamo, però, che subito dopo Gesù proclamerà le Beatitudini nelle quali, come scrive Papa Francesco, «si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita» (Gaudete et exsultate, n. 63). Penso che tutti questi elementi siano particolarmente illuminanti per un’assemblea che, come la nostra, in questi giorni sta riflettendo sul tema di una comunicazione costitutivamente sinodale.
La proclamazione delle Beatitudini, infatti, è un annuncio. Ritengo, anzi, che sia ancora di più. Penso che sia un’esortazione e pure un comando. Nella sua traduzione francese del Nuovo Testamento, André Chouraqui, un autore di origine ebraica, rende il «beati» con En marche! «Orsù, alzatevi e mettetevi in cammino»! Prima ancora di proclamare la Beatitudini, però, c’è qualcos’altro che Gesù comincia a comunicare. Non è una parola, ma una forza, un vigore sanante: «da lui usciva una forza che guariva tutti». Prima ancora che parole, Gesù comunica gesti che danno forza, speranza. È il suo stile! Gesù prima opera, quindi parla. All’inizio degli Atti leggiamo, infatti, che egli cominciò con il fare e quindi con l’insegnamento: coepit facere et docere. Vi accennava il Papa sabato sera, nel discorso di conclusione dell’assemblea sinodale.
San Gregorio Magno ne trasse un principio d’azione: «insegna con autorità chi prima fa e poi dice, perché se la coscienza tradisce la parola allora ogni insegnamento perde di credibilità» (Moralia XXXIII, 24: PL 76, 265). Con un abile gioco di parole Isacco della Stella dirà che il doctor è anzitutto un ductor, ossia uno che accompagna, che guida con l’esempio della propria vita: «Doctor autem et ductor noster Jesus Christus ea docet quae facit» (cf. Serm. XXX: PL 194, 1788).
Sorge, allora, una domanda: noi, che tipo di comunicazione siamo oggi chiamati a fare? La nostra comunicazione, da dove comincia? Dalle parole, o dalle opere? Mi torna alla memoria quel che si legge in un testo del II secolo, conosciuto come Lettera a Diogneto. Qui si legge che i discepoli di Gesù non si segnalavano per quello che dicevano, ma per quel che facevano. «Pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa…» (cf. Cap. 5-6; Funk 1, 317-321).
C’è, però, un’altra cosa che, a commento della pagina di vangelo che abbiamo ascoltato, desidero condividere. All’inizio si legge: «Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio». Perché lo fece e dove? Possiamo senz’altro pensare ad un’altura determinata; c’è il fatto, però, che nella tradizione biblica la montagna è il luogo per eccellenza per l’incontro con Dio. «Sale colui che cerca Dio, sale colui che chiede insistentemente l’aiuto di Dio per il proprio cammino», scrive sant’Ambrogio (cf. Exp. Ev. sec. Lucam V, 41: PL 15, 1647).
Stette lì una notte intera per pregare! Ma perché? Qual era la questione da risolvere? Sta il fatto che nel dialogo con il Padre Gesù comprende che per potere adempiere la sua missione ha bisogno di una com-pagnia, ha bisogno di altri che mangino con lui lo stesso pane, che siano suoi compagni e amici. Per questo si legge che Gesù non chiama semplicemente, ma chiama-a-sé. Pros-ephonesen, dice il testo greco, ricorrendo così a un verbo che, nel nostro caso, indica una comunicazione diretta, che addirittura ha il carattere di urgenza sicché essa è pure un convocare chiamando per nome, lo stabilire così, subito, una relazione, un contatto, un rapporto a tu per tu, in un «noi».
Gesù vuole che i suoi missionari siano suoi amici, suoi confidenti, suoi commensali e amici fra loro. Non sceglie delle persone perfette, ineccepibili, omologate. I dodici apostoli, sono, anzi, persone molto diverse l’una dall’altra; talvolta contrastanti! C’è Simon Pietro, che è alquanto impetuoso, ma pure facile a impaurirsi; veementi erano pure Giacomo e Giovanni, («Boanèrghes, cioè figli del tuono», Mc 3,17), ma anche un po’ ambiziosi (cf. Mc 10,55). Simone, l’apostolo che oggi celebriamo insieme con Giuda-Taddeo, è chiamato «zelota» ed forse è un titolo allusivo: ma… come andar d’accordo con Matteo, che, essendo stato al servizio del potere romano, aveva una storia del tutto opposta? Tommaso è uno che ha bisogno di vedere per credere; un po’ diverso da Filippo e Bartolomeo (si tratta di Natanaele?), che sono indicati come uomini semplici e sinceri; poi c’è Giuda, che divenne il traditore: come mai gli fu affidata una funzione che sarebbe stata più adatta per Matteo? Gesù, però, convoca a sé queste diversità e lo fa a suo rischio personale. Sarà per loro soltanto un trait-d’union? No. Ben di più e loro dovranno imparare a sintonizzare con Gesù le loro diversità. Alla fine sarà lo Spirito a essere la loro «armonia», come ama ripetere Papa Francesco alludendo a san Basilio (cf. De Spiritu Sancto XVI, 38: PG 32, 140).
Così è oggi anche per noi. Il racconto del vangelo dice che con loro Gesù discese dal monte e dunque andò incontro a tutti quello «erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti» proprio con quelle diversità. È così anche oggi. Ai tanti, uomini e donne, che sentono (magari anche non sapendolo) il desiderio di lui, Gesù vuole andare incontro insieme con noi. È questa una radicale sinodalità: andare incontro agli altri non come dei salvatori, ma come dei salvati; andarci con la nostra vita, ossia pure con la nostra simpatia e la nostra fraternità, prima ancora che con le parole.
Nella Regola non bollata, ai suoi frati missionari tra le genti Francesco d’Assisi diceva: anzitutto, quando vi andate, state in mezzo a loro senza fare liti o dispute, rispettosi verso tutti e testimoniate d’essere cristiani; quando, poi, piacerà al Signore, annunziate loro la parola di Dio perché credano in Dio (cf. XVI, 5-7: FF 43). Pensate sia un buon metodo di «comunicazione costitutivamente sinodale»?
Basilica Vaticana-Altare della Cattedra, 28 ottobre 2024
Marcello Card. Semeraro