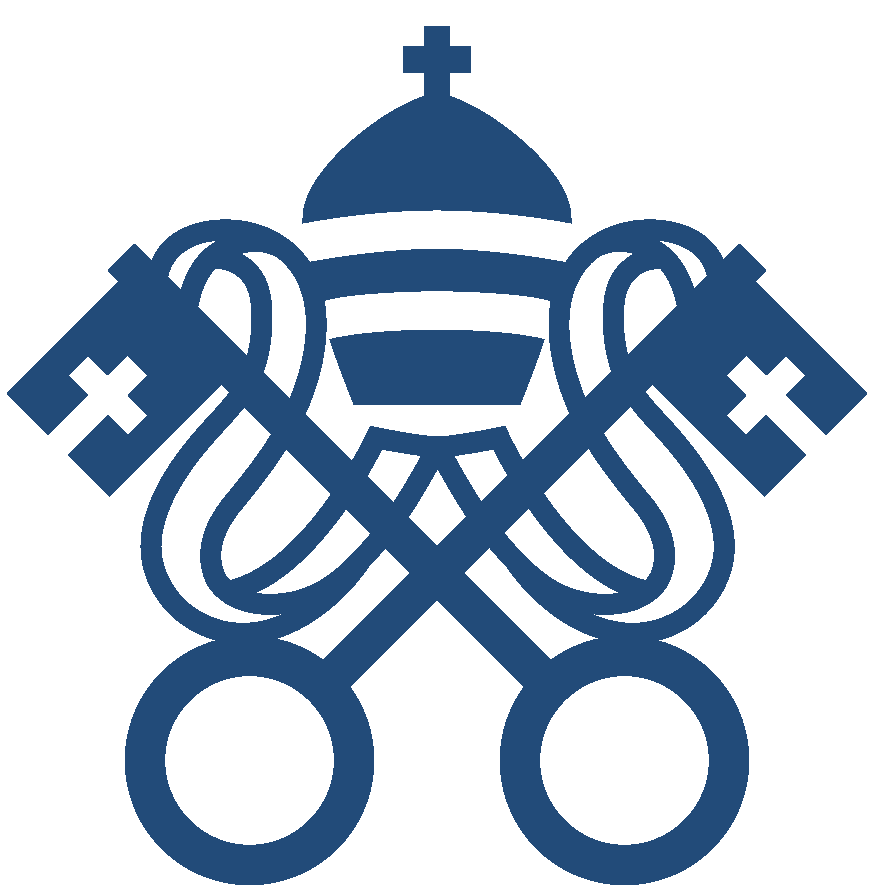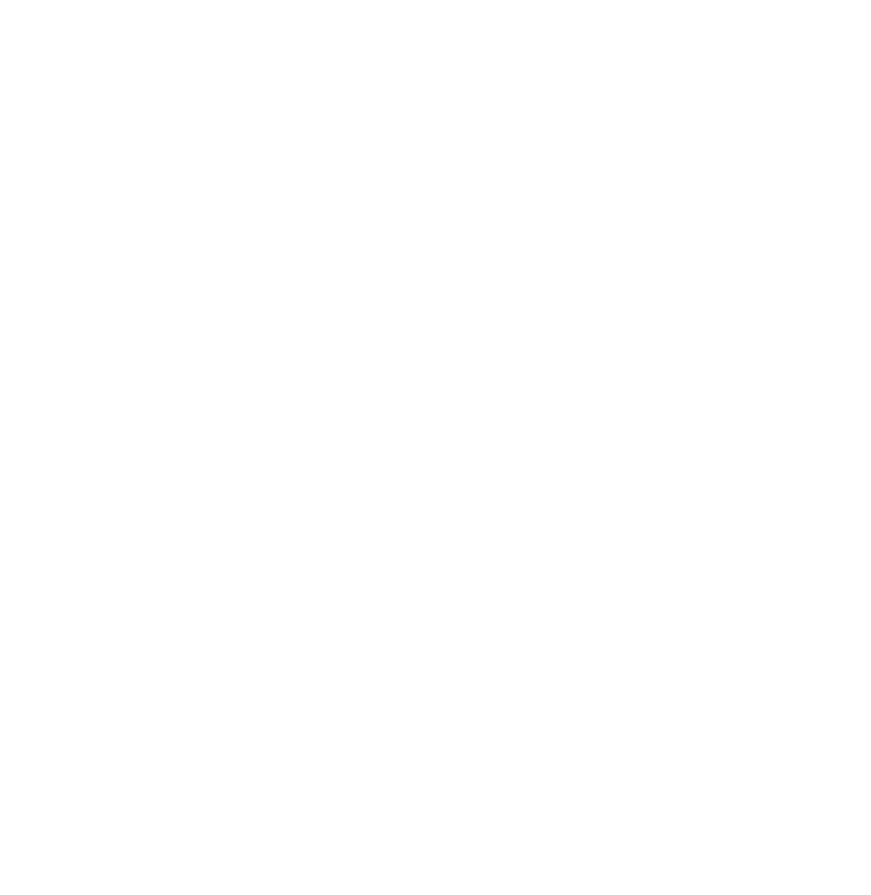di Alessandro Zaccuri
Anziché come condottiero, il Messia si manifesta in Gesù come narratore. Ma proprio per questo, e non a dispetto di questo, la sua azione liberatrice è ancora più profonda. Ogni racconto, infatti, ha in sé una dimensione politica, troppo spesso trascurata da chi preferisce pensare alla comunicazione e più specificamente alla letteratura come a un’abilità tecnica in sé inerte: come a qualcosa che subentra a battaglia terminata, per restare in ambito bellico. Alcuni combattono, altri — dopo che le armi sono state deposte — raccontano com’è andata.
Non è così o, almeno, non è così semplice. Le storie interpretano la realtà, anzitutto, e già questo basterebbe per comprendere che nessuna storia è mai del tutto irrilevante o innocente. I racconti di cui oggi più che mai ci nutriamo in forme e con modalità disparate (i film e i romanzi, le serie tv e le graphic novel, l’epopea collettiva della cronaca giornalistica e il controcanto talvolta caotico delle reti sociali) hanno un ruolo determinante nel delineare le nostre aspettative e nel permetterci di rielaborare le nostre esperienze non soltanto nell’ambito privato delle relazioni affettive, ma anche e forse specialmente nel contesto più ampio della convivenza sociale: persuadendoci, per esempio, che una certa scelta è giusta e un’altra sbagliata, che un determinato comportamento è eticamente fondato e un altro condannabile.
Già a questo livello, che potremmo definire del consumo di storie, si rende evidente la dimensione performativa del racconto sulla quale giustamente insiste Papa Francesco nel Messaggio per la cinquantaquattresima giornata per le comunicazioni sociali. A ben vedere, del resto, anche la citazione scelta come titolo del documento è connotata politicamente: siamo nel libro dell’Esodo, nel pieno della sfida tra Mosè, che rivendica libertà per il popolo di Israele, e il Faraone, che quella libertà si ostina a negarla. Fin dal principio, nelle intenzioni del Signore, i «segni» che si stanno susseguendo (compreso quello terribile delle cavallette, di cui riferisce appunto il capitolo 10) non possono essere separati dal racconto che ne verrà fatto per fissarli nella memoria. Non c’è distinzione, se non in astratto, fra il gesto e la parola, tra la vicenda che accade e il ricordo che viene tramandato. Nella storia della salvezza tutto si compie «perché tu possa raccontare e fissare nella memoria». La parola biblica, «Storia di storie», è sempre parola efficace ed è proprio a partire da questa caratteristica che si compie l’incarnazione del Lògos, attraverso una rivelazione che — come sottolinea il Messaggio — diventa subito racconto.
Delle storie, però, non siamo solo ascoltatori o lettori. Ciascuno di noi è il narratore di sé stesso, proprio come lo è stato Gesù, che ha voluto esprimersi in parabole e nello stesso tempo si è consegnato alla memoria viva della comunità, dalla quale gli evangelisti hanno attinto per i loro resoconti. In questo senso non è esagerato affermare che il racconto è la lingua madre del cristianesimo, in virtù della quale ogni cristiano è chiamato a farsi testimone attraverso la narrazione. Compito non facile, in un mondo che ha fatto dello storytelling una risorsa sempre più diffusa e invadente. Le storie sono ovunque, lo abbiamo già osservato, e chiunque è in grado di produrre la propria storia o di intervenire su quelle degli altri. Lo si comprende bene leggendo il Messaggio del Papa, che non si rivolge solamente ai professionisti della comunicazione, che fino a pochi anni fa ne erano i destinatari esclusivi. Certo, la responsabilità del narratore rimane una caratteristica saliente di chi pratica il giornalismo oppure un’altra forma strutturata di racconto, ma sempre più rilevante, specie per quanto riguarda le «storie distruttive e provocatorie» dalle quali ci mette in guardia Francesco, è il ruolo dei tanti narratori inconsapevoli che intervengono nel web, contribuendo non di rado alla diffusione di notizie false e di narrazioni fuorvianti.
Non è qui in questione lo sviluppo della rete, che ha seguito e continua a seguire un andamento che trova la sua spiegazione più convincente proprio nel «bisogno di raccontarsi» dal quale muove la riflessione del Messaggio che stiamo commentando. L’acquisizione, istintiva per il credente, dell’essere umano come animale narrante non va però separata da quella, solo in apparenza più tradizionale, dello stesso essere umano come animale politico. Sono le storie, letteralmente, a fare indirizzare il corso della convivenza, ed è la storia che ogni popolo o nazione decide di raccontare — e di raccontarsi — a determinare scelte e comportamenti concreti. Lo si è visto nei mesi scorsi, nel pieno della pandemia, quando solidarietà e sottovalutazione, negazionismo e principio di prudenza sono stati diversamente declinati di Paese in Paese, con assoluta coerenza rispetto alle posizioni precedentemente espresse dai rispettivi Governi in carica.
«Le responsabilità cominciano nei sogni», sosteneva il poeta William Butler Yeats e anche il sogno è, a suo modo, una forma di racconto, forse la più intima e rivelatrice dei nostri desideri e delle nostre paure, del bene che possiamo fare e del male che occorre contrastare. Anche i sogni sono materia politica, dunque? In un certo senso sì, come confermare l’uso insistente della parola “sogno” nel dibattito pubblico degli ultimi decenni, a partire dal famoso — e troppo spesso manipolato o frainteso — I have a dream. Il punto è che nella Bibbia, come il reverendo Martin Luther King sapeva bene, il sogno è indicazione di un compito, non espressione di un desiderio. Si viene visitati dal sogno così come un narratore è visitato da quella peculiare forma di intuizione alla quale, per molti secoli, abbiamo dato il nome di ispirazione e che adesso cerchiamo di nascondere sotto una mole crescente di espedienti. La pretesa che il racconto non abbia in sé nulla di originario, ma sia il mero prodotto di un’oculata combinazione di elementi precostituiti è una delle insidie più preoccupanti del nostro tempo. Perché deresponsabilizza il narratore, in primo luogo, negando la sua efficacia nel momento stesso in cui finge di celebrarne il prestigio. E perché, dopo aver trasformato il racconto in bene disponibile, ne rende possibile l’utilizzo più spregiudicato. Questa, del resto, è stata per molto tempo una delle leggi non scritte della comunicazione: chi disprezza la letteratura è destinato a essere vittima della cattiva letteratura. Della quale, come si sarà ormai capito, avidamente si alimenta la cattiva politica.
Il Messaggio di quest’anno cade su un crinale irripetibile. L’emergenza coronavirus ha reso evidente quanto un racconto più o meno sincero, più o meno interessato oppure generoso, possa influire sulle sorti dell’intero pianeta. Tuttavia non va dimenticato il fatto che quest’anno fa da preludio al settimo centenario della morte di Dante Alighieri, che cadrà nel 2021. È a lui che è opportuno guardare, all’autore della più grande epica cristiana mai concepita, narratore e testimone nella massima accezione di entrambi i termini. Il lettore della Commedia è continuamente richiamato alla coincidenza tra il poetico e il politico: proprio perché è stata trasfigurata dall’evento della Risurrezione, la parola non può più sottrarsi al dovere di incidere sulla realtà, trasformandola a sua volta. Un narratore, in fondo, è sempre un profeta. Per questo non è mai disarmato.
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 24 settembre 2020)