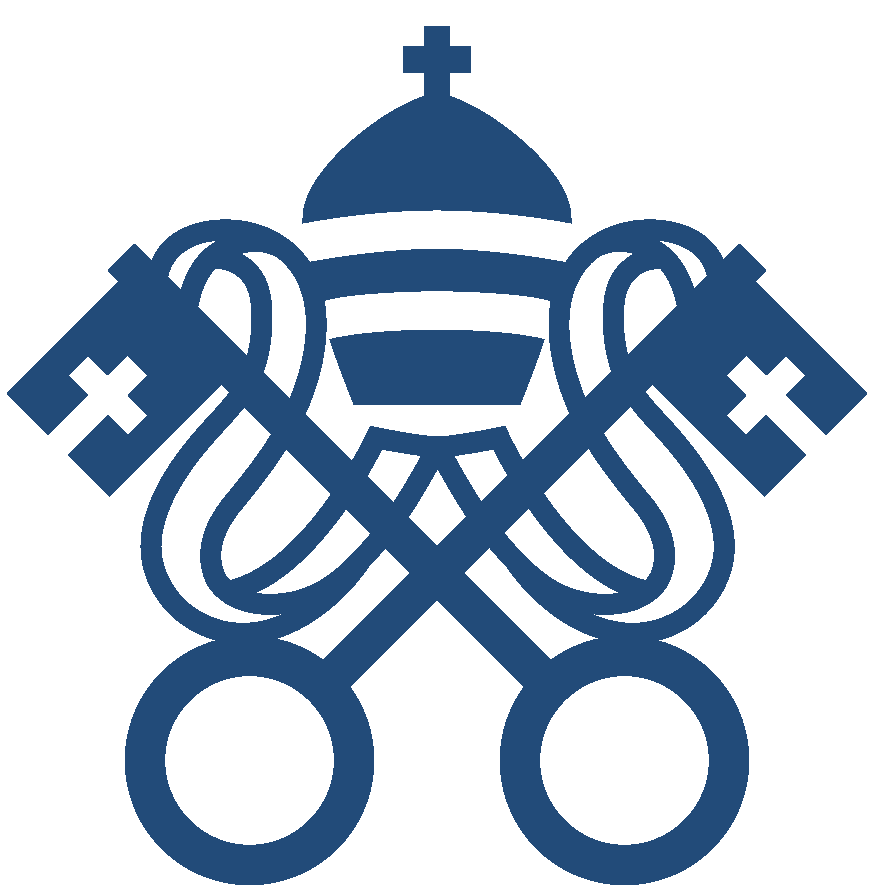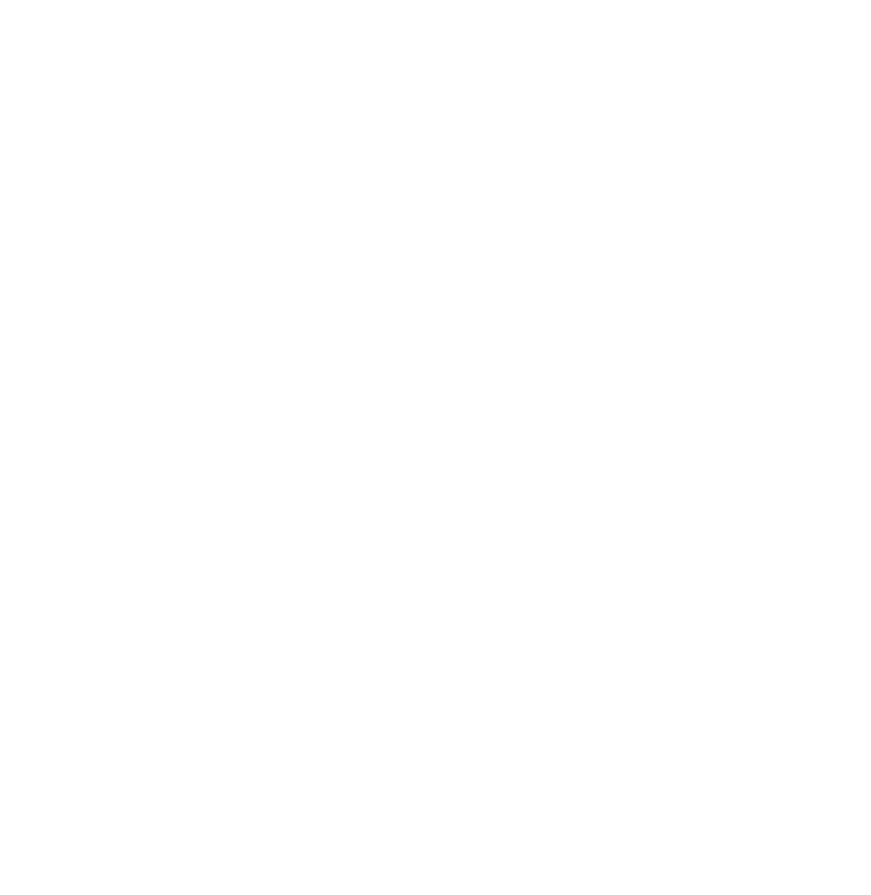di Piero Di Domenicantonio
L’azzurro del cielo, il verde dei vigneti, il bianco della calce sui trulli. Oggi sono i colori della Valle d’Itria a riempire gli occhi di Manoocher Deghati. Colori molto diversi da quelli che ha impresso sulla pellicola e scolpito nella sua memoria in più di quarant’anni di lavoro come fotoreporter per le più importanti agenzie giornalistiche internazionali: il rosso del sangue degli innocenti, il grigio scuro del fumo dei pozzi di petrolio incendiati nel deserto, il nero del buio della prigione delle donne condannate a morte.
Vincitore di due Word Press Photo, l’oscar del fotogiornalismo, Deghati ha iniziato la sua carriera durante la rivoluzione khomeinista in Iran, il Paese dove è nato 65 anni fa. Esule, è poi diventato cittadino del mondo per professione raccontando con le immagini le principali crisi degli ultimi decenni. Oggi vive in un grappolo di vecchi trulli tra Bari e Taranto che ha ristrutturato mescolando la cordialità e i profumi della campagna pugliese con la gentilezza e gli aromi della sua terra d’origine. «Qui mi sento a casa», racconta mentre offre agli ospiti una tazza di tè nero e zenzero e mostra la serie di rosari — «non tutti sono cristiani» spiega, indicandoli accanto alla porta del studio — che ha raccolto durante i suoi innumerevoli viaggi: dall’Afghanistan all’Egitto, dal Centroamerica a Sarajevo, dall’Iraq alla Palestina... come indicano le targhette attaccate sulle grandi scatole di plastica che custodiscono l’archivio dei negativi e delle diapositive.
Deghati ha letto il messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali di quest’anno? Parla del bisogno di narrare, quindi parla anche di lei.
Sì, il messaggio del Papa coincide bene con la mia vita. Raccontare storie è la mia passione come fotogiornalista. Storie belle, ma anche storie tristi. In ogni caso storie vere, come lo sono le rivoluzioni, le guerre, i disastri naturali. La fotografia esiste da 150 anni, ma da sempre, come dice il Papa, l’uomo vive di narrazioni. All’inizio ci si ritrovava intorno a un fuoco. Poi si è iniziato a incidere graffiti sulle pareti delle grotte. Adesso abbiamo a disposizione mezzi che ci permettono di condividere le nostre immagini con milioni, miliardi di persone. Abbiamo una grande opportunità e dobbiamo saperla usare per suscitare la speranza, per incoraggiare reazioni positive anche se dobbiamo raccontare storie orribili. Non ha senso raccontare solo storie buone. Ma quando racconti storie cattive lo devi fare per denunciare la cattiveria.
Questa “passione” l’ha portata a rischiare la vita, come è avvenuto il 26 settembre 1996 a Ramallah quando, durante gli scontri tra palestinesi e militari israeliani, lei venne colpito gravemente da un cecchino.
Se fai il fotografo, per raccontare una storia devi essere nel cuore dell’azione. E questo ha il suo prezzo da pagare.
Come si racconta una storia con una fotografia?
Prima di tutto devi interessarti a quello che vuoi raccontare. Devi conoscere. Devi sapere perché vuoi raccontarla. Questa è la cosa più importante. Poi, puoi scegliere se farlo con una sola immagine oppure con una serie. Per il «National Geographic» mi è capitato di spendere due anni per due reportage in Turchia. Ho lavorato sul posto anche per più di un mese di fila per entrare nella realtà di quel Paese. Alla fine ho scattato quasi mille rullini — allora si contavano le pellicole! — e trenta fotografie sono state pubblicate. Per la France Presse o per l’Associated Press facevo foto di cronaca. Le mie energie erano perciò tutte dirette nel riuscire a scattare “la” foto, quella capace di contenere tutte le informazioni, tutti gli elementi necessari a far comprendere anche agli altri quello che stava accadendo davanti ai miei occhi. E per far passare un messaggio.
E qual è il suo messaggio?
Quando mi sono trovato in zone di guerra ho sempre sentito che il mio compito era quello di denunciare l’orrore della guerra. Perché io odio le guerre. Sentivo che questo era il mio dovere. E la fotografia è lo strumento più efficace per far passare questo messaggio. È un linguaggio universale che tutti possono capire. Non c’è bisogno di strumenti culturali particolari per comprendere un’immagine. Questa è la forza della fotografia.
Qual è il suo rapporto con le persone che fotografa?
La relazione con gli altri è molto importante. Non è che vai in un posto, alzi la fotocamera e fai click. Non funziona così. Devi sempre far capire quali sono le tue intenzioni. Se vuoi raccontare la loro storia in modo onesto vedrai che ti apriranno ogni porta. Molte volte, soprattutto nelle zone di guerra, mi è capitato di sentirmi dire: «Vai, fotografa! Fai vedere al mondo come stiamo soffrendo. Il tuo occhio è la nostra voce». E quando succede questo vuol dire che sei riuscito a fare qualcosa di veramente positivo.
Un fotografo di guerra può raccontare storie buone?
Sì, anche se deve raccontare il male. Perché quando fotografa è come se dicesse: «Questo è il male che non deve esistere». Se non ne fossi stato convinto non avrei fatto questo mestiere. Credo, e ho sempre creduto, che fotografare, raccontare storie, debba avere un ritorno positivo sulla società, debba suscitare il cambiamento.
Alcune sue foto hanno raggiunto questo obiettivo.
Qualche cosa si è mosso a livello internazionale quando su alcuni giornali sono comparse delle fotografie che mostravano le atrocità compiute da regimi autoritari. A quel punto nessuno poteva più dire di non sapere.
Come sta cambiando la sua professione?
I giornalisti, soprattutto i fotogiornalisti fanno paura al potere. Delle volte ci sparano. Altre volte ci arrestano. Ma il modo migliore per fermarci è stato quello di tagliare i fondi per l’informazione: senza soldi non puoi viaggiare, non puoi andare a vedere. È cominciato tutto più di venti anni fa, con una decisione editoriale presa a livello mondiale. Così oggi capita che un giovane che per esempio è stato in Siria rischiando la vita torni con delle fotografie incredibili che nessuno però vuole pubblicare. «Non abbiamo fondi», dicono. E poi ti accorgi che per un gossip pagano anche centomila euro. I soldi ci sono, ma non per la verità.
Anche gli smartphone e i social media hanno influito?
In tutto il mondo ho insegnato fotografia: dal Guatemala all’Afghanistan, dove ho fondato la prima scuola di fotogiornalismo aperta anche alle donne. Ho sempre pensato infatti che una storia possa essere raccontata meglio da chi la vive piuttosto che da noi, inviati, che abitiamo a New York o a Parigi e andiamo lì per una settimana. Oggi le cose stanno cambiando velocemente. La diffusione degli smartphone fa sì che dall’Amazzonia fino alle grandi capitali europee ci sia sempre qualcuno pronto a scattare una fotografia. Quando ho cominciato a lavorare, in tutto il mondo eravamo forse un centinaio di fotogiornalisti. Adesso abbiamo miliardi di fotografi. È incredibile. Non è più possibile nascondere qualcosa. Siamo tutti testimoni. E nel momento in cui condividiamo quelle immagini non siamo testimoni silenziosi. L’esempio più recente è l’uccisione di George Floyd a Minneapolis. Le immagini della sua morte non sono state fatte da un professionista. Eppure hanno avuto un effetto incredibile a livello planetario, mobilitando milioni di persone contro il razzismo. Questo è un buon esempio di come le immagini possono cambiare il mondo. E ora questo potere è nelle tasche di tutti.
Questa è la potenza delle immagini.
Anche la fotografia del Papa da solo in piazza San Pietro che prega per chiedere la liberazione del mondo dalla pandemia è di una potenza straordinaria. Perché non è un’immagine costruita, ma è la verità. In quella piazza fino a pochi giorni prima gremita di fedeli, il Papa ha voluto dire con forza “io sono qui. Anche se voi non potete venire, sono io con voi”. Questo è il messaggio.
L’avventurosa vita di Manoocher Deghati, fotoreporter di guerra sui fronti di tutto il mondo, non può essere rinchiusa in una fredda biografia. La moglie Ursula Janssen, archeologa e scrittrice, ha deciso perciò di raccontarla per quello che è: un romanzo nel quale le vicende personali si intrecciano con la storia di questi ultimi decenni. Ho visto è il titolo del libro disponibile su Amazon nella versione cartacea (11,99 euro) e in e-book (5,99 euro). Duecentoquarantanove pagine e 58 fotografie che parlano della passione del raccontare per immagini.
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 18 giugno 2020)