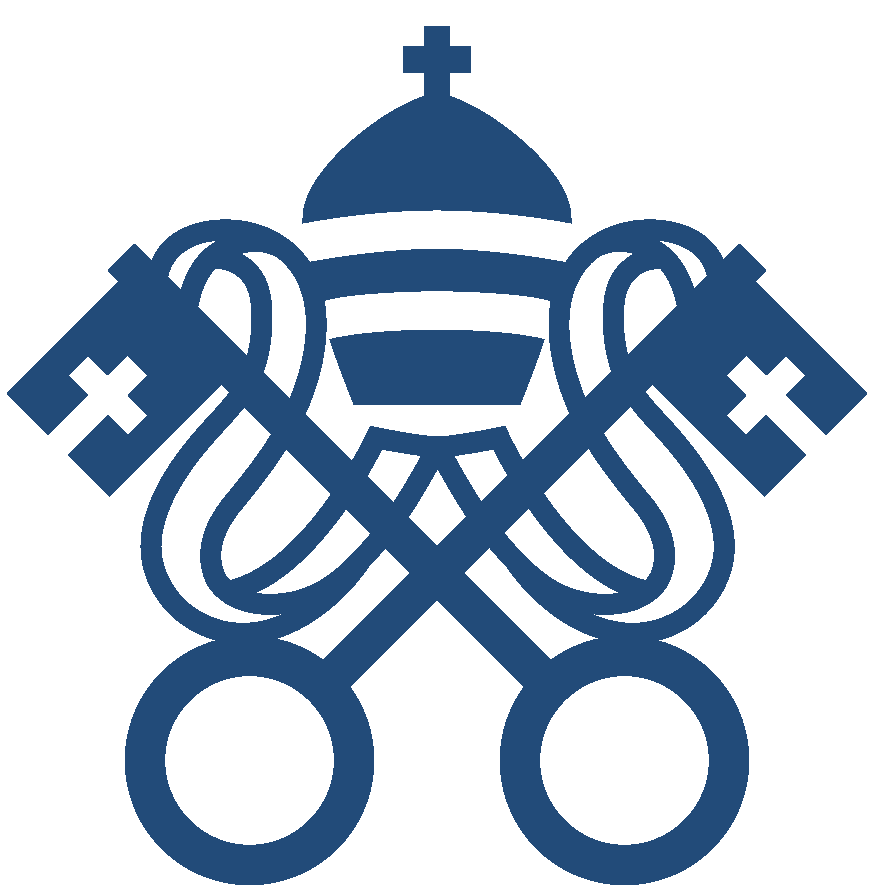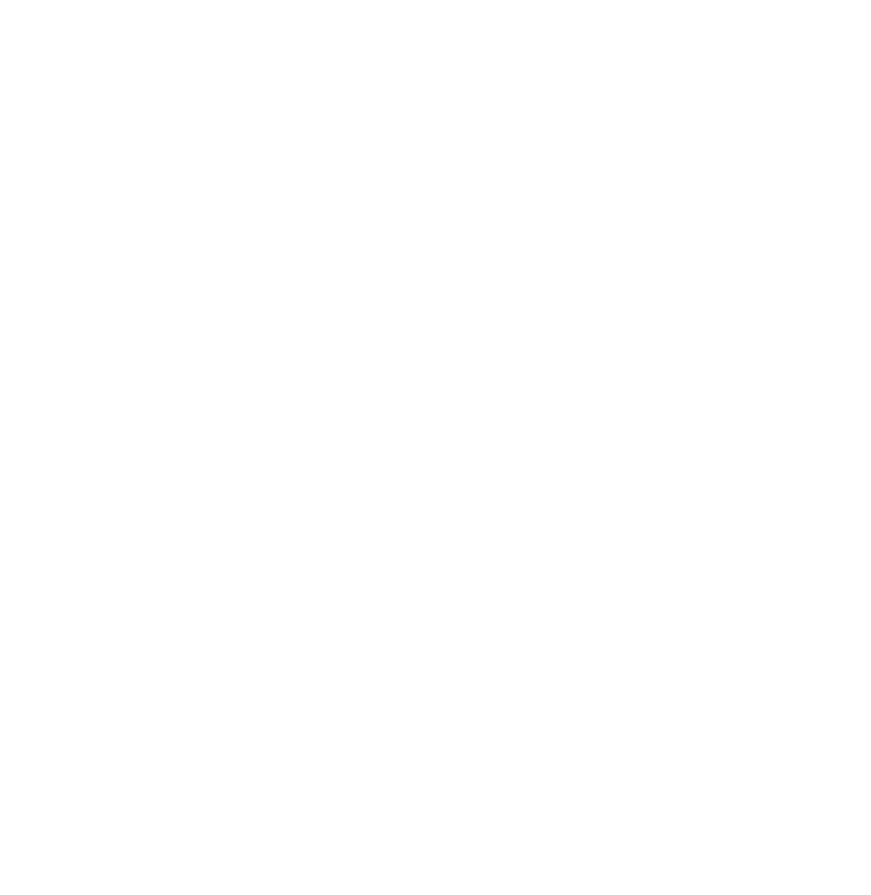di Marco Ronconi
«L’umanità merita racconti alla sua altezza», scrive il Papa nel suo Messaggio per la 54a Giornata per le comunicazioni sociali. Non sembri una domanda oziosa, ma qual è il livello di altezza dell’umanità? L’essere umano può sprofondare negli abissi di perdizione più profondi — lo ha fatto, lo ricordiamo e lo raccontiamo — oppure può innalzarsi ai cieli più alti. Ci sono casi di ascese e precipizi nella stessa biografia, nella stessa memoria, nello stesso racconto, pure tra quelli menzionati come esemplari dal Papa nel Messaggio, senza contare le moltissime vie di mezzo. Se «l’umanità merita racconti alla sua altezza», la questione degli strumenti di misurazione diventa seria. Il Papa, sempre nello stesso Messaggio, ne propone tre, anzi quattro perché l’ultimo è doppio: uno sguardo sapienziale sull’umanità; il coraggio di combattere il male e la menzogna; la pazienza e il discernimento per cucire le ferite e non confondersi. In realtà ce ne sarebbe un quinto, ma lo terrei per il finale.
La sapienza di riconoscere l’umanità
Per racconti all’altezza dell’umanità, occorre in primo luogo un tipo particolare di sguardo, quello che nella Bibbia è attribuito alla Sapienza. Ora cercherò di descriverlo, ma va premesso che si tratta di uno sguardo — un punto di vista — che si impara solo per contagio: si può vedere così, solo se si è stati visti così. Lo sguardo del sapiente è il contrario di quello dello stolto. La differenza tra i due non è nella quantità di cose che sanno, ma nell’uso che ne fanno. Esistono stolti eruditissimi, ad esempio, e sapienti illetterati. Il sapiente è tale perché, di fronte a un problema, lo vede per ciò che è e, se possibile, lo risolve con ciò che sa: può usare anche una teoria, ma non è l’unico strumento a sua disposizione. Lo stolto, al contrario, è troppo appesantito dalle sue dottrine e norme — il numero non importa — per trovarsi a suo agio nella vita, soprattutto quella che non si lascia incastrare nelle teorie e nelle abitudini. Il problema serio è che la vita è il luogo in cui ci è possibile incontrare Dio: per questo la Sapienza è gradita a Dio, che invece non sa proprio cosa fare con gli stolti. Se provassero a stare nella vita senza avere l’ossessione di controllarla, almeno, Dio potrebbe farli incontrare con la Sua grazia, ma gli stolti sono troppo impegnati a negarsi la sorpresa di un dono, a confondere il corretto con il bene, a giustificare e giustificarsi invece che vivere di misericordia, ricevuta e data. Tipo gli amici di Giobbe, per dire. I sapienti, invece, sono realisti, nel senso che accettano la realtà per quello che è e non per quello che dovrebbe essere: «vanità di vanità, tutto è vanità» o «nulla di nuovo sotto il sole» non sono il problema da risolvere, ma il luogo da abitare (anche «tuo padre era un arameo errante» e «io sono il Signore tuo Dio», a dire il vero, sono dati e non problemi, ma lasciamo stare). Dato che la realtà è ambigua e complessa, i sapienti, di preferenza, raccontano: «Meglio essere in due che uno solo (...) Infatti, se cadono, l’uno rialza l’altro» (Qoelet 4, 10). Non è né giusto né sbagliato, è semplicemente così. Nei racconti dei sapienti ci sono uomini giusti che diventano ciechi per il capriccio — anche un po’ umiliante — di uccelli sui rami, mali che si accaniscono su spose innocenti, pellegrini accompagnati da angeli… insomma c’è un po’ di tutto. Certo, di fronte alle realtà più spigolose, il sapiente combatte, si ribella, giudica, benedicendo e anche maledicendo. Se non può fare altro, anche definendo e insegnando. Ma non è mai l’unica possibilità, come per lo stolto. Di fronte alla realtà, a volte si può solo accettarne i misteri e limitarsi a nominarli: «Tre cose sono troppo ardue per me, anzi quattro che non comprendo affatto: la via dell’aquila nel cielo, la via del serpente sulla roccia, la via della nave nell’alto mare, la via dell’uomo in una giovane donna» (Proverbi 30, 18-19). Potrebbe essere l’esergo di una tetralogia di Thomas Mann, ma anche la battuta di un personaggio scombiccherato come quelli dei film di Radu Mihaileanu. Ti viene voglia di ascoltare che cosa sta prima di quella frase e come continua la vita di chi la pronuncia. Tornando allo stolto, egli pensa che, se Dio è entrato nella storia, occorre sviscerarne le modalità, farle proprie e mettersi in caccia dell’identico possibile, per fissarlo. Se Elia fosse stato così, sull’Oreb avrebbe riconosciuto Dio nel fuoco, molto più simile al roveto ardente apparso a Mosè, che in un mormorio di vento leggero. (Lo so, Elia era un profeta, non un sapiente in senso tecnico, ma chi di noi è una cosa sola?). I sapienti sanno che Dio è entrato nella storia e quindi scrutano i frutti maturi e il volo degli uccelli, le viscere della nascita e il rantolo della morte, non disdegnando una moneta o un bicchiere di vino, perché hanno udito il racconto dell’ingresso di Dio nella storia e sono disposti a scommettere che non è certo finita quel giorno, la storia. Anzi, ogni storia è diventata parte di quella di Dio e ad ascoltarle bene, se ne può sentire l’eco. Qualcuna si può addirittura raccontare. Intendiamoci bene, il sapiente non è un guardone; ha una vita da mandare avanti, ma ci sono alcuni casi in cui non può evitare di prendere la parola: se qualcuno ha bisogno, oppure se vuole alleggerirsi le tasche condividendo eredità. Il sapiente sa misurare l’altezza dell’umanità: è il luogo che Dio ha iniziato ad abitare e, per quanto ne sappiamo, non ha ancora smesso. Un racconto all’altezza dell’umanità ha come prima misura uno sguardo sapienziale.
Il coraggio del fallimento
Come distinguere un sapiente che racconta da uno stolto che vaneggia? Non è facile. In italiano, ad esempio, l’esclamazione «non raccontarmi storie!» detta da un amante ferito è esattamente la reazione che ognuno dovrebbe meritarsi quando pone la sua bocca al servizio degli empi. Nelle storie e nelle parole non c’è solo una luce che rivela, ma anche un’ombra che copre. A volte le ombre sono necessarie — non foss’altro per un tempo di riposo, che sempre vita è — ma altre volte diventano tenebre. Esiste cioè un modo di raccontare storie che lenisce senza curare, copre per soffocare e non per riscaldare, rimuove senza nessuna attenzione per le radici, e si potrebbe continuare. Papa Francesco parla del «coraggio di respingere i racconti falsi e malvagi». Come si riconoscono? È difficile perché si camuffano. Tutti noi, ad esempio, ci raccontiamo storie per alleggerire il peso del vivere. «Com’è andata oggi?», «bene»: è una storia; lunga solo due frasi, ma è una storia per lo più inverosimile, a prenderla alla lettera. Ripeterla ci aiuta, per questo lo facciamo. Ma non si può sempre. Viene il momento, vengono quegli occhi, viene quella lacrima o quel sorriso, viene quel vuoto e quel dolore, viene quel respiro profondo di vita che quando ti è chiesto «com’è andata oggi?» deglutisci e inizi: «Se hai dieci minuti, Ti racconto». E non è facile fare verità su di sé, figuriamoci sul mondo che è entrato a fare parte di noi. Figuriamoci sugli altri. Eppure i racconti all’altezza dell’umanità esigono questo coraggio. E solo chi ha sperimentato orecchie misericordiose che hanno vagliato la pula delle nostre parole, impara poi a riconoscere il sincero dal vero, il menzognero dal falso. Non diventa proprietario di qualcosa, ma distingue senza confondere, articola senza sovrapporre. Solo chi ha visto crollare cattedrali di storie che si è raccontato per rinviare la vita a un domani remoto, può sedersi accanto a un letto, una sera, e, davvero, obbedire alla richiesta: «Papà, mi racconti una storia?». Perché sa distinguere le storie che salvano, nel senso che permettono di vivere anche il sonno, da quelle che rivestono di tenebre i passi di ogni giorno. Davide raccontava storie meravigliose, tali da alleviare la follia di Saul, ma fu per una sua tremenda storia smascherata dal profeta Nathan, che perse tra lacrime impotenti il figlio di Betsabea, mentre restava il più grande re, dalla cui stirpe sarebbe nato il Messia. Davide fu un uomo capace di un coraggio all’altezza della vita che ebbe in sorte. Ecco la seconda misura.
La pazienza e il discernimento
L’ultimo strumento di misurazione sono due: la pazienza e il discernimento. C’è una parola greca che le raccoglie entrambe: macrothymia, ossia quella particolare virtù dell’agricoltore, in cui si miscelano pazienza, costanza, esperienza e speranza. È la perizia di chi legge i segni del tempo atmosferico e del terreno dissodato, della novità inaspettata e della tradizione ricevuta, rischiando per la sua parte, affidandosi dove non può fare altro, un passo alla volta. Pazienza e discernimento hanno il ritmo lento della terra e humus, non a caso, è radice comune a humanitas e humilitas. Alcuni padri latini, Leone Magno ad esempio, le usavano quasi come sinonimi, giocando sulla variazione di suono, perché i racconti sono anche questione di ritmo e di musica. A volte temo che solo gli stolti, poveri in humanitas, possano illudersi che l’humilitas sia una conquista ascetica. L’umiltà è semplicemente la nostra condizione di uomini: non siamo Dio, siamo fatti di terra, esposti alle intemperie, in grado di ospitare vita, generare frutti ed essere persino curati. Umiltà — oggi va molto di moda la variante «vulnerabilità» — è uno dei nomi dell’umanità. L’umiltà non è una conquista di nessuno perché la possediamo già tutti. La conquista, semmai, è la sua accettazione, per la quale servono tempo e uno sguardo plurale: servono cioè pazienza e discernimento, e il secondo non è mai una abilità individuale. La responsabilità è sempre personale, ma il discernimento può essere solo comune e, da quel poco che so di tradizione cristiana, mi sembra sia sempre stato così, salvo sprazzi di storia aridi di racconti sapienziali. Pazienza e discernimento sono il terzo (e il quarto) strumento. Ma c’è un ma, come in ogni narrazione che si rispetti, prima del finale.
La misura del Figlio di Dio
«Il Vangelo di Giovanni ci dice che il Narratore per eccellenza — il Verbo, la Parola — si è fatto narrazione: “Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha raccontato” (1, 18). Ho usato il termine “raccontato” — spiega il Papa — perché l’originale exeghésato può essere tradotto sia “rivelato” sia “raccontato”. Dio si è personalmente intessuto nella nostra umanità, dandoci così un nuovo modo di tessere le nostre storie. La storia di Cristo (…) ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la nostra carne, la nostra storia, fino a farsi uomo, carne e storia. Ci dice pure che non esistono storie umane insignificanti o piccole. (…) Ogni storia umana ha una dignità insopprimibile. Perciò l’umanità merita racconti che siano alla sua altezza, a quell’altezza vertiginosa e affascinante alla quale Gesù l’ha elevata». Dio ha elevato ogni storia umana facendo violenza non all’umano, ma al divino, dilatato fino alla discesa agli inferi. Dio ha assunto l’umanità per ciò che è e non per ciò che dovrebbe essere, fino alla morte. Lo ha fatto chiamando per nome gli uomini e le donne che ha incontrato, i luoghi in cui è vissuto, i tempi che ha trascorso; con il coraggio esemplare di distinguere il peccato dal peccatore, per non confondere e non confondersi. Lo ha fatto con la pazienza che ha imparato dal Padre, coinvolgendo nel suo discernimento anche coloro con cui ha condiviso la strada: «Donna, che vuoi da me?» (Giovanni 2, 4); «Credete che io possa fare questo?» (Matteo 9, 28); «E voi, chi dite che io sia?» (Luca 9, 20); «Simone, mi ami?» (Giovanni 21, 16); «Che cosa sono questi discorsi che state facendo?» (Luca 24, 17). Si è fatto carne perché la carne umana fosse capace di Dio. Si è fatto storia perché la storia umana fosse abitata da Dio. Si è fatto racconto perché l’umanità meritava racconti che fossero alla sua altezza.
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 2 luglio 2020)