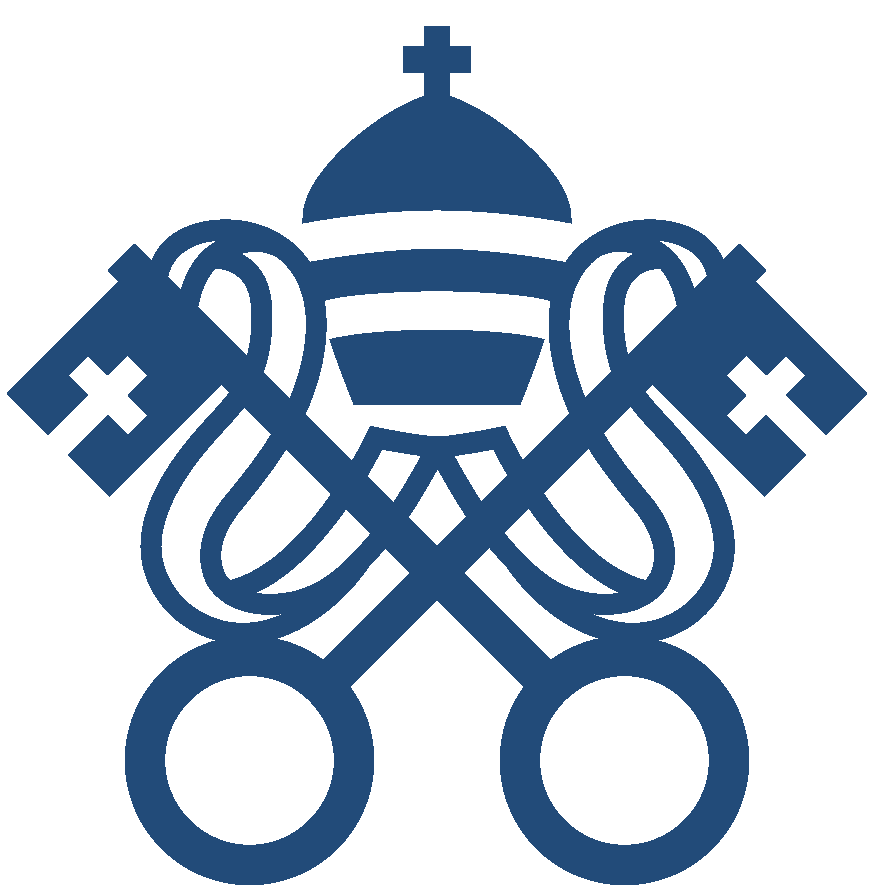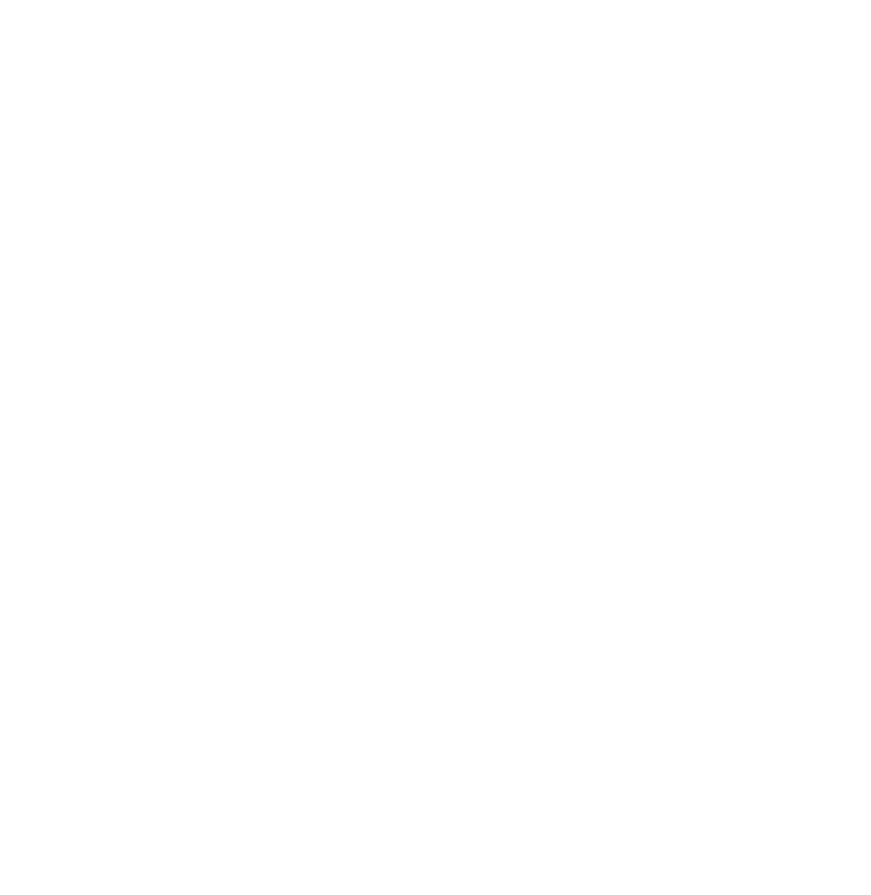di Mary Karr (da L'Osservatore Romano, mercoledì 25 marzo 2020)
[ Nata a Groves, Texas, nel 1955, è una scrittrice e poetessa pluripremiata e acclamata dalla critica. Tra le sue opere ricordiamo The Liars’ Club (1995), Cherry (2001) e Lit (2009), nonché Art of Memoir (2015) e cinque raccolte di poesie, tra le quali la recente Tropic of Squalor (2018). Autrice di testi per canzoni, ha collaborato con Rodney Crowell all’album Kin. Oratrice ricercata, ha tenuto conferenze in prestigiose università, biblioteche e festival di letteratura in tutto il mondo ]
«Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia umana è, in un certo senso, storia divina. Nella storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del suo Figlio» (Papa Francesco).
Per i primi quarant’anni della mia vita sono stata atea e quindi mi sono sempre sentita come una strega in qualsiasi chiesa venissi trascinata — soprattutto da piccola, dai miei vicini. Mi colpisce leggere nel messaggio del Papa sulla narrazione come ogni storia umana abbia «una dignità insopprimibile», e che il Padre, di fatto, guarda tutti noi e vede suo figlio Gesù — davvero una buona notizia per una cintura nera del peccato come me.
Sono cresciuta in una famiglia difficile, di forti bevitori e atei convinti, ma i libri che vi ho trovato — che erano strani nella Bible belt operaia texana dove sono nata — in qualche modo mi hanno salvata, connettendomi con altre creature sofferenti attraverso la narrazione. Non credevo in Dio, ma una parte di me pensava veramente che Winnie the Pooh stesse nel bosco ad aspettare il suo amico Christopher Robin e che un giovane stalliere di nome Semola sarebbe diventato re estraendo una spada da una roccia — destino che compì solo per caso. (Proprio come spesso è solo per caso ce realizziamo il sogno speciale di Dio per ciascuno di noi). Quei racconti mi davano speranza quando questa era scarsa.
Ero una bambina permalosa e studiosa, stramba e piagnucolona. Vivevo in un quartiere difficile, ed ero abbastanza sboccata da attirarmi qualche sberla, fino a quando papà mi ha incoraggiato a iniziare a mordere chiunque cercasse di sopraffarmi. «Fagli sentire i denti, piccola», diceva. Un morso lasciava un segno duraturo anche nel bullo più grande. E le cicatrici che ho lasciato sono entrate a far parte di quello che si raccontava nel quartiere su quanto fossi selvaggia. Imprecavo come un marinaio, anche da piccolissima — i miei genitori trovavano divertente che bestemmiassi. Riesco ancora a sentire la signora Perry che, dalla sua veranda, agita il mocio nella mia direzione e dice: «Dalla tua bocca escono serpenti e lucertole, Mary Karr». Ma quando le rispondevo che non me ne fregava niente, mentivo.
Non m’importava, e mi feriva, quando gli altri bambini dicevano che saremmo andati tutti all’inferno, sebbene non credevo che esistesse un posto del genere. Simone Weil ha detto che non c’è sofferenza senza dolore — una qualche forma di pubblico disprezzo, o di gogna. Anche se i nostri vicini non ci evitavano in maniera evidente — ci lasciavano partecipare ai loro incontri di baseball e rispondevano quando ci rivolgevamo loro — la maggior parte degli adulti non permetteva ai figli di giocare nel nostro cortile. Chi poteva biasimarli? C’erano fori di proiettile nelle pareti della mia cucina. A dire il vero, nemmeno io mi sentivo tanto sicura a casa mia.
Non fraintendetemi. I miei genitori non erano mostri. Li adoravo e loro mi amavano meglio che potevano. Ma entrambi erano tormentati da terribili demoni — papà forse da quelli della seconda guerra mondiale, mamma da un paio di figli persi e più di cinque mariti, dei quali sono venuta a sapere quando avevo una ventina d’anni. Entrambi bevevano per dimenticare il dolore, abitudine che li rendeva solo più confusi e depressi.
«Nella storia serpeggia il male», scrive il Santo Padre. E così i cristiani spesso usano i racconti biblici per escludere quelle persone che Gesù più vuole che accogliamo. Nella mia mente di bambina ho collegato la pietà rimproverante dei nostri vicini con tutta la religione – anche con Dio e Gesù, e tutto il resto. Così, di riflesso respingevo ogni narrazione di fede proprio quando avevo più fame del suo aiuto.
Per giunta, i racconti erano difficili da digerire. Chi mai potrebbe credere che un tempo un’arca è riuscita a contenere una coppia di tutti gli animali, o che un mare si è aperto perché degli schiavi potessero fuggire dai loro carcerieri? Certamente non riuscivo a credere che i miti avrebbero mai ereditato la terra. Trascinata a messa da una compagna di scuola, trovai la statua di Maria talmente beata e perfetta — non aveva nemmeno un poro dilatato! — da pensare che mi avrebbe davvero odiata.
Ma il corpo massacrato inchiodato alla croce — quello mi sembrava reale. Mi attirava con un fascino quasi pornografico. Che quella grottesca sofferenza privata venisse esibita in pubblico mi lasciava di stucco. Inoltre, l’autocommiserarmi mi aveva resa sensibile alle persone ferite. Semplicemente non riuscivo a guardare a un Gesù crocifisso senza che mi sentissi soffocare. Di certo, però, non credevo che era tornato! Nessun essere umano inchiodato così a una croce poteva rialzarsi e preparare una grigliata sulla spiaggia per i suoi compagni. Impossibile. Non c’è verso.
Ci raccontiamo storie per vivere, ha scritto la saggista americana Joan Didion. Con l’evolversi della tecnologia per condividere e conservare le informazioni, i racconti hanno senz’altro modellato il cablaggio stesso del nostro cervello. Ma ogni grande opera letteraria inizia con un essere umano — nella solitudine del suo viaggio — che vuole uscire e trovare un’altra creatura che la pensa come lui.
La letteratura più antica, come per esempio l’Odissea, conteneva tutte le imprese umane. Quel poema non serviva solo a intrattenere, ma spiegava anche le usanze religiose e descriveva la storia; trasmetteva religione ed educazione civica, filosofia e diritto, istantanee della vita quotidiana. Oggi sono altre tecnologie ad avere questo onere — libri di testo e fotografie, documentari e videogiochi. Ma al centro di come ci conosciamo gli uni gli altri — impresso in noi e integrato nel nostro firmware — c’è la narrazione. Quando raccontiamo storie, non entriamo semplicemente nella tradizione di Shakespeare e di Eschilo o dei profeti come san Paolo, ma ci colleghiamo anche agli antenati seduti nelle cave a tracciare bisonti sulle pareti, ci colleghiamo a tutta la nostra famiglia umana, come sottolinea il Santo Padre.
Quando ero una giovane madre e scrittrice in affanno, il fatto che bevessi e facessi uso di droghe iniziò a rovinare la vita del mio bambino. Per smettere di bere fui mandata in un seminterrato, dove gli altri alcolizzati e tossici sembravano degli scansafatiche e dei perdenti — non era gente che avrei voluto frequentare. Dovetti ricorrere a ogni briciolo del mio autocontrollo per non scappare fuori ed entrare nel primo bar, poiché sentivo un terribile bisogno di whiskey. Ma ho preso un bicchiere di polistirolo di caffè e — malgrado la mia repulsione — ho iniziato ad ascoltare. Il risultato è stato magico. Ogni volto ha iniziato a fiorire aprendosi come un girasole. Quante difficoltà avevano tutti!
Il dottor, John Avery, specialista in dipendenze al New York Hospital di Manhattan, in seguito mi disse che la consolazione che avevo iniziato a provare aveva un fondamento fisiologico. Quando ascoltiamo i racconti delle persone — specialmente di quelle con cui abbiamo condiviso le nostre stesse avventure — rilasciamo un ormone chiamato ossitocina, l’“ormone del benessere”. I nostri livelli di cortisolo e di adrenalina — gli ormoni dello stress — si abbassano. Di fatto, l’ossitocina è quello che secernono le madri quando allattano al seno. Ci aiuta a collegarci gli uni con gli altri e a sentirci meno soli. Riduce l’ansia e può tessere magicamente estranei disperati in un’amorevole tribù. Quando Joan Didion ha scritto «Ci raccontiamo storie per vivere», senz’altro intendeva che in parte otteniamo questo conforto da polverina magica connettendoci attraverso la narrazione.
All’inizio del mio ritorno alla sobrietà cominciai a praticare la preghiera centrante — non per “trovare Dio”, ma per alleviare una vita di depressione e ansietà. E mi sono ritrovata a leggere sempre più opere monastiche cristiane di gente come Thomas Merton e il grande padre cistercense Thomas Keating, di venerata memoria. E in mezzo al mio trovare una qualche comunità tra i sobri e un po’ di quiete nel mio petto, mio figlio mi chiese di portarlo in chiesa «per vedere se Dio è lì». All’epoca aveva otto o nove anni, così gli misi un farfallino e andammo.
Ragazzi, quanto mi sono sentita pazza e strana ad andare a messa: una donna divorziata, ex tossicodipendente in mezzo a tutte quelle famiglie tirate a lucido. Non conoscevo le regole — quando alzarsi e che cosa dire. Mio figlio andava alla scuola domenicale e io mi sedevo in fondo, con una pila di compiti da correggere (sono professoressa) e del latte.
E poi avvenne la cosa più strana. Durante la preghiera dei fedeli, le persone iniziarono a recitare le loro intenzioni. Io ero piuttosto in fondo e non riuscivo a vedere nessun volto, ma potevo sentire ogni voce. Una giovane donna dalla voce tremula disse «per l’intervento per il tumore di nostro figlio», e la congregazione replicò «Signore, abbi misericordia». Dal banco dietro, una mano di donna si appoggiò sulla spalla di quella madre e io mi ritrovai con un nodo alla gola. Un uomo anziano pregò, rendendo grazie, perché sua nipote era tornata sana e salva da una missione in Salvador, e un signore dall’altro lato della navata gli mostrò il pollice in su. Ascoltando le speranze e i timori semplici di quelle persone, sentii il duro guscio intorno al mio cuore dissolversi. Udivo piccoli frammenti di storie belle e nobili, raccontate da persone che ancora non avevo incontrato.
Non furono le straordinarie storie della liturgia a coinvolgermi — quelle arrivarono molti anni dopo. Furono i cuori amorevoli delle persone tesi ai loro simili, e alla fine anche a mio figlio e a me. Le loro storie mi condussero alle scritture e — infine — al battesimo. Ora lo Spirito Santo ha riscritto la mia storia. La casa della mia infanzia non è stato soltanto un posto crudele la cui brutalità mi aveva traumatizzato fino a distruggermi — anche se in parte è vero. È stato anche un luogo che mi è stato dato per praticare l’amore paziente e disponibile per i miei genitori, instillato nel mio cuore quando sono stata tessuta nel grembo di mia madre. Questa è una storia che posso sostenere.