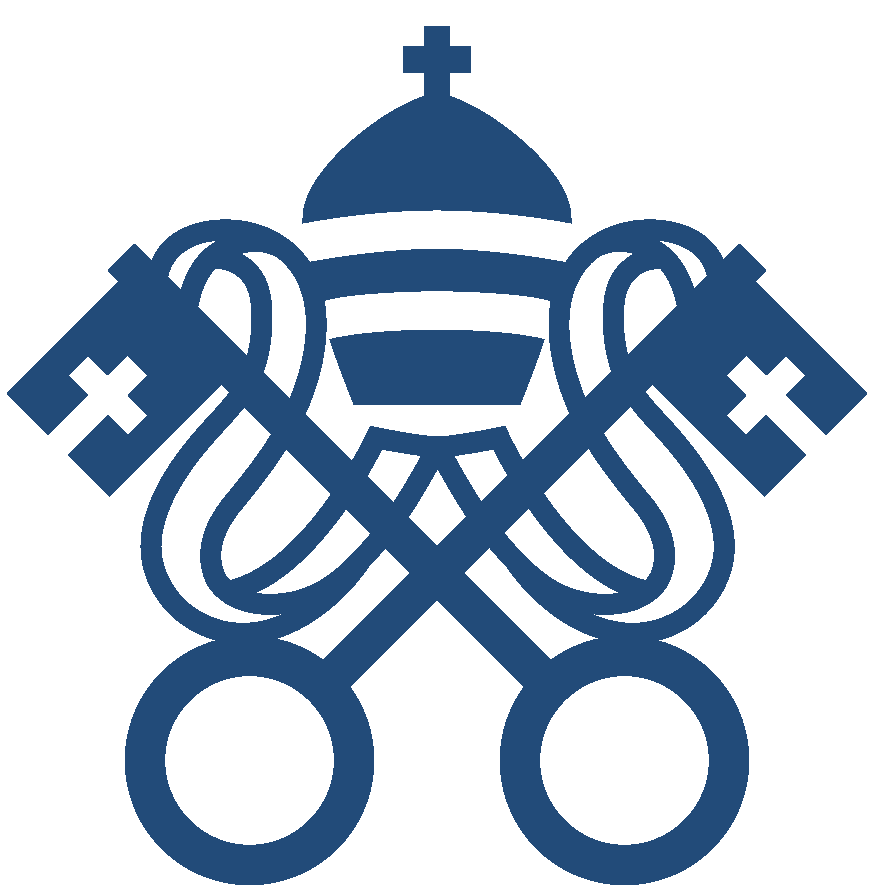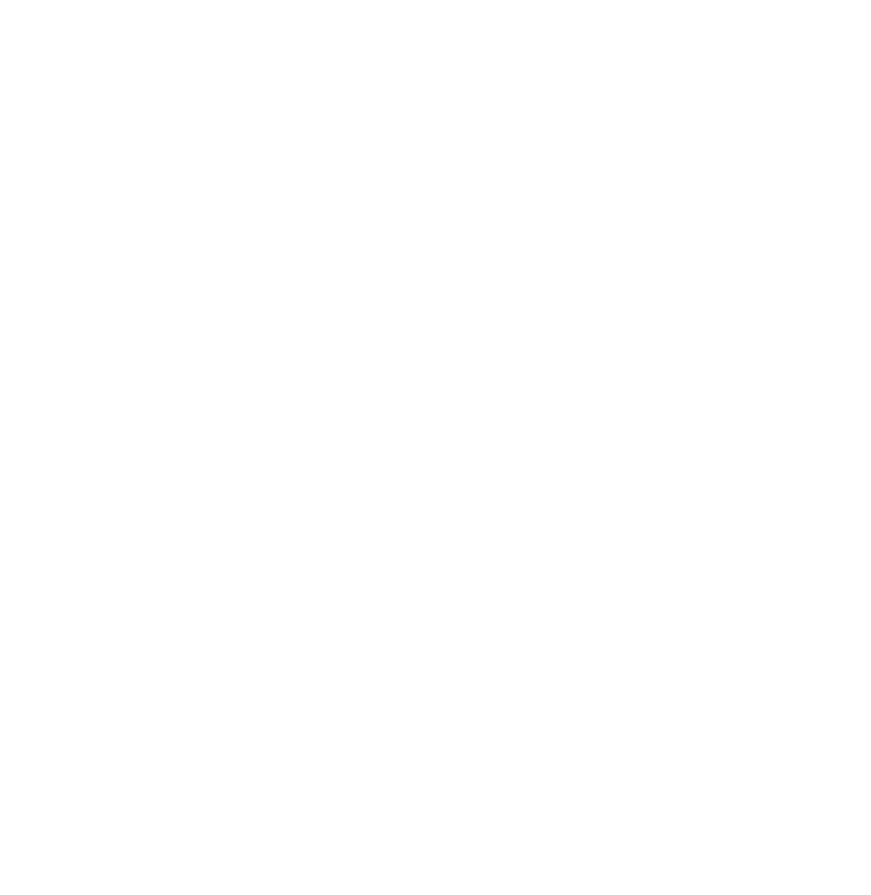di Marco Tibaldi
«Il racconto è presente in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le società; il racconto comincia con la storia stessa dell’umanità; non esiste, non è mai esistito in alcun luogo un popolo senza racconti... il racconto si fa gioco della buona e della cattiva letteratura: internazionale, transtorico, transculturale, il racconto è come la vita». Così si esprimeva a ragione Roland Barthes, identificando nella narrazione, per così dire, uno dei bisogni primari dell’uomo che, accanto al cibo, al sostentamento e all’accudimento avverte la necessità dei racconti. «Mi racconti una storia?» è una delle prime richieste che ogni cucciolo di uomo formula appena è in grado di esprimersi. Le storie infatti sono interpretazioni della realtà, una mappa simbolica per orientarsi in quel ricco, affascinante ma anche pericoloso luogo che è il mondo in cui si è chiamati a vivere. Lewis Carrol diceva che le fiabe sono «doni d’amore» perché come ogni narrazione fanno sognare: consentono di vedere mete ma anche come raggiungerle, mettono in scena, attraverso i loro simboli, le paure, i desideri, gli insegnamenti fondamentali per potersela cavare.
Cominciato da piccoli questo grande racconto non cessa mai. Oggi ha assunto nuove forme rispetto al passato, a causa dell’evolversi dei modelli famigliari e dello sviluppo della tecnologia. Sono sempre meno i genitori o i nonni, quando ci sono, a raccontare le prime storie, delegando questa funzione primaria dell’educazione alla televisione o al tablet. Una volta cresciuto, nel giovane o nell’adulto, non si estingue il bisogno di narrazione. Ai romanzi e alla letteratura, che la scuola cerca faticosamente di difendere, si sono affiancati una miriade di altri erogatori di narrazione: in primisin primisla televisione, ma, sempre più, anche i computer o i telefonini che consentono di accedere alle infinite risorse della rete.
Al di là di tutto, riaffiorano costantemente anche nell’orizzonte tecnologico in cui siamo immersi le domande che guidano i racconti che, come ricordava Barthes, sono coincidenti con la vita. Tutte le tappe e i momenti significativi dell’esistenza sono messi a tema: la nascita, la morte, l’al di là ma anche l’al di qua, lo star bene e lo star male in tutte le loro forme. Vediamo allora più da vicino il meccanismo di funzionamento della narrazione, per cercare di capire meglio il fascino che da sempre suscita. Come fa a catturarci? In primo luogo attira attraverso il divertimento, inteso nel senso etimologico della parola come «cambiamento di direzione» (dal latino de-vertere ). Il racconto fa cambiare strada perché allontana dalla presa diretta con la realtà che, anche quando va bene, è sempre impegnativa. Per questo, il racconto rilassa, mette il suo destinatario a proprio agio perché lo porta in un mondo lontano. Per farlo utilizza l’immaginazione, una funzione spesso bistrattata nelle agenzie educative ufficiali, mentre è così umana e spirituale nella sua costituzione. Attraverso l’immaginazione si entra nel regno del possibile, si possono visitare luoghi in cui non si è mai stati e nel contempo rivivere tempi andati o immaginarne di futuri.
L’immaginazione si nutre di ricordi e anticipazioni. Alle parole «c’era una volta un castello» o alle prime sequenze di un telefilm ambientato ad esempio in un ospedale, subito si attivano, attraverso l’immaginazione, i ricordi personali, perché tutti hanno sentito parlare di un castello in cui una volta viveva una principessa o un re... o di un ospedale con medici, malattie e corsie piene di persone. E così la storia ha già catturato il suo ascoltatore o spettatore, facendogli rivivere, se non tutti i dettagli del passato, certamente le tracce emotive, belle o brutte, che esso ha lasciato. E quando si muovono gli affetti ci si appassiona e non si vuole far altro che vedere o sentire come va a finire la storia.
Nella capacità di immaginare il futuro sta l’altro aspetto emozionante delle storie. Nel loro dispiegarsi, soprattutto quando i protagonisti sono posti davanti alle scelte da compiere, i destinatari, alla velocità della luce, scelgono con loro, come se si fosse in quella situazione. E dopo si vuole sapere cosa è successo realmente nella storia, per vedere se si è indovinato la scelta oppure no. Nel gioco di mettersi nei panni di un altro sta il fascino e il piacere della narrazione. In fondo, è il giocare alla vita senza dover pagare il prezzo per quando si sbaglia. E siccome la vita interessa, anche la narrazione, nelle sue varie forme, non cessa di abbandonare gli uomini finché sono in vita.
Grazie alla sua rilevanza antropologica, la relazione che si viene a instaurare tra colui che racconta e il destinatario delle storie è molto forte. Basti pensare al successo che hanno i divi di ieri e di oggi siano essi gli autori delle storie narrate o gli attori che le hanno impersonate.
Le storie poi hanno il potere magico di modificare i comportamenti. Il loro apparente de-vertere riporta il lettore nella vita con una forma nuova che, se lo si vuole, si può assumere e fare propria nel bene come nel male. Nel male, perché tante volte è accaduto che personaggi letterari abbiano dato voce o incitato comportamenti negativi, come accadde, ad esempio, all’uscita del Werther di Goethe che fu accompagnato da un’ondata di suicidi. Ma anche nel bene, come accadde esemplarmente al termine del racconto che il profeta Natan fece al re Davide, per fargli prendere consapevolezza del male compiuto e portarlo così al pentimento (2 Samuele 12, 1-15).
Per questi motivi il concilio Vaticano ii ha autorevolmente sottolineato l’importanza della narrazione. Ad esempio nella Dei Verbum , il documento conciliare dedicato alla rivelazione, si afferma che «Dio invisibile nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Esodo 33, 11; Giovanni 15, 14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Baruc 3, 38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (Dei Verbum 2). Questo processo di comunicazione personale «avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto». Il tutto trova poi il suo apice nella vicenda del Figlio incarnato, il «Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione». Per conoscere Dio e poterlo annunciare ad altri, è necessario quindi raccontare l’insieme di eventi e parole che costituiscono la sua rivelazione. Senza il racconto non possiamo infatti accedere agli eventi così come questi, senza le parole che ce li trasmettono, resterebbero muti.
Da queste premesse, Dei Verbum muove per offrire una serie preziosa di indicazioni su come debba essere fatta questa narrazione. In primo luogo, occorre considerare l’unità tra i due Testamenti. Contro una tendenza sempre risorgente, da Marcione in poi, di separare o considerare meno importante il Primo Testamento rispetto al Secondo, perché in esso si manifesterebbe il volto violento e irascibile di Dio, il concilio ribadisce con forza che Dio «ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nell’Antico e l’Antico diventasse chiaro nel Nuovo» (Dei Verbum 16) e che senza l’Antico il Nuovo non si può comprendere. Ciò significa anche che occorre mettere in luce nella narrazione il carattere evangelico di buona notizia già presente anche nel Primo Testamento, inquadrando e interpretando le difficoltà poste da certi passi, alla luce sia del principio cristologico sia dell’attenta considerazione dei generi letterari (Dei Verbum 12).
Di fronte a espressioni o a testi che, presi alla lettera, presentano un volto ambiguo di Dio, basta chiedersi cosa ha fatto Gesù, il narratore del Padre (Giovanni 1, 18), per capire che quelle espressioni sono frutto di una comprensione parziale di Dio, che si è evoluta nel tempo e che egli stesso ha accettato pur di interagire con gli uomini.
La narrazione da elemento centrale della riflessione dell’uomo su se stesso e la propria vita è quindi anche il luogo entro cui incontrare il nostro Salvatore e Redentore. Ciascuno, in fondo, diventa le storie in cui si identifica. Come ha efficacemente detto Paul Ricoeur, la nostra identità è narrativa per cui, prendendo sul serio le narrazioni evangeliche che contengono in sé tutto ciò di cui gli uomini hanno bisogno e che desiderano, si può arrivare all’esperienza mirabile descritta da Paolo: «Non vivo più io ma Cristo vive in me» (Galati 2, 20).
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 22 ottobre 2020)