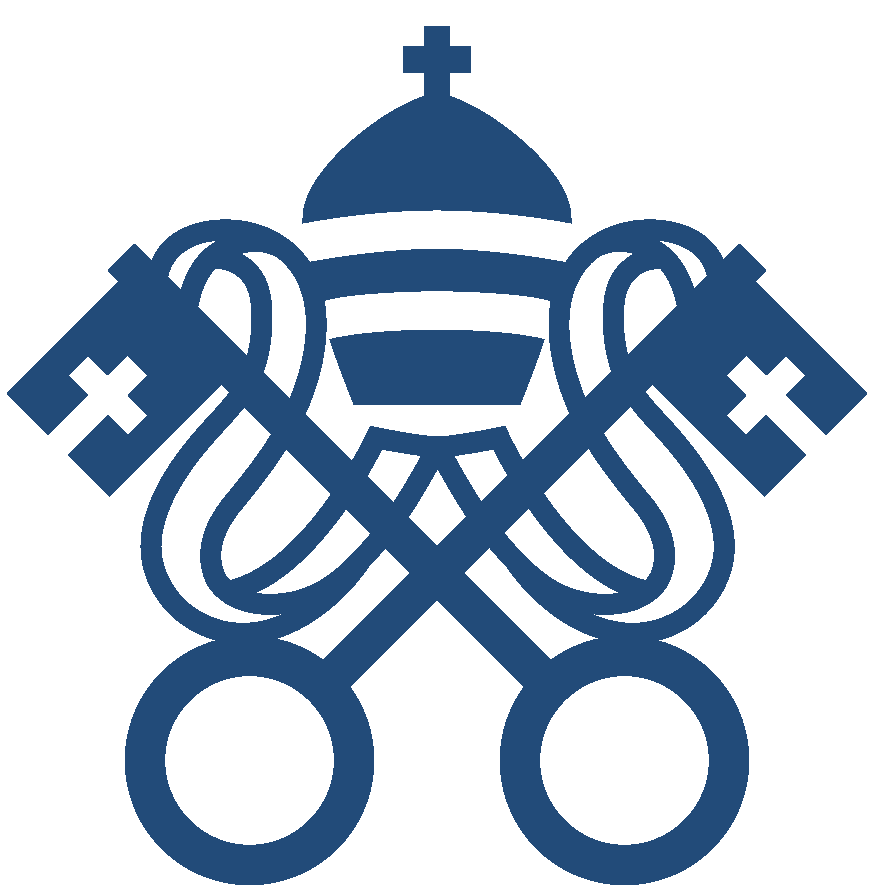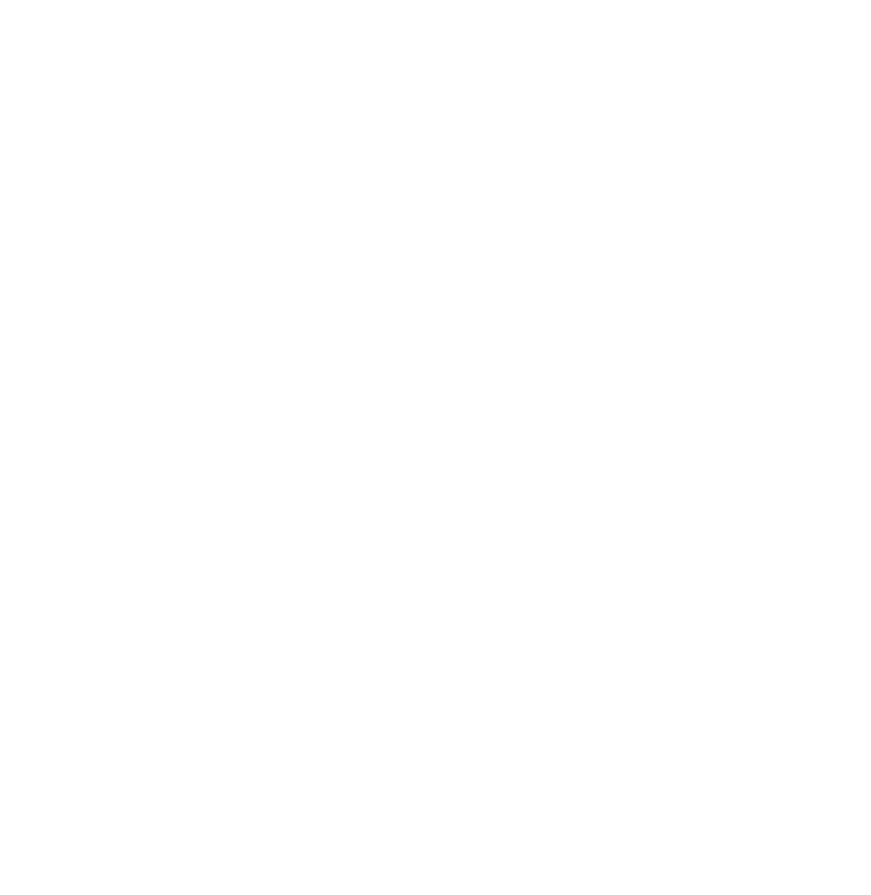di Paolo Pegoraro
Poche settimane fa ho cambiato casa. Nella cortilina condominiale, a protezione delle finestre, ho trovato dieci vasi con una siepe di pitosforo inselvatichito: sterpi aggrovigliati in ogni direzione, piante infestanti e germogli intestarditi a farsi strada tra foglie collose di cocciniglie o traforate dall’oziorrinco. L’estate casalinga della pandemia mi ha dato il tempo di ripulire, potare, trapiantare, concimare, scoprire piccole succulente ricoperte da quel caos. Il risultato ha sorpreso me non meno dei condomini. Sì, in quella selva anarchica era nascosta molta bellezza.
Anche il tempo assomiglia in qualche modo a quella piccola selva. Innocenza e disillusione, incontri e amicizie, sogni, scontri, fallimenti, traumi e meraviglia... le stagioni della vita si accalcano l’una sull’altra: l’amore, la morte e il perdono che entrambe abbraccia. Ogni istante tende i suoi delicati ramoscelli al sole del ricordo, molti riparano nell’ombra fresca dell’oblio. E come una boscaglia senza manutenzione non è un giardino, così il tempo che non viene raccontato non è storia. Quanta responsabilità, in questo compito! Negazione, distorsione, strumentalizzazione, parzialità, falsificazione... quanti parassiti strisciano tra le radici! Quale ramo è vivo, e quale secco? Quale erba officinale, quale insetto dannoso? Cosa narriamo — a noi stessi e agli altri — e cosa potiamo? Quanta attenzione e fatica richiede, questo lavoro. Non solo i comunicatori di professione — siano essi giornalisti o narratori, testimoni o cantastorie — ma ognuno di noi è “giardiniere del proprio tempo”, poiché la vita si fa storia solo attraverso il racconto della memoria. Colpisce che lo scorso gennaio Papa Francesco abbia scelto di articolare, nel suo Messaggio per la 54ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, la congiuntura “vita-racconto / memoria-storia”. Perché ciò che la pandemia ha mietuto, con le vite dei nostri amati, sono state proprio le distese della memoria di intere generazioni. “Memoria” che non è la mera cronaca dei fatti, ma l’eco di come quei fatti hanno risuonato nei cuori di un altro tempo. Il ricordo di come donne e uomini come noi hanno risposto alle scosse della vita. Gli anziani sono testimoni che altri stili di vita — e di relazioni umane — sono stati possibili. Che “oggi” non è “da sempre” né “per sempre”. «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria» (Esodo 10, 2).
Come raccontare la memoria? La nostra, certo, ma anche quella di una comunità umana? Papa Francesco ci ricorda che vi sono «storie buone» come pure una «memoria malata», quella rimasta impigliata «ai rimpianti e alle tristezze».
Le storie buone sono dunque quelle che aiutano la memoria nel delicato processo della guarigione. Proprio venti anni fa un altro grande papa invitò tutta la Chiesa a purificare la memoria. Era la Giornata del Perdono del Grande Giubileo dell’Anno 2000 e san Giovanni Paolo II, con un gesto esemplare e profetico, scandì l’invocazione: «Perdoniamo e chiediamo perdono!».
Raccontare la memoria, trasmettere la memoria, purificare la memoria: giungere anche faticosamente a chiedere e concedere riconciliazione.
Si tratta, tanto nella dimensione personale come in quella collettiva, di un processo lento, che richiede infinita cura e continue attenzioni, come quelle di cui ha bisogno una pianta in fin di vita. È un processo che intende liberare la coscienza «da tutte le forme di risentimento o di violenza, che l’eredità di colpe del passato può avervi lasciato» per condurre «ad un corrispondente riconoscimento di colpa e contribuisca ad un reale cammino di riconciliazione» (Memoria e riconciliazione).
La memoria non può essere raccontata senza progressiva purificazione, perché una memoria prigioniera della rivalsa, una memoria germinata nella mera subalternità dell’odio, è radice di frutti malati: irrigidisce nella meccanica necessità della reazione, stronca il dinamismo della storia, ci tramuta in statue di sale.
Come pure è malattia l’ingratitudine, la cecità a quanto ricevuto, lo sguardo volto solamente in avanti. Per questo Papa Francesco ci invita a raccontare la nostra storia a un pubblico speciale. Non a noi stessi, pubblico timoroso di entrare in certe stanze ormai senza più chiave; e neppure agli altri, pubblico deliziato solamente dalle stanze senza chiave. No, che il nostro pubblico sia... Dio. «Ma come — è l’immediata obiezione — se c’è qualcuno che già conosce la mia storia è proprio Lui! Cosa gliela racconto a fare?».
Ripenso a quando, bambino, chiedevo ogni sera ai miei nonni di raccontarmi la medesima favola; a come li correggessi a ogni dimenticanza, anche minima; a come gli occhi sfavillassero di invariato stupore. Similmente lo sguardo di Dio «cambia il senso e la prospettiva» della nostra storia: non solo egli non ne è annoiato, ma anzi, interviene con grazia a correggere il nostro racconto moraleggiante, riversandovi il solo, imprevedibile colpo di scena che mai stanca... l’«amore compassionevole verso di noi e verso gli altri».
Sì, Dio conosce già la nostra storia: siamo noi, quelli che devono ascoltarla ancora e ancora. Siamo noi quelli che devono volgersi indietro per fare «memoria dell’amore», per maturare la gratitudine in una responsabilità libera e gioiosa, molla propulsiva verso il futuro. Il racconto della memoria — il senso che vogliamo dare al nostro tempo — è un’operazione fatta di gesti attenti e segreti, come il giardinaggio o, secondo l’immagine usata dal Papa, come la tessitura.
La selezione dei materiali da filare, dei loro colori, del disegno. L’intreccio dei fili orizzontali della trama con quelli verticali dell’ordito (da cui, in italiano, il senso traslato dei verbi tramare e ordire come “agire di nascosto”). Quanti fili non scorgiamo, oppure dimentichiamo, nel racconto della nostra memoria? Quanti nodi, visibili solamente se si arrovescia il bel tessuto, sono stati necessari per comporre la fantasia aggraziata della nostra personalità?
D’altra parte, come ci ricorda il libro dell’Esodo (33,23), anche Dio non si può vedere che di spalle... quasi che il suo passaggio si potesse riconosce solamente a posteriori. E, pertanto, nel racconto della memoria.
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 3 settembre 2020)