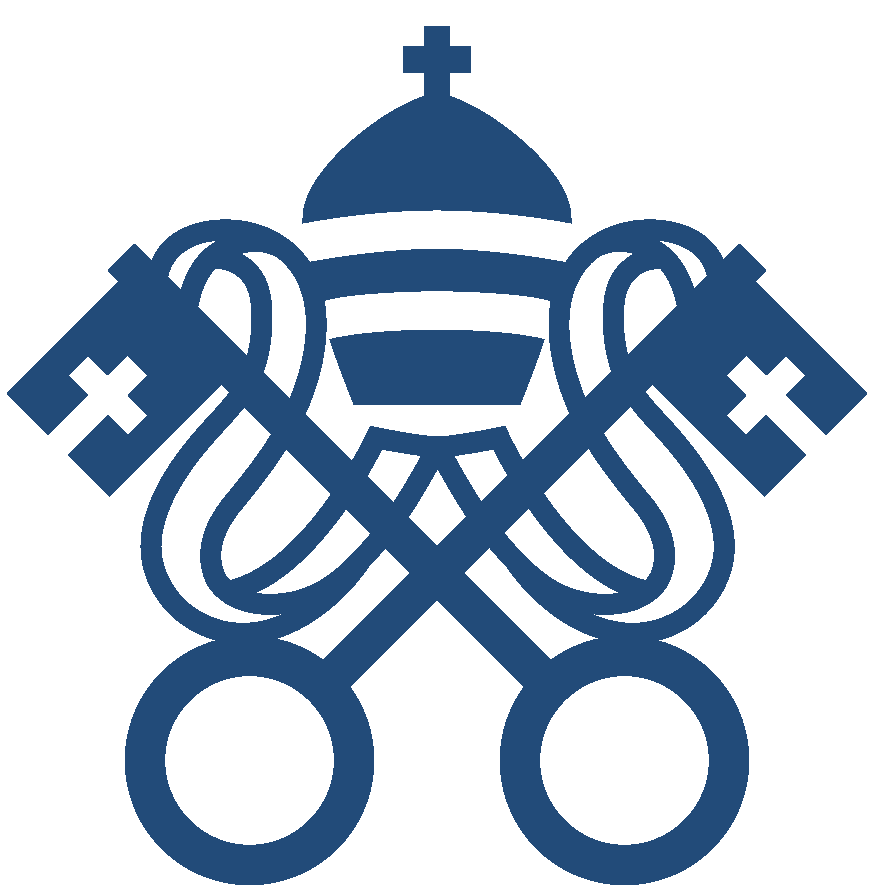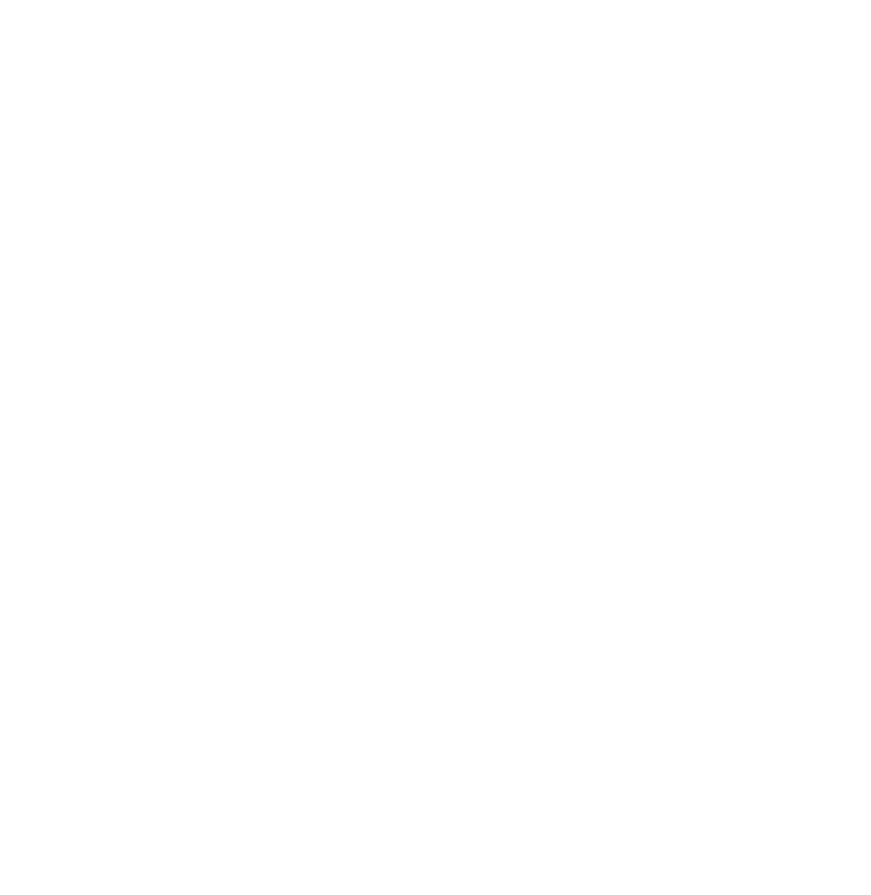di Brunetto Salvarani
C’è una storia, raccolta da Jirí Langer, ebreo praghese amico di Kafka, e contenuta in un libro commovente intitolato Le nove porte: «In una yeshivà (la scuola talmudica) un giovane allievo, un po’ sprovveduto e proveniente da lontano, sin dai primissimi giorni di insegnamento si segnala per una strana caratteristica. Non appena il maestro, volendo introdurre la lettura della Torà, pronuncia le parole: “E Dio disse” (il ritornello del primo capitolo della Genesi), egli si mette a danzare e, correndo vorticosamente su e giù nel cortile della scuola, non smette di ripetere come un folle: “E Dio disse”, “E Dio disse”. In tal modo non riesce che a seguire pochi attimi della lezione. Eppure questo gli è sufficiente».
“E Dio disse”! L’ingenuo studente aveva colto, in realtà, il senso profondo e la radicalità inimitabile di quelle tre parole, che racchiudono l’evangelo più stupefacente che il cosmo intero possa mai udire: yhwh parla, e il suo narrare è meravigliosamente creativo. Attraverso la sua parola — in ebraico davar — Egli crea, e fa buono (e bello, secondo il senso dell’originale tov) tutto ciò che plasma. Tuttavia l’agire di yhwh si concretizza tramite un racconto, ancora prima che con un gesto. Inoltre, non è creativo soltanto di un mondo: è creativo di un popolo, quello che diverrà Israele quando, ai piedi del Sinai, non vide immagine alcuna, e «vi era soltanto una voce» (Deuteronomio 4, 12). Quel ragazzo della yeshivà aveva intuito che il compito dell’uomo è fare memoria delle meraviglie di Dio, raccontando a sua volta che yhwh ci ha parlato.
Queste prospettive, di grande suggestione, sono sottese al messaggio che Papa Francesco ha firmato per la cinquantaquattresima giornata delle comunicazioni sociali, prendendo atto dell’odierna rinascita di quella che per primo il teologo tedesco Johann Baptist Metz — recentemente scomparso — ha definito teologia narrativa. Un testo, quello papale, ottimamente documentato e ricco di spunti sia teorici sia pratici, in cui si conferma, una volta di più, la sua predilezione per uno stile cristiano pienamente immerso nei tempi incerti che stiamo attraversando. Scrive Bergoglio: «Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia umana è, in un certo senso, storia divina. Nella storia di ogni uomo il Padre rivede la storia del suo Figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha una dignità insopprimibile. Perciò l’umanità merita racconti che siano alla sua altezza, a quell’altezza vertiginosa e affascinante alla quale Gesù l’ha elevata».
Ebbene, sono trascorsi quasi cinquant’anni dall’uscita del numero di «Concilium» grazie al quale la locuzione teologia narrativa entrava quasi di soppiatto nel dibattito teologico mondiale, provocando peraltro da subito un discreto fragore. Si deve soprattutto a un paio di brevi articoli ivi comparsi, firmati da Harald Weinrich e dallo stesso Metz, il merito di aver avviato, sostanzialmente ex nihilo, una riflessione destinata a rivelarsi quanto mai fruttuosa in svariati ambiti del sapere religioso: è da allora che si è cominciato a riferire e a discutere, fra l’altro, di etica narrativa, di pedagogia narrativa, di esegesi narrativa, catechesi narrativa, e così via. Che si è riaperta una strada da troppo tempo chiusa, o pressoché tale: perlomeno inaridita. Che si è colto, finalmente, almeno in nuce, non solo che, come spiegava Umberto Eco nella prefazione a Il nome della rosa, di ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare, ma che la fede cristiana si capisce veramente solo raccontando una storia.
Se il narrare di Dio rappresenta il suo ingresso e, potremmo dire, la sua compromissione con la storia, è evidente che, per trattenere Dio nella storia, tutto questo debba essere narrato: tutto questo e tutto ciò che viene dopo nelle opere di Dio, l’esodo, l’elezione, l’alleanza, la futura redenzione. Sì, paradossalmente anche il futuro va narrato: non come fantasia letteraria o illusione apocalittica, ma in quanto seme nascosto nel tesoro della memoria e destinato a germogliare in seguito. È in tale chiave che nel rito della cena pasquale ebraica — il cosiddetto seder, matrice dell’eucaristia — la famiglia racconta e si racconta, secondo il comando di Es 12, 14.27, ma tiene anche socchiusa la porta di casa, nell’eventualità che si faccia vivo il profeta Elia, colui che per la tradizione garantisce l’efficacia nel futuro del racconto. Sappiamo come simili temi siano rimasti negletti per secoli nella teologia e nella catechesi cristiane e la Bibbia sia stata letta spesso in modo atemporale, come una riserva di prove teologiche. Oggi però non è più così, e i risultati si cominciano a vedere.
Parafrasando il titolo di un’opera di Daniel Pennac, potremmo dire che la testimonianza e l’insegnamento cristiani si snodano nei secoli come un racconto, a partire dal racconto fondatore, quello della vita, morte e risurrezione di Gesù di Nazaret. La riscoperta di una teologia che prenda le mosse da qui, accogliente, disponibile alla parresìa, produttrice di speranza, ha inoltre reso più agevole la ripresa di un incontro con l’ebraismo, che si è sempre più autocompreso attraverso la narrazione che tramite la riflessione dogmatica. Nel tempo del pluralismo religioso e del mosaico della fede in un Paese, come il nostro, che fatica ad accettare questo scenario in progress, la ricerca, pure spesso ardua, di occasioni di incontro passa anche attraverso un lavoro sulla nostra identità narrativa. Perché dialogare non significa necessariamente risolvere un problema: invece di argomentare o dimostrare si può anche raccontare o ascoltare la storia di un altro.
Andrebbe favorita, pertanto, la possibilità ai molti fratelli e sorelle stranieri che ci vivono accanto (e con i quali, peraltro, spesso ancora non viviamo insieme) che vorrebbero narrare la propria storia, di poterlo fare, moltiplicando gli spazi e i momenti per far sì che il nostro racconto — oggi non di rado sfuocato e spersonalizzato — s’incroci con il loro. Creando un racconto nuovo. Anche perché — come annota il Papa nel suo messaggio — «per opera dello Spirito Santo ogni storia, anche quella più dimenticata, anche quella che sembra scritta sulle righe più storte, può diventare ispirata, può rinascere come capolavoro, diventando un’appendice di Vangelo».
Non solo. Una narrazione autentica, pericolosa, e capace di effetti critici, inizia quando la persona diventa capace di assumere il ruolo degli altri e contemporaneamente guarda se stesso dal loro punto di vista: essa si colloca infatti al cuore del conflitto tra i bisogni di appartenenza e le aspirazioni al cambiamento, svolgendo un ruolo liberatorio di accomodamento, di interdipendenza e interazione. La strada sempre più urgente di una seria pedagogia interculturale troverebbe vigore dal suo innesto con quella della pedagogia narrativa. Papa Francesco ne aveva già parlato in Evangelii gaudium (2013), affrontando il tema della sfida delle culture urbane: «È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città» (n.74).
Chiudo, ripensando ai rapporti con i nostri fratelli maggiori (come li chiamò san Giovanni Paolo II nel suo storico appuntamento nel Tempio maggiore della capitale il 13 aprile 1986), con una domanda ai miei occhi puramente retorica. Lo accennavo sopra: è solo un caso che si sia ripreso, sia pur faticosamente e a passi circospetti, a discutere fra ebrei e cristiani, proprio mentre la teologia è tornata a verificare le proprie antiche radici narrative? No, non è un caso, anzi: è un’altra prova che «la salvezza viene dai Giudei» (Giovanni 4, 21), o meglio, da Chi l’ha raccontata loro e, tramite loro, a tutti. Senza voler stabilire l’ingenerosa equazione per cui argomentativo equivarrebbe senz’altro a negativo e narrativo a positivo, vorrei parafrasare l’esclamazione di Mosè — «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!» (Numeri 11, 29) — così: «Fossero tutti (o molti, almeno) narratori di storie nel popolo del Signore!».
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 24 settembre 2020)