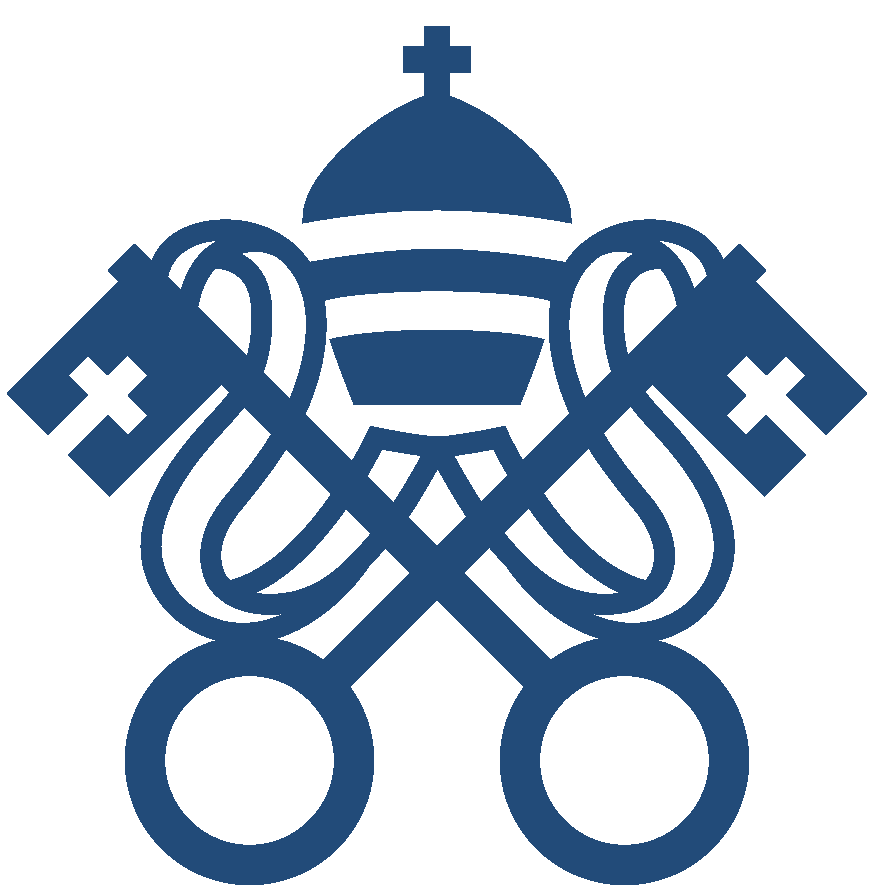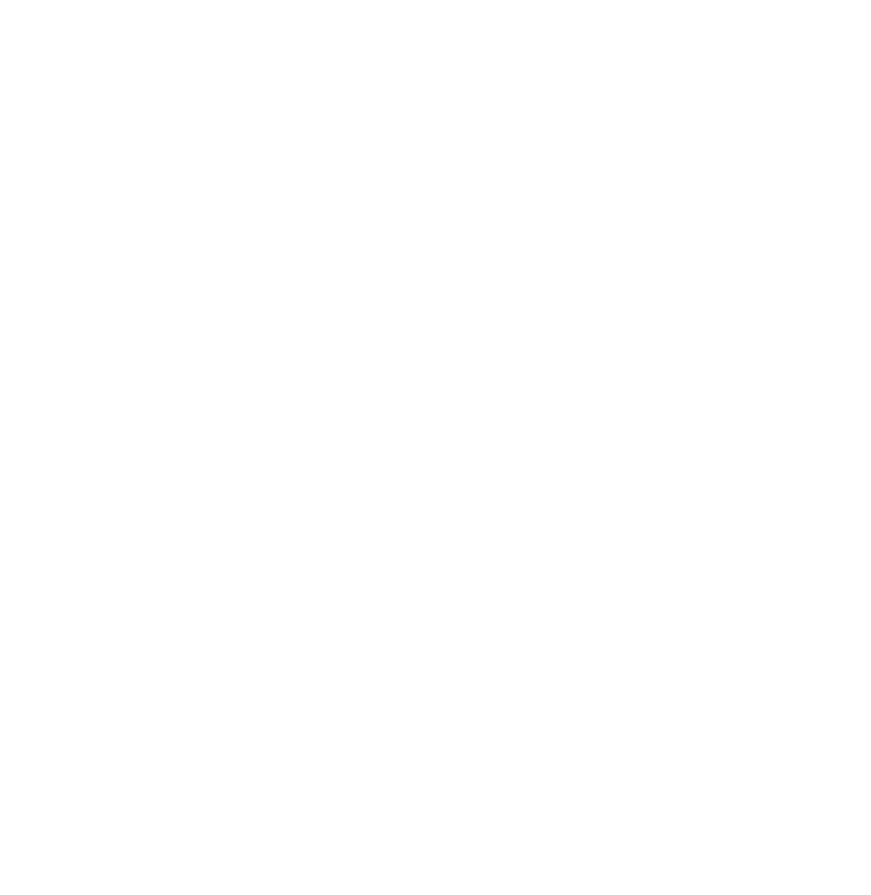di Timothy Radcliffe
Le conseguenze del distanziamento sociale nel nostro rapporto con Dio
Il 22 e 23 gennaio 2020, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha presieduto un comitato di emergenza per valutare se un nuovo virus scoppiato a Wuhan costituiva una questione di emergenza sanitaria pubblica internazionale. Il comitato non è riuscito a trovare un accordo. Il giorno dopo, il 24 gennaio, Papa Francesco ha pubblicato il Messaggio per la 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, sull’arte della narrazione. Il mondo stava per rendersi conto di un nuovo flagello globale. Quali storie possiamo raccontare dinanzi a una pandemia?
Il Papa afferma che abbiamo bisogno di storie «per non smarrirci (…) storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme». Le nostre storie, comunitarie e individuali forgiano il nostro senso del tempo, di modo che possiamo navigare con speranza verso un futuro. Ma in questo tempo di confinamento, i consueti calendari che ci danno un senso del futuro stanno venendo meno. Gli incontri familiari, per matrimoni e funerali, non sono possibili; non possiamo riunirci per celebrare le grandi solennità dell’anno liturgico; anche il calendario sportivo non ci dà più un senso di aspettativa. Il nostro tempo è diventato informe. Una pandemia ci lascia senza alcun orientamento. Abbiamo bisogno di storie che modellino la nostra vita in un tempo di calamità.
Provvidenzialmente, il messaggio del Papa inizia con una citazione — «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria» (Esodo 10, 2) — che fa diretto riferimento alle piaghe inflitte agli egiziani. Il sangue degli agnelli sugli stipiti delle case degli ebrei li salvò dall’ultima piaga, la morte di tutti i primogeniti maschi. Le piaghe nella Bibbia ci pongono di fronte alla morte, non solo come destino inevitabile di ogni cosa vivente, ma anche come potere spietato che soltanto il Signore della vita e della morte può rovesciare. Ogni pandemia contiene un accenno di apocalisse, del «cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno» (Apocalisse 6, 8).
Le epidemie hanno spesso gettato l’ombra della morte sull’umanità, ma mai fino ad ora eravamo stati così consapevoli di una minaccia globale. Tutti i giorni leggo quante vittime ci sono state in ogni Paese del mondo. Che storia di speranza può offrire oggi il cristianesimo dinanzi al covid-19?
La Pasqua ebraica era una memoria delle piaghe che portarono alla liberazione degli israeliti dalla schiavitù in Egitto. Questa memoria forgiava il confronto del Signore con il nemico più grande dell’umanità, la morte, la notte prima di essere tradito. È questa la storia con la quale possiamo ritrovare il nostro orientamento in un tempo di calamità. Quella notte crollava tutto ciò che dava un orientamento e una direzione ai discepoli. Tutto ciò in cui avevano riposto la loro speranza stava per sgretolarsi. Davanti a loro c’erano solo tradimento, negazione, diserzione, il crollo della loro piccola comunità e la passione e la morte di colui che li chiamava suoi amici. Come dissero i discepoli sulla strada di Emmaus: «Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele» (Luca 24, 21). La croce non sembrava essere solo la morte di una persona, ma la vittoria della morte stessa.
Quindi, il gesto di Gesù di prendere il pane, benedirlo e dichiarare che era il suo corpo, e che il vino era il suo sangue, fu un gesto pregno di una speranza che andava ben oltre ogni loro immaginazione. Non contrastava solo con la sua morte il giorno successivo, bensì con il regno della morte, protendendosi verso la vittoria del giorno di Pasqua.
Lo splendore del dramma di quella ultima notte lo si intravede in situazioni in cui la morte per un po’ getta la sua ombra oscura sui popoli. Questa cosa mi ha colpito per la prima volta durante una visita in Rwanda nel 1993, quando il genocidio stava appena iniziando. Dovevo andare a visitare le suore domenicane nel nord, quando arrivò l’ambasciatore belga avvisandoci di rimanere a casa perché il Paese era in fiamme, ma noi partimmo ugualmente. Dopo una giornata carica di violenza, di ribelli e soldati, di bambini mutilati dalle mine, mi recai a trovare le mie suore domenicane. Che cosa potevo dire in mezzo a tanto orrore? Ero a corto di parole. Poi ricordai che avevo da reiterare una memoria e una promessa, che sfidavano la morte e promettevano comunione quando l’umanità era dispersa. È questa la storia con cui sfidiamo la minaccia della pestilenza, ed è per questo che è molto triste che la maggior parte di noi non si possa riunire per celebrarla ma debba assistere online.
Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali è un invito a ricordare che anche nell’isolamento delle nostre case possiamo sostenere la comunione in modi che non sono mai stati possibili in passato.
Rispondiamo a una crisi globale con una comunione globale. Le persone che assistono all’Eucaristia quotidiana online nella mia prioria a Oxford sono il triplo di quelle che venivano in Chiesa prima del covid-19. Sto ricevendo uno tsunami di messaggi di posta elettronica e di telefonate. Uso Skype e Zoom come mai prima d’ora.
Tuttavia, l’isolamento fisico consuma la nostra umanità. Abbiamo bisogno del nutrimento del volto degli altri e del sostentamento di un tocco gentile. Se ne veniamo privati, la nostra umanità viene fatta morire di fame. I nonni non possono abbracciare i loro bambini e ci ritroviamo separati da persone che amiamo. Zoom e Skype non bastano. Come possiamo sopportare tutto ciò?
La storia dell’Ultima Cena racconta una comunione nata dall’isolamento sempre più profondo di Gesù. Durante l’Ultima Cena egli presiede una comunità che si sta già sgretolando. Nel giardino del Getsemani i suoi discepoli dormono mentre lui lotta da solo per affrontare il suo destino. È una figura solitaria quando si trova dinanzi al giudizio dei sommi sacerdoti e di Ponzio Pilato, e poi raggiunge la solitudine estrema della croce, resa indicibilmente più grave dalla folla urlante sottostante. Quindi, un modo per sopportare l’isolamento imposto a miliardi di persone è partecipare alla solitudine di Gesù, che l’ha sopportata perché noi potessimo appartenere gli uni agli altri in lui.
In Rwanda, e poi più di recente in Siria, a portata d’udito dal fronte con l’Is (il cosiddetto stato islamico), mi è stata svelata la speranza pregnante della nostra semplice storia eucaristica. È questa la narrazione che nessuna pestilenza può sovvertire. E tuttavia, da milioni di persone che vanno a messa è percepita semplicemente come noiosa. Per molti non tocca l’immaginario, è solo un triste dovere da sopportare.
È paradossale che uno dei racconti più popolari del ventesimo secolo, Il Signore degli Anelli di J.R.R Tolkien, sia una esplorazione della sua fede nell’Eucaristia. Poco prima della prima comunione del figlio Michael gli scrisse «io ti propongo l’unica grande cosa da amare sulla terra: i Santi Sacramenti. Qui tu troverai avventura, gloria, onore, fedeltà e la vera strada per tutto il tuo amore su questa terra». Sembra strano che un romanzo che ha toccato l’immaginario del mondo sia eucaristico, mentre invece l’Eucaristia stessa spesso non riesce a farlo. Come può diventare evidente la bellezza della sua narrativa?
Papa Francesco identifica l’eroismo come una caratteristica delle storie coinvolgenti: «Le storie di ogni tempo hanno un “telaio” comune: la struttura prevede degli “eroi”, anche quotidiani, che per inseguire un sogno affrontano situazioni difficili, combattono il male sospinti da una forza che li rende coraggiosi, quella dell’amore. Immergendoci nelle storie, possiamo ritrovare motivazioni eroiche per affrontare le sfide della vita». Il Signore degli Anelli è la storia di piccoli esseri che si muovono lenti, che temono l’avventura ma diventano eroi.
Se riusciamo a vedere il dramma della nostra Eucaristia come una storia d’eroismo, ciò potrebbe accendere la nostra immaginazione. Vengono subito in mente due esempi. Il primo è l’antico componimento poetico inglese The Dream of the Rood, che probabilmente risale al VII secolo. Ritrae Gesù come un giovane eroe che sale sulla croce per combattere come un cavaliere. Il secondo è il film Uomini di Dio (titolo originale: Des hommes et des dieux), diretto da Xavier Beavois, che nel 2010 ha vinto il Grand Prix al festival del cinema di Cannes. Ha colpito l’immaginario di milioni di persone perché è la storia vera di alcuni timidi monaci comuni che diventano eroi. Racconta di una piccola comunità di monaci trappisti in Algeria negli anni Novanta dello scorso secolo, che si ritrovano travolti da un’ondata crescente di violenza. Devono restare e rischiare di morire o andarsene? La scena più commovente è la loro Ultima Cena. L’anziano fratello Luc tira fuori un paio di bottiglie di vino e mette sul grammofono la musica del Lago dei cigni. Non viene detta una parola. Vediamo solo i loro volti, pieni di tristezza per la sofferenza che li attende e di gioia perché parteciperanno tutti alla storia degli ultimi giorni del loro Signore. È la bellezza assoluta di un eroismo eucaristico silenzioso e senza pretese.
Come possiamo vivere la situazione attuale in modo eroico e toccare così l’immaginario dei nostri contemporanei? Durante le pestilenze del passato, ad esempio la Morte Nera, i cristiani uscivano e servivano i malati, rischiando di morire. Gli eroi della nostra pandemia sono gli infermieri e i medici che lavorano in prima linea. Molti di loro lo fanno come espressione della loro fede cristiana, ma la Chiesa come può vivere in modo chiaro il dramma della storia eucaristica adesso che le chiese sono chiuse e molti ospedali, perlomeno nel Regno Unito, non lasciano entrare i cappellani?
Ho finito con l’accettare, con difficoltà, la saggezza e la correttezza della decisione di auto-isolare il clero. Altrimenti diventeremmo noi stessi strumenti di contagio. Esistono esempi di eroismo: don Giuseppe Berardelli, il sacerdote settantaduenne che ha rinunciato al ventilatore affinché un giovane potesse vivere, e di conseguenza è morto; oppure mi viene in mente un giovane domenicano americano che lavora a New York, il quale si è trasferito in un ospedale per essere d’aiuto alle persone colpite dal virus, anche se ciò ha significato lasciare la sua comunità. Mi è però difficile immaginare come la Chiesa possa rendere esplicito l’eroismo della nostra grande storia dinanzi al covid-19. L’auto-isolamento magari è necessario, ma non appare eroico! Forse è possibile con una sorta di santo realismo, guardando in faccia la morte, riconoscendo la tragedia unica vissuta da ogni vittima, ma rifiutando di cadere nel panico, poiché crediamo che il dominio della morte sia finito.
C’è un ultimo tema nel messaggio del Papa che, nella crisi attuale, ha assunto un rilievo inaspettato. Francesco sottolinea la bellezza di raccontare le nostre storie a Dio. «Raccontarsi al Signore è entrare nel suo sguardo di amore compassionevole verso di noi e verso gli altri. A Lui possiamo narrare le storie che viviamo, portare le persone, affidare le situazioni. Con Lui possiamo riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strappi».
Questa Pasqua sono stati in molti a non poter ricevere il sacramento della riconciliazione. Due mesi dopo la pubblicazione del messaggio, il Papa ha esortato i fedeli a confessare i loro peccati a Dio in assenza di un sacerdote. Questo non deve necessariamente essere un declamare i peccati, bensì, come suggerisce il messaggio del Papa, un raccontare la propria storia a Dio, con i suoi drammi, i suoi fallimenti e i suoi trionfi. San Tommaso d’Aquino, nel suo Scriptum super librum iv Sententiarum, va oltre e afferma che quando non c’è un sacerdote, si possono dire i propri peccati a un altro laico, che non può dare l’assoluzione, ma che è una sorta di ministro del sacramento “per necessità”. Quindi, in questa crisi, possiamo tutti rappresentare l’orecchio misericordioso di Dio, partecipando al dramma della vita altrui, rassicurandoci gli uni gli altri della vittoria finale dell’amore.
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 21 maggio 2020)