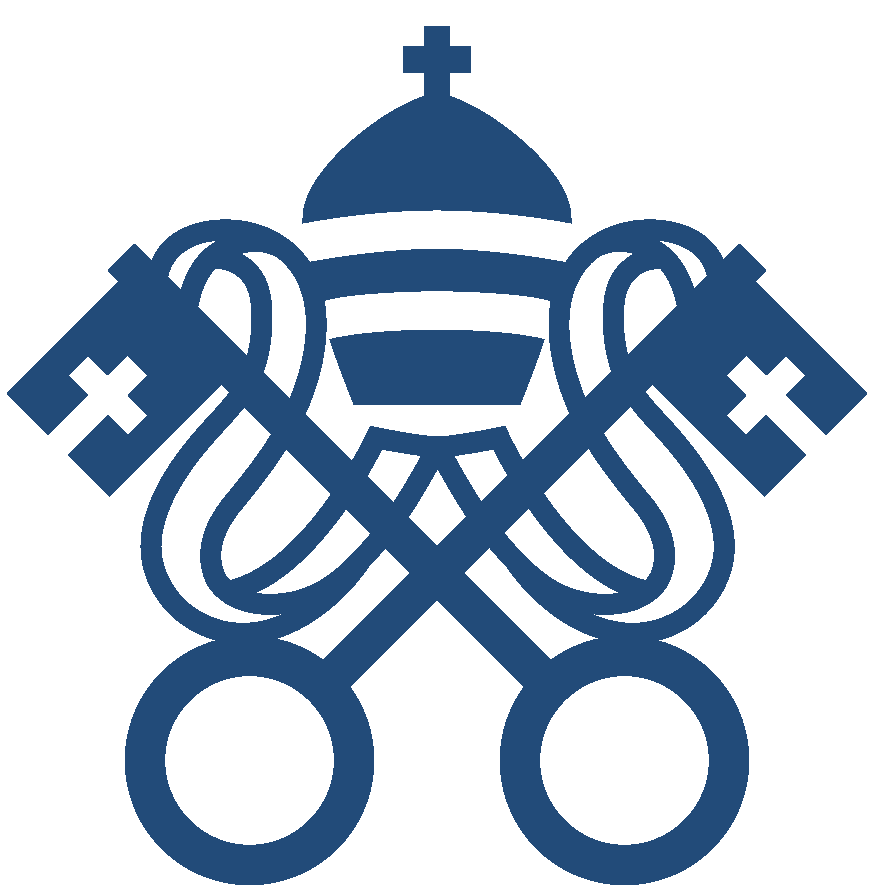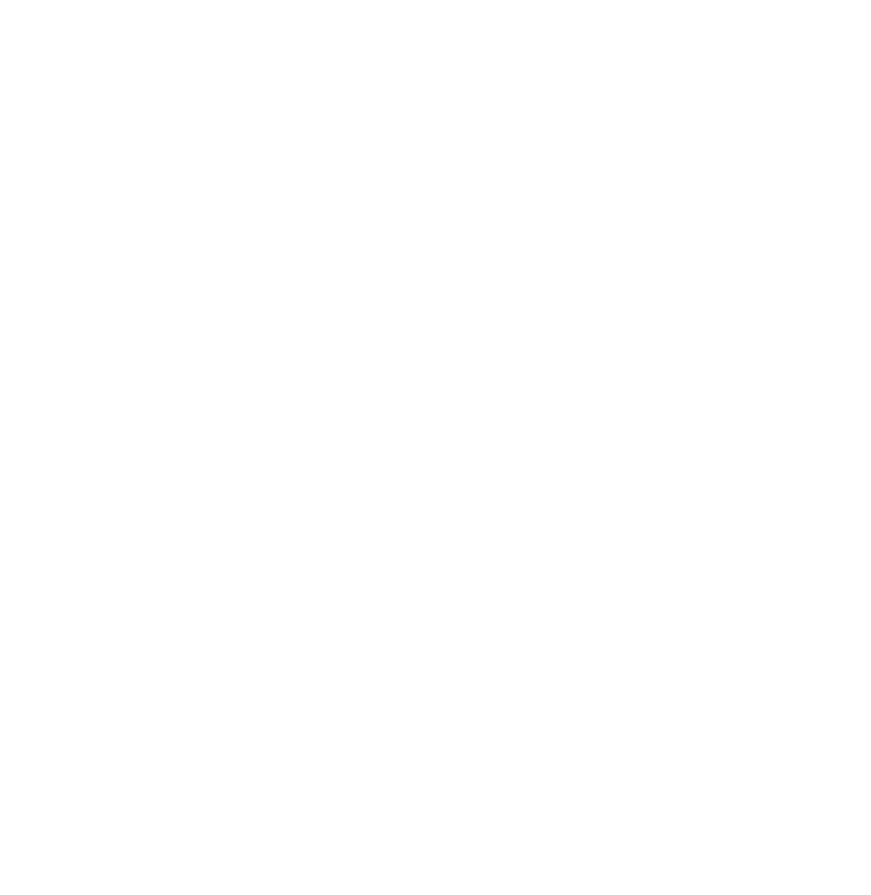di Sandro Veronesi
L’importanza della letteratura, dalla tradizione dei chassidim ai libri di Salman Rushdie
Il 24 gennaio scorso Papa Francesco, in occasione della 54ma giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ha pubblicato una riflessione sul tema della narrazione. E già qui: non è automatico il nesso tra comunicazione sociale e narrazione, al mondo laico spesso sfugge, concentrato com’è sull’informazione, i social media, lo storytelling (specificamente e giustamente messo in discussione nel testo del Papa) e i messaggi propagandistici di varia natura. In realtà è il primo nesso, la comunicazione sociale ha cominciato a esistere proprio con la narrazione — la narrazione orale, il racconto delle origini, la trasmissione della memoria collettiva, prima ancora dell’invenzione della scrittura — ma è un fatto che la nostra cultura fatichi assai a ricordarsene. Ci ha dunque pensato il Papa nella sua opera di scansione delle attività umane, e nello sforzo incessante che caratterizza il suo pontificato di aprire dialoghi con il mondo laico o raccolto attorno ad altre religioni. Il suo messaggio è dedicato al discernimento, ed è emozionante nel suo rivelare la profonda convinzione, non scontata per un Papa, che il bello coincida col bene.
Fino a non tanto tempo fa la bellezza era spesso associata al soffio di Satana, e l’associazione che invece Papa Francesco fa tra bellezza e Vangelo suona, alle mie orecchie di scrittore laico, contemporaneamente ovvia e rivoluzionaria. Ovvia perché il Vangelo è effettivamente una sofisticata, bellissima macchina narrativa, che aziona tutto ciò che un racconto perfetto deve azionare: stupore, ammirazione, sdegno, pietà, paura e fede — ed è oltretutto articolato in quattro versioni diverse, così da lasciare anche dei dubbi: quali sono state le ultime parole di Cristo? Cos’ha detto alle guardie a Getsemani? Rivoluzionaria perché una parola che sia traducibile con “bellezza” nei Vangeli non compare mai, né dall’esegesi viene enucleata: semplicemente, Cristo e i Vangeli non hanno alcun interesse all’estetica. Malgrado questo, Francesco parla di bene bello, e associa questo concetto proprio alla narrazione, partendo da una citazione dall’Esodo: «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria» (10, 2). Niente di più esatto si può dire, in realtà, circa lo scopo del racconto: fissare nella memoria — e la bellezza, allora, anche per il Papa, cioè per la Chiesa, è considerata il vettore privilegiato per conquistare la posterità.
Ripeto, non era scontato che lo dicesse il Papa, soprattutto in una comunità nella quale questo tipo di riflessione è generalmente confinato nella stretta comunità degli scrittori e dei letterati. Insomma, era la giornata mondiale delle comunicazioni sociali per tutti, non solo per il Papa, eppure nessuna carica pubblica del mondo laico ha pensato di dedicarvi un pensiero, né tantomeno di rivolgerlo direttamente all’atto del narrare. È in queste cose che si misura la grandezza delle persone, l’ampiezza della rete che gettano.
E tuttavia, come dicevo, quella riflessione è anche ovvia, poiché nessuno più di un credente deve riflettere sul tema della narrazione, dal momento che quando gli è stato proposto di credere in Dio gli è stato in realtà proposto di credere a un racconto. Questo spiega la gran quantità di testi “sacri”, dove al racconto è ancorata l’origine e la ragion d’essere dell’intera tradizione religiosa. Ogni religione ne ha, e se si va a grattarli con cura sotto a ognuno troviamo un bel racconto — dal momento che nessuno, e qui sta l’ovvietà, potendo scegliere, si accontenta di un racconto brutto. La bellezza non è necessaria soltanto ai paladini del gusto, lo è anche a quelli della rivelazione.
Vorrei citare due esempi provenienti dalle altre due religioni monoteiste a supporto di questo assunto. Il primo riguarda l’islam, ed è ciò che si può chiamare “esempio al contrario”. Più precisamente, riguarda la vicenda che ha portato alla Fatwa promulgata il 14 febbraio del 1989 dall’ayatollah Khomeini contro Salman Rushdie e tutti quanti avessero collaborato alla pubblicazione del suo romanzo I versi satanici (Mondadori, 1988). Di questa vicenda è nota perlopiù l’ultima parte e cioè la Fatwa stessa, la condanna a morte urbi et orbi per l’autore del libro, per i suoi traduttori e i suoi editori in tutto il mondo, resa ancora più micidiale dalla taglia che Khomeini, capo spirituale ma anche politico dell’Iran, mise sulla testa del romanziere anglo-indiano: tre milioni di dollari se il suo giustiziere fosse stato musulmano e un milione se non lo fosse stato. Già meno persone ricordano quale fosse, esattamente, l’accusa: apostasia (ridda), cioè l’abbandono volontario e blasfemo della propria religione. In pochi ormai rammentano quale fosse la vera questione, che si può riassumere così: in un passaggio del romanzo, uno dei personaggi che sta perdendo la fede fa un incubo terribile nel quale viene messa in scena l’antica leggenda secondo cui Maometto avrebbe recitato due versi della 53ma Sura del Corano, il 19 e il 20, sotto suggerimento di Satana. In quei due versi vengono menzionate tre divinità pre-islamiche, al-Lāt, al-ʿUzzā e Manāt, e gli abitanti della Mecca, ancora a maggioranza politeisti, cui la lettura di Maometto era rivolta, presero quella menzione come una deroga al rigido monoteismo che il Profeta andava predicando. La tradizione riporta che l’indomani fu Maometto stesso, resosi conto del malinteso, a ritrattare quei versi, sostenendo che non gli erano stati suggeriti nell’orecchio destro, dove sussurrava l’arcangelo Gabriele, bensì in quello sinistro. Nulla di nuovo Rushdie ha portato a questa leggenda, che l’islam aveva tramandato nei testi insieme all’interpretazione corretta senza che mai nessuno venisse condannato: perché, allora, contro di lui addirittura una Fatwa? La risposta a questa domanda è quello che ho chiamato esempio al contrario: Khomeini, intellettuale raffinato, giurista, teologo, esperto di filosofia e di gnosticismo nonché conoscitore della cultura e della letteratura europee, comprese che quella messa in scena, cioè quel racconto, andava ben oltre la riproposizione di una antica e superata diatriba teologica. Comprese che la qualità del racconto, la sua dettagliata definizione e la luce che da esso emanava avrebbero potuto recare un danno irreversibile all’ideologia integralista che aveva imposto e che severamente amministrava. Un conto era sapere di quella vecchia questione, o leggerne sui testi storici, e tutt’un altro era vederla in una rappresentazione narrativa di alta qualità. Per questo l’ayatollah ha deciso di fare ricorso allo strumento più potente e violento che i suoi poteri gli conferivano, nel tentativo di impedire il disastro, cioè la lettura di quelle pagine e la visione che ognuno ne avrebbe ricavato. (E sarà il caso di ricordare che, se Rushdie è scampato alla condanna, così non è stato per uno dei suoi editori e due suoi traduttori: l’editore norvegese, William Nygaard, fu ferito gravemente da tre colpi d’arma da fuoco esplosi contro di lui davanti a casa sua, a Dagaliveien, da un attentatore rimasto sconosciuto; il suo traduttore italiano, Ettore Capriolo, venne pugnalato per fortuna non mortalmente a Milano, e quello giapponese, Hitoshi Igarashi, invece fu assassinato, crivellato di colpi nel suo ufficio di Tokyo). Dunque, nella considerazione di Khomeini, il racconto di quella blasfemia che circolava da secoli era esso stesso diventato la blasfemia. Facendo per un attimo astrazione dalle tragiche conseguenze di quella Fatwa, e scusandosene con le sue vittime, si può affermare che essa sia stata la recensione più positiva che I versi satanici abbia ricevuto, cioè un madornale riconoscimento della sua bellezza.
Il secondo esempio lo devo a Giorgio Agamben che lo menziona all’inizio del suo libro Il fuoco e il racconto (Nottetempo, 2014) e riguarda lo chassidismo, cioè il movimento ebraico di rinnovamento spirituale fondato nel Seicento dal mistico polacco Yisrāēl ben Ĕlīezer, affermatosi con il nome di Ba’al Schem Tov (letteralmente “Maestro del Buon Nome”). Ebbene, lo scrittore israeliano Shmuel Yosef Agnon, premio Nobel nel 1966, racconta che quando il Ba’al Schem Tov doveva assolvere un compito particolarmente difficile andava in un certo posto nel bosco, accendeva un fuoco, diceva le preghiere e ciò che voleva si realizzava. Quando, una generazione dopo, il suo discepolo e successore Maggid di Meseritsch si trovò nella stessa situazione, si recò in quel posto nel bosco e disse: «Non sappiamo più accendere e il fuoco, ma possiamo dire le preghiere» — e tutto avvenne secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, quando toccò al suo discepolo e successore Mosche Leib di Sassov, egli andò nel bosco e disse: «Non sappiamo più accendere e il fuoco, non sappiamo più dire le preghiere, ma conosciamo il posto nel bosco, e questo deve bastare». E infatti bastò. Ma quando un’altra generazione trascorse e il suo discepolo e successore Yisrael Friedman di Ruzhin dovette anch’egli misurarsi con la stessa difficoltà, restò nel suo castello, si mise a sedere sulla sua sedia dorata e disse: «Non sappiamo più accendere il fuoco, non siamo capaci di recitare le preghiere e non conosciamo nemmeno il posto nel bosco: ma di tutto questo possiamo raccontare la storia». E, ancora una volta, questo bastò.
Dunque, anche qui il racconto non è più solo il vettore di trasmissione della verità, ma è la verità stessa: la storia del luogo segreto, del fuoco e delle preghiere diventa essa stessa il luogo segreto, il fuoco e le preghiere — e anche questa trasformazione, ma viene da chiamarla consustanziazione, è dovuta alla sua bellezza, che è dunque ben di più di un semplice effetto collaterale.
Ecco, il messaggio di Papa Francesco, così diretto, come al solito, e universale, rinforza queste considerazioni fatte però in precedenza all’interno di logiche strettamente religiose, e bisognose di interpretazione. Le sparge nel mondo laico, scavalcando non soltanto l’antica diffidenza del cristianesimo nei confronti del bello, ma menzionando tra gli esempi che fa anche opere non sacre, come I promessi sposi o I fratelli Karamazov. Di questo, per la forza che trasmette, e per la comunione che produce tra due tradizioni spesso messe in contrapposizione tra loro, bisogna ringraziarlo profondamente. E se posso finir così, vorrei aggiungere che mai mi sarei aspettato di dover ringraziare un Papa per avermi rifornito di energia nel mio minuscolo sforzo di scrivere romanzi — attività che semmai ero pronto ad accettare mi avrebbe condotto all’inferno.
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 14 maggio 2020)