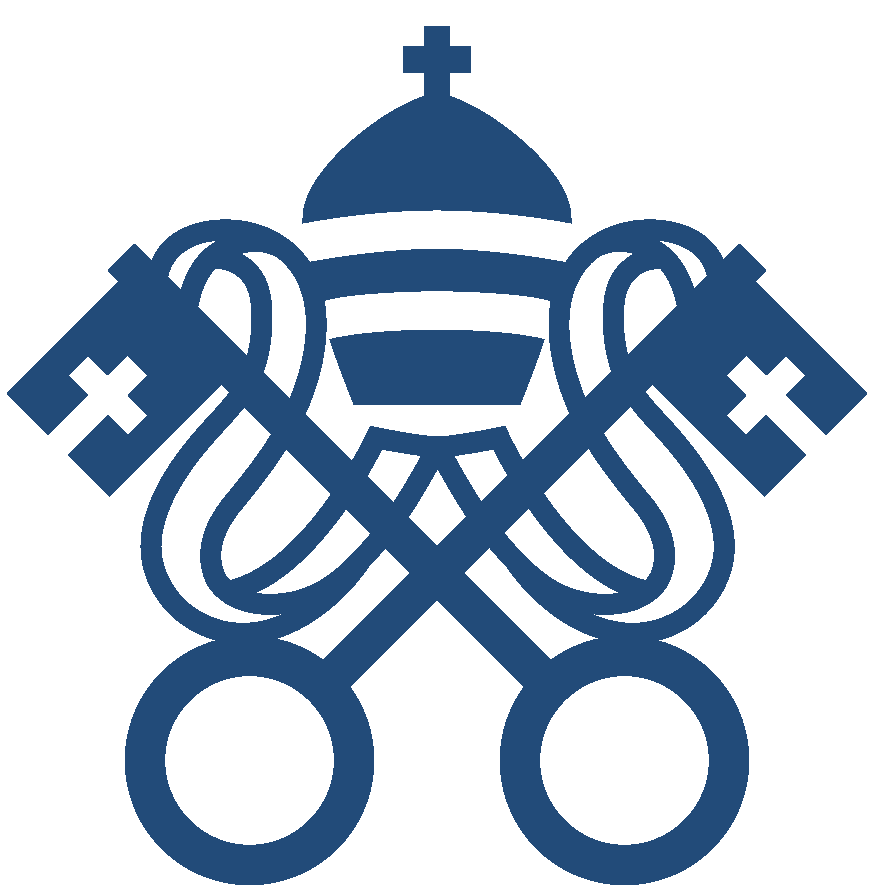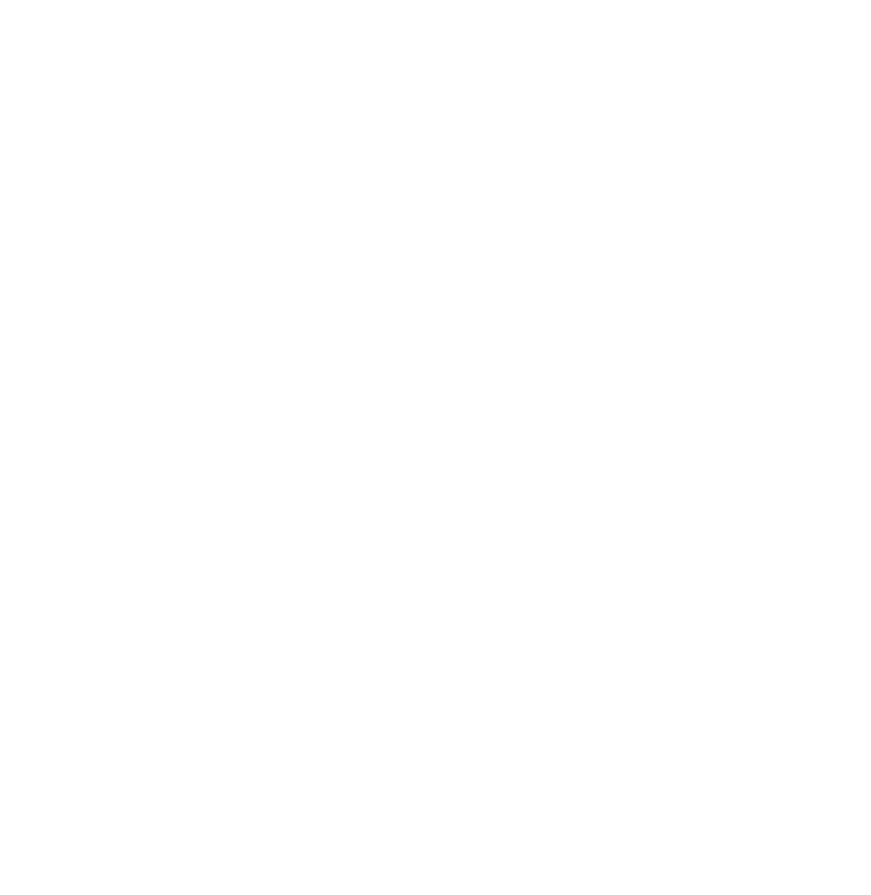di Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede
Quando ero bambino amavo le storie, i racconti capaci di trasfigurare la realtà. Amavo vedere le cose da un’altra prospettiva. Capovolta. Amavo la sorpresa, lo stupore, l’inatteso. Quando, poco più che adolescente, ho iniziato a fare il giornalista, ho amato di più la concretezza, l’analisi, la cronaca fredda delle notizie, nude e crude; convinto che da una parte ci siano i fatti, e dall’altra le storie.
Oggi che sono sulla soglia della terza età mi accorgo, grazie alle parole di papa Francesco nel suo Messaggio per la 54a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, quanto le due cose non siano in contrasto fra loro; quanto sia vero che noi siamo ciò che raccontiamo (le cose ci cambiano, infatti, per il solo fatto di dirle); e come anche le storie abbiano bisogno di noi per conoscere – nella concretezza della verità – un dinamismo che le riscatti.
Oggi mi rendo conto davvero che, come scrive Gregorio di Nissa, «tutti gli esseri soggetti al divenire non restano mai identici a se stessi, ma passano continuamente da uno stato a un altro mediante un cambiamento che opera sempre, in bene o in male […] e noi siamo così, in certo modo, i nostri stessi genitori, creandoci come vogliamo, e con la nostra scelta dandoci la forma che vogliamo»[1].
Ma sono i racconti – ci dice il Papa – che tessono le nostre identità. Per questo, «per non smarrirci, abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone […], abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che ci abita»[2]. E tocca a noi questo compito. Non tocca ad altri. Senza qualcuno che la racconta, la storia sarebbe muta, immobile, congelata. Vivremmo un eterno presente, senza futuro, senza speranza, senza prospettiva. Ecco la nostra frontiera.
«Le temps file ses jours, rien n’a changé ici et puis, sans qu’on y pense, on s’habitue à vivre sans avenir». Il tempo – scriveva Jacques Chaumelle in una canzone portata al successo in Italia da Luigi Tenco – tesse i suoi giorni e poi, senza pensarci, ci si abitua a vivere senza futuro: Un giorno dopo l’altro. Un giorno dopo l’altro rischiamo di assuefarci, oppure di avere paura. E rimaniamo fermi. Un giorno dopo l’altro smettiamo di sorprenderci; perché crediamo di sapere già tutto. Un giorno dopo l’altro ci abituiamo alla vista corta. E disimpariamo a vedere l’orizzonte dei nostri racconti. Che è più grande del confine che delimita il giornalismo.
Un invito rivolto alla Comunità tutta
Certo, c’è una vocazione del giornalista, di ogni giornalista: senza dubbio essa è quella di raccontare la realtà; di aiutare a capirla cercando di vedere cose che altri non vedono, distinguendo il vero dal falso, la parola che testimonia da quella che inganna.
E non c’è dubbio che per non tradirla dunque, questa vocazione, serve tempo, serve il tempo della ricerca e della comprensione, serve prendersi il tempo necessario; serve non lasciarsi prendere dalla fretta.
Ma la bellezza e la grandezza di questo Messaggio del Papa è nella universalità della chiamata, che ci riguarda tutti. Riguarda i giornalisti, ma anche gli scrittori, i registi, i poeti, gli artisti, i politici. I nostri racconti sono infiniti. Sono scritti, parlati, filmati; tessuti di parole, immagini, musica; memoria del passato e visione di futuro.
Come scrive Martin Buber nei suoi racconti dei Chassidim: «La parola che narra è più che semplice parola, essa trasmette effettivamente l’accaduto alle generazioni future, anzi la narrazione è accadimento essa stessa, ha la sacralità di un rito […] Il racconto è lo stesso avvenimento, ha l’unzione di un atto sacro […] è ben più che un’immagine riflessa: l’essenza sacra di cui dà testimonianza continua a vivere in essa»[3].
I nostri racconti sono la vita che tramandiamo. Tutti siamo responsabili del mondo che la nostra narrazione ricama. E a tutti il Papa chiede: qual è la storia che ci raccontiamo? Quanto la abbiamo davvero vissuta, meditata, riflettuta, capita, prima di raccontarla? È una storia vera? È una storia dinamica? O è una storia falsa? È una storia immobile? È una storia dove c’è l’uomo, e c’è il mistero che lo racchiude, o è una storia che cancella la nostra umanità? È una storia raccontata bene o è una storia raccontata male? È una storia aperta alla speranza oppure una storia chiusa? Una storia che si compiace del male o che cerca sempre, in ogni situazione, la scintilla di bene capace di riscattarla?
Tutte le storie si comprendono solo alla fine. Qual è la fine delle nostre storie? Quale spazio è lasciato al mistero di Dio, alla possibilità della redenzione? Dov’è la sapienza del racconto?
Le vie del racconto
«I grandi sapienti del passato – ha scritto il Papa nella Lettera enciclica Laudato si’ – correrebbero il rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo dell’informazione […] La vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una specie di inquinamento mentale»[4].
Non sempre ci rendiamo conto di quanto importante sia il ruolo della comunicazione (e in essa di ognuno di noi quando comunica) nell’essere strumenti di comprensione o di fraintendimento, nel costruire o nel distruggere una consapevolezza responsabile, nel nutrire o nel mal-nutrire le nostre identità in divenire.
A ognuno è richiesta questa capacità di vedere e di raccontare. Di denunciare il brutto e di scoprire il bello. Di trovare un riscatto anche al dolore, alla sofferenza; una prospettiva a ciò che appare inspiegabile. E di esprimere questo racconto con le parole, con le immagini, con la musica; di farlo vivere e respirare e crescere anche nell’arte, nel cinema, nella fiction. Per certi versi anche di più.
Se è vero, come scrive Jonathan Gottschall[5], che la finzione altera radicalmente il modo in cui le informazioni vengono elaborate e che le ricerche mostrano che quanto più siamo assorbiti da una storia, tanto più la storia ci cambia; tutte le storie ci pongono di fronte a una scelta nel modo in cui le raccontiamo.
Lo storytelling può essere intessuto di verità o di falsità, di uno sguardo puro o di uno sguardo duro, di pregiudizi o di misericordia, di ricerca del bene comune o di compiacimento nel racconto del male. Sta a noi dare allo storytelling lo stesso significato, la stessa funzione che gli ha dato e che gli da Dio. Sta a noi tessere la nostra storia per la parte che ci è data. Sta a noi non sottrarci alla responsabilità che ci compete. Oggi forse più che mai.
Quando la storia che narriamo incrocia il peccato, il crimine, il male, il nostro racconto non deve mirare a nascondere, a coprire, a ingannare. Il nostro racconto deve essere vero. Tutti sappiamo che il male esiste. E tutti sappiamo che a volte si manifesta anche con il tradimento da parte di chi non ci aspettavamo potesse tradirci mai. Succede, in forme diverse, nelle vite di ognuno. Succede purtroppo. Ci sono due modi di agire di fronte al male. Uno è arrendersi. Pensare (sbagliando) che il male abbia vinto. L’altro è reagire. Credere nel dinamismo del bene, del bello, del giusto. Credere nella possibilità di redenzione. Agire per il bene. La storia dell’uomo è questa. Vederla con gli occhi di Dio fa sì che anche il nostro racconto faccia parte del cammino verso il riscatto personale e collettivo della nostra storia.
Come scrive il Papa, «anche quando raccontiamo il male, possiamo imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del bene e dargli spazio»[6]. Le sue parole ci riportano all’essenza di un tema intorno al quale da tanto tempo giriamo in tondo, rischiando di perdere l’orientamento; con il rischio di far sì che l’era della comunicazione coincida con quella della incomunicabilità; e che il trionfo dei big data porti con sé la sconfitta della sapienza, necessaria per leggere e raccontare il senso di ogni storia, e con esso il significato della Storia.
Occhi di carne e di vetro
Narrare viene da gnarus, fare esperienza. Ma senza la capacità di ricondurre l’esperienza a unità, non c’è sapienza, e nemmeno conoscenza; tutto si riduce a una elencazione senza senso, a un polverone confuso di dettagli, una anarchia di briciole. A questo serve narrare. Solo il racconto è capace di rivelare ciò che non è immediatamente visibile agli occhi, ciò che è nascosto. Sempre, anche nella scienza, serve un’ipotesi di ricerca, una chiave di lettura delle cose. Per vedere le cose oltre l’apparenza, serve dunque l’uso del cuore, oltre a quello degli occhi.
Ho imparato questa lezione da una giovanissima scrittrice argentina, Veronica Cantero Burroni, cui le sofferenze non hanno tolto il sorriso e la gioia di condividere. Citando papa Francesco e lo scrittore latino americano Miguel Ángel Asturias, lei dice che gli occhi di carne servono per vedere la realtà, e accettare anche i propri limiti. Ma che esistono anche altri occhi, occhi di vetro, per andare oltre questi limiti. «Quando scrivo con l’occhio di carne osservo la realtà, quando scrivo con quello di vetro la trasfiguro».
Come un questa sua poesia in forma di dialogo:
- Quando ti vedo sorridere, desidero che quel sorriso sia mio. Non è per rubarti la gioia. È che tu sei stato lo specchio del mio desiderio più grande.
- Cosa desideri?
- Desidero che la gioia non sia effimera, che non sia schiava di una risata, che possa fiorire in mezzo alle spine con cui la vita ci trafigge. Ma come? Come fare che il dolore non ci porti via la gioia? Te l’ho chiesto con una angoscia prima nascosta. Come fai a fare in modo che il caos di ogni giorno non ti tolga quel sorriso che incanta? Per caso niente di fa male? Ti ho chiesto senza capire.
- Certo che ci sono cose che mi fanno male. Il dolore è inevitabile. E allora? Il dolore ci sfida, ma senza sfide la vita non sarebbe vita. Così come una rosa non sarebbe rosa senza spine.
- Vorrei poter strappare le spine dalla vita, ma non posso e quando provo a farlo mi pungo e mi fa ancora più male.
- Anche io ci ho provato, e dopo essermi ferita molte volte ho capito che anche se costa la cosa migliore è accettare le spine; perché con il tempo, da ognuna di essa nasce un petalo.
- È vero, ma come resistere mentre il fiore cresce?
- Abbracciando il mistero del bozzolo che, ancora in mezzo alla spina, inizia a fiorire. Se ogni giorno ci diamo il tempo di guardare negli occhi la bellezza di questo mistero è impossibile che la gioia non sia il dono di ogni giorno.
Ecco una lezione di racconto, in forma di poesia, da parte di una ragazza che ama la vita dalla sua sedia a rotelle. E usa le parole come carezze sulle ferite di ognuno di noi in un tempo che usa le parole come pietre, che si è assuefatto alla cultura dell’iperbole. E invece ha bisogno della giusta misura, della giusta distanza, della giusta prossimità.
In una sua commovente intervista a Tv2000, nel programma condotto da Monica Mondo, Veronica ha spiegato il suo segreto: «Scrivo quando sento che ne ho bisogno, quando sento dentro di me un grido […] Parlo a Dio e gli affido tutta la paura, tutti i dubbi che ho … e Lui mi rida la fede e la certezza […] Lui è il protagonista della mia storia… e attraverso di me Lui la racconta. E io ascolto … ascolto Lui e ascolto anche il dono che Lui mi ha donato […] Nella scrittura ho scoperto che (la malattia) non è la mia croce, ma la ragione per cui io scrivo. Perché Dio mi ha detto: “Io ti do questo dono perché attraverso di esso tu possa dimostrare alle persone che si può […] La mia famiglia mi ha insegnato che Dio non mi abbandona mai e che c’è sempre una ragione per la difficoltà che io incontro nel mio cammino»[7].
Le parole di questa giovane scrittrice, i suoi racconti, le sue poesie sono la miglior risposta allo spirito del tempo, che descrive ogni tenebra come impenetrabile dalla luce. E che, assolvendoci da ogni responsabilità, costruisce le false ragioni del nostro scontento, fondandole su attese e delusioni senza fondamento; segnate dalla rassegnazione di chi ha cancellato dal suo orizzonte l’idea dell’inatteso e la fatica di un cammino.
Dentro le spaccature
I poeti spesso vedono più lontano. In una delle sue più belle canzoni, Leonard Cohen, che prima di essere un cantautore è stato un poeta – e che in quanto tale riusciva a vedere e descrivere le cose al di là dell’apparenza – ha scritto un distico che potrebbe essere l’icona di quel che è non solo la frontiera comunicativa del Papa, ma anche la nostra, in questo nostro tempo così diviso, frantumato: «There is a crack in everything, that’s how the light gets in» (“C’è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce”)[8].
Ecco un modo diverso di vedere le spaccature, camminarci dentro. Vedere la luce che le attraversa. Anche Giacomo Leopardi, che pure non aveva il dono della fede, guardava oltre. Parlando alla luna del mistero del dolore[9]:
Pur tu, solinga, eterna peregrina,
Che sì pensosa sei, tu forse intendi,
Questo viver terreno,
Il patir nostro, il sospirar, che sia;
[...]
E tu certo comprendi
Il perché delle cose, e vedi il frutto
Del mattin, della sera,
Del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
Riflettendo sull’Universo, Leopardi aggiunge:
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito Seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono
Ancora, inventandosi una sublime, paradossale, definizione della noia: «La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani […] il non poter essere soddisfatti da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; […] e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; […] e sentire che l’animo umano e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo»[10].
La verità è che l’uomo non può raccontarsi senza intessere le sue parole di un unico interrogativo: che cosa sono? Perché sono? Cosa ci faccio qui? Cosa c’è oltre? Domande alle quali non si può pretendere di dare una risposta chiusa. Fuori dal tempo e dalla storia. Cioè fuori dal mondo. Dal nostro dolore, dalle nostre speranze.
Domande che trovano risposta solo raccontandosi a Dio. Come scrive papa Francesco nel Messaggio: «Raccontare a Dio la nostra storia non è mai inutile: anche se la cronaca degli eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva»[11].
Mia madre, prima di morire, lasciò a noi suoi figli una lunga riflessione in forma di racconto sul senso della vita alla luce della fede. E citando la Bibbia, la storia di Giuseppe, la storia di Giobbe, alcuni episodi del Vangelo, scrisse:
«È solo con uno sguardo lungo che possiamo trovare il senso. È solo con una visione di insieme che riusciamo a definire i contorni del disegno della nostra vita. Non possiamo riuscirci mentre li viviamo, mentre siamo immersi nei nostri dolori o nei nostri sorrisi. Ma lo possiamo fare quando riusciamo a vederci da lontano. Lo possiamo fare solo avanti negli anni, guardandoci indietro. Solo allora capiremo che ogni prova ha avuto un senso. Ogni lacrima versata o passo calcato hanno avuto un preciso significato. E tutti quei passi, quelle curve e quelle cadute ci hanno condotto per mano per compiere la pienezza della nostra vita. “Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione” (Gc 5,11). Dobbiamo solo ricordarci di guardare, di riconoscere quelli che sono i segnali che Dio ci manda. In un incontro, in un sorriso, in una telefonata, in un libro o in un film. Ma siamo noi a dover saper cogliere questi segnali. Essere disposti ad ascoltare. Siamo noi a dover imparare a sorprenderci di quanti segni è costellata la nostra vita. Piccole briciole nei posti più̀ inaspettati. Voci appena sussurrate che solo noi abbiamo la possibilità̀ di percepire nel frastuono di giorni. Piccoli bisbigli, proprio come una brezza leggera. Soffi di Amore che non smettono mai di accarezzarci. E solo imparando a riconoscere quella brezza ci accorgeremo di come ne siamo stati sempre avvolti. Ogni giorno».
Di questo racconto è intessuta la mia storia.
Ho letto una volta di una disputa, a tratti surreale, fra due dei più grossi scienziati del secolo scorso, Hans Bethe e Leó Szilárd. I due discutevano a proposito della opportunità di tenere un diario delle cose viste e vissute, delle persone incontrate, delle emozioni e dei pensieri suscitati. Szilárd sosteneva di voler scrivere un diario, non tanto per sé, quanto per memoria di Dio, e Bethe replicava che il suo progetto non aveva molto senso, in quanto “Dio sapeva già tutto”. E pare che Szilárd avesse risposto: “Sì, certo, ma non conosce la mia versione”. In questo dubbio, in questa insicurezza, in questa fragilità, c’è la chiave della narrazione.
Il tempo del racconto
Sempre le cose richiedono la pazienza del tempo, il tempo della conoscenza, per essere svelate. Una volta, in una sua intervista, Christiane Amanpour ha detto che il compito del giornalista è raccattare una storia in una situazione in cui la verità non è sempre appurabile. E che l’unica esclusiva che possiamo veramente difendere è quella che ci deriva dal rapporto vero, diretto, con le persone. Era un modo per affermare – credo – che la verità è sempre una ricerca. E che la ricerca nasce dall’indagine della realtà. Cioè dal camminare dentro le storie che fanno la Storia.
Se c’è un vizio, invece, che impedisce di vedere la verità delle cose, che ci fa scambiare l’apparenza per la sostanza, esso sta nel camminare nel mondo pensando di sapere già tutto, prigionieri dei nostri pregiudizi; sta nel non prendersi il tempo necessario per incontrare, per conoscere, per discernere e riconoscere anche in quella degli altri la nostra storia comune, per comprendere cosa è che riconduce a unità la complessità frammentata del reale.
Ma c’è sempre un modo diverso di dire le cose. Quando riusciamo a dare un senso razionale ed emotivo insieme al flusso ininterrotto di eventi. Quando gli diamo una spiegazione, un dinamismo positivo, una prospettiva. Un oltre. Quando oltre ai problemi individuiamo le vie d’uscita; oltre al male la redenzione possibile. Oltre al personaggio, la persona. Quando riusciamo a ricondurre a unità la globalizzazione frammentata che caratterizza il nostro tempo.
Altrimenti la comunicazione senza storia, senza senso, senza verità, senza incontro, finisce con il divorare se stessa, con il ridurre a zero il suo contenuto. E si trasforma in una trappola che ruba l’anima e l’intelletto a chi sembra costretto a connettersi per esistere, e ad alienarsi connettendosi.
Da queste domande, da questa assunzione di responsabilità che ci riguarda tutti, possiamo riprendere il cammino. E riprenderlo, da credenti, con la consapevolezza di un evento che ha cambiato la storia, illuminandola nel mistero di Dio che si fa uomo proprio per redimerla.
Il Papa ci ricorda che «una buona storia è in grado di travalicare i confini dello spazio e del tempo. A distanza di secoli rimane attuale, perché nutre la vita». Ci dice che siamo chiamati, «di generazione in generazione, a raccontare e fissare nella memoria gli episodi più significativi di questa Storia di storie, quelli capaci di comunicare il senso di ciò che è accaduto». Ci ricorda che «la conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccontando, di generazione in generazione, come Egli continua a farsi presente. Il Dio della vita si comunica raccontando la vita»[12].
Un cammino diverso
Lo sapevano bene i Re Magi, sapienti di quella sapienza che rischiamo di perdere nel trambusto delle nostre vite. Per proteggere la storia che era stata loro rivelata e il Dio Bambino che la incarnava, furono avvertiti in sogno che per tornare a casa occorreva scegliere un altro cammino.
Conviene anche a noi, per ritrovare il luogo che custodisce il senso della storia e del racconto, scegliere un cammino diverso rispetto a quello che ci ha portato sin qui. Per ripartire serve un altro cammino, un’altra storia, un altro modo di vedere, di raccontare, di fare memoria, di costruire – narrandolo – il futuro.
[1] Gregorio di Nissa, La vita di Mosè, II, 3.
[2] Francesco, Messaggio per la 54a Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia, 2020.
[3] M. Buber, I racconti dei Chassidim, Garzanti, Milano 1979, pp. 3-4.
[4] Francesco, Lettera enciclica Laudato si’, 24 maggio 2015, n. 47.
[5] Cfr. J. Gottschall, L’istinto di narrare: come le storie ci hanno reso umani, Bollati Boringhieri, Torino 2018.
[6] Francesco, Messaggio per la 54a Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, cit.
[7] Cfr. Intervista a Veronica Cantero Burroni realizzata da Monica Mondo, programma Soul, Tv2000, 27 agosto 2018 (https://www.tv2000.it/soul/video/speciale-soul-meeting-rimini-2018-veronica-cantero-burroni-ospite-di-monica-mondo/).
[8] Leonard Cohen, canzone Anthem, album The Future, Columbia Records 1992.
[9] G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 1831.
[10] G. Leopardi, Pensieri, n. LXVIII, in Zibaldone.
[11] Francesco, Messaggio per la 54a Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, cit.
[12] Ibidem.
(Articolo tratto da Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, 22 maggio 2020)
Per maggiori dettagli sul volume, ulteriori informazioni e per leggere tutti gli altri contributi si rimanda all'articolo dedicato sul sito dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI.