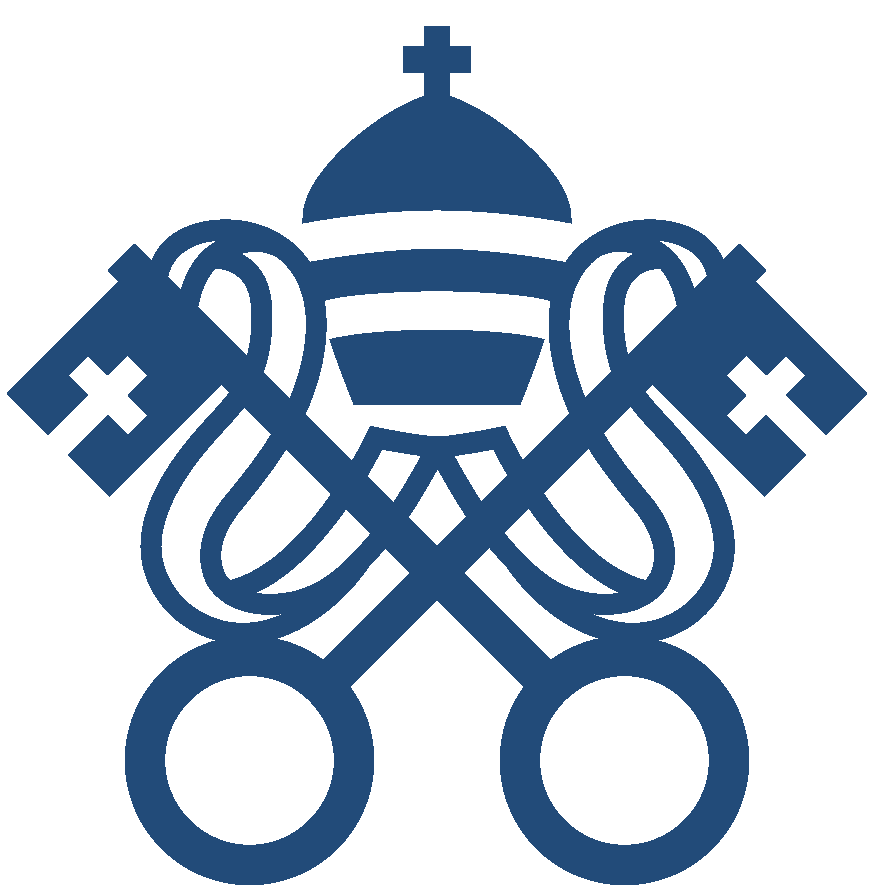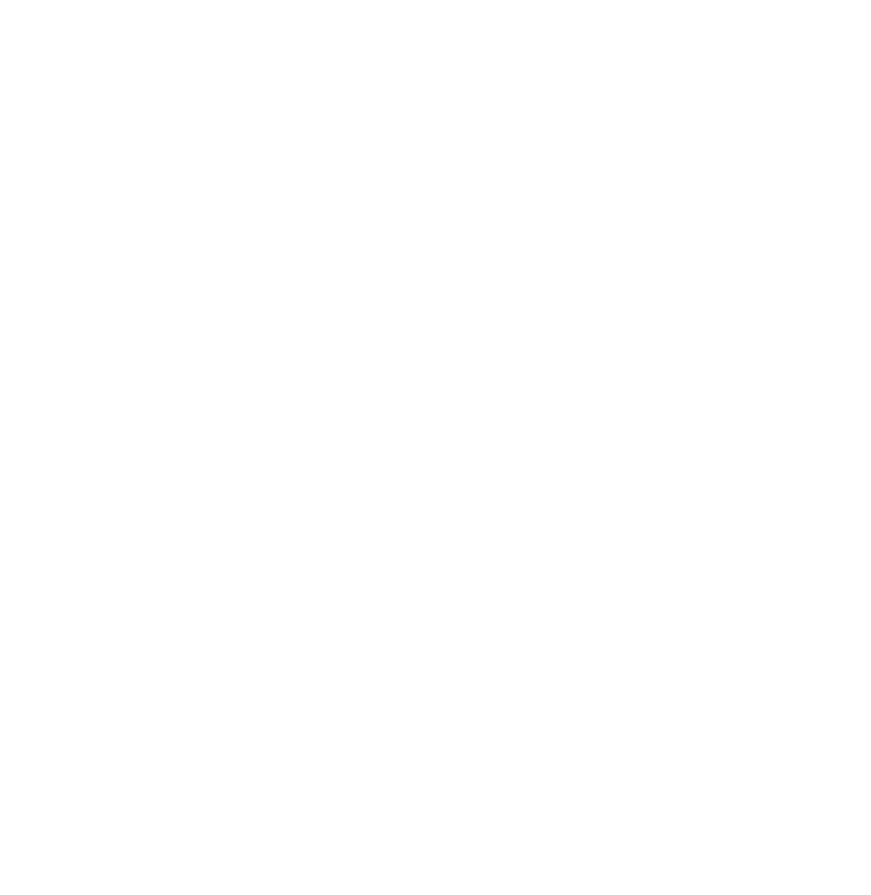di Guglielmo Spirito
«Desidero dedicare il Messaggio di quest’anno al tema della narrazione, perché credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita. Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri».
Papa Francesco, con una manciata di parole lanciate come semi, risveglia in chi legge una foresta incantata, greve di suggestioni e di allusioni feconde. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, dove potrei smarrirmi, dove ho bisogno di respirare e di trovare la forza e le radici per andare avanti (un ossimoro, degno degli Ent: radici per camminare!). Una narrazione umana che ci parli del bello che ci abita (magari anche cantando, come la famiglia von Trap nel vecchio film The Sound of Music); che riveli l’intreccio dei fili delle nostre vite, intessute assieme (come capita a Scrooge in A Christmas Carol di Dickens).
«L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di cibo. Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, di notizie…, le storie influenzano la nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato. I racconti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri comportamenti, possono aiutarci a capire e a dire chi siamo (…) L’uomo è un essere narrante perché è un essere in divenire, che si scopre e si arricchisce nelle trame dei suoi giorni. Ma, fin dagli inizi, il nostro racconto è minacciato: nella storia serpeggia il male».
Le storie che da bambini amiamo sentirci raccontare o leggere, ci plasmano (come capita a Elsa ed Anna in Frozen ii. Il segreto di Arendelle), ci segnano e ci aiutano a capire e a dire chi siamo (hobbit che come Frodo, Sam, Pippin e Merry diventano capaci di andare ben oltre alle cose scontate e trite, accettando avventure e sfide, e ritrovandosi cambiati). Non abbiamo bisogno di sapere che ci sono draghi che serpeggiano — ogni bambino lo sa — ma loro e noi abbiamo bisogno (come diceva Chesterton) di ricordare che c’è un san Giorgio che uccide il drago, e che i nostri alleati sono più numerosi dei nostri avversari (cfr. ii Re 6, 15-17) come del resto il nostro angelo custode (anche se noi, ahimè, non lo ricordiamo) ce lo ricorda con la sua presenza.
«La storia di Cristo non è un patrimonio del passato, è la nostra storia, sempre attuale», dice il Papa. «Non hanno dunque una fine i grandi racconti?», domandò Sam. «No, non terminano mai i racconti», disse Frodo. Come I promessi sposi (molto adatti in tempi di pestilenza), come I fratelli Karamazov (molto adatti in tempi di aspiranti Grandi Inquisitori), come innumerevoli altre storie. Lunghe o corte, romanzi, racconti, poesie, fumetti: Jorge Luis Borges, il padre Leonardo Castellani (in particolare, le sue Camperas) e Quino (la sua Mafalda meriterebbe essere doctor honoris causa) solo per citare alcuni autori argentini, ai quali si potrebbero aggiungere i racconti del comico Luis Landriscina e quelli del gruppo di musica-commedia Les Luthiers, oppure anche i canti di Los Chalchaleros.
«Abbiamo bisogno di pazienza e discernimento per riscoprire storie che ci aiutino a non perdere il filo tra le tante lacerazioni dell’oggi; storie che riportino alla luce la verità di quel che siamo, anche nell’eroicità ignorata del quotidiano».
Questo può essere mostrato attraverso un racconto. In Leaf by Niggle, di J.R.R. Tolkien, ci viene presentato Niggle, un pittore di scarso successo, sempre indaffarato ma mai in grado di portare a termine con efficacia qualcosa: è però sempre disponibile ad aiutare gli altri, in particolare il suo vicino Parish, zoppo e brontolone.
Niggle è ossessionato da un dipinto, nato come immagine di una foglia e poi cresciuto come albero e quindi come bosco, che teme di non riuscire a finire perché cresce continuamente di dimensioni: il pittore sa infatti che presto dovrà partire per un lungo viaggio, e vorrebbe riuscire a finire il quadro prima.
Padre Elia Citterio, dei Fratelli Contemplativi di Gesù (in un articolo pubblicato come «Foglia» di Niggle) afferma che sarebbe troppo banale, ma non fuori posto dire che il personaggio Niggle rimanda allo scrittore stesso, alle prese con le mille angustie quotidiane, con le innumerevoli fatiche, impegni, impedimenti, fallimenti eppur sempre dedito a ciò che lo interessava veramente; sempre dibattuto tra il bisogno di convalide e riconoscimenti altrui alla propria opera creativa e, nello stesso tempo, la fede insopprimibile in quell’opera secondo la percezione interiore della propria anima. Non si tratta però di un rimando alla sua realtà biografica. Si tratta piuttosto di forzare la propria realtà biografica come si forza con un grimaldello la serratura di un forziere che contiene un tesoro. L’importante, del racconto, è quel tesoro, imprendibile anche allo scrittore stesso, ma la cui sagacia narrativa lo fa intravedere al possibile lettore, ignaro, più dello scrittore, di quello stesso tesoro. Il tesoro lo si ravvisa nel suggerimento di tre dinamiche che si intersecano continuamente per creare spazi di percezione della verità del vivere. La prima: l’esito non è il senso. Il racconto si distende su tre tempi definiti rispetto al quadro da dipingere: un tempo per abbozzare il lavoro, un tempo per finirlo e un tempo per concluderlo. Ogni tempo è caratterizzato da sensazioni particolari: fatica e agitazione nel primo, tranquillità e soddisfazione nel secondo, comunione e contemplazione aperta sul mistero indefinibile nel terzo. Senza tenere insieme i tre tempi la percezione del lavoro è falsata e non scaturisce nessun senso.
Il filo rosso che tiene insieme i tre tempi e permette di coglierli a specchio l’uno nell’altro perché appaia il senso, mai descritto ma sempre presupposto, è quello che posso chiamare la sincerità profonda del cuore. Perché il senso non è mai nell’esito? Perché il senso non ha ragioni utili, ma solo ragioni vere, che però non sono immediatamente coglibili nelle contraddizioni degli eventi quotidiani e dei sentimenti che insorgono. Le ragioni vere si distinguono dalle ragioni utili perché non sono reazioni a qualcosa o a qualcuno, ma provengono da quella sincerità di cuore. La seconda: non esistono limiti costrittivi, ma solo confini di accesso. Nei tre scenari si assiste ad un continuo spostamento di confini, ma con l’impressione del movimento e della distanza diametralmente opposti. Nell’abbozzo del quadro tutto sempre si complica per il continuo crescere del dipinto, per le continue interruzioni che si susseguono, per i continui rimandi al dopo o a un po’ più in là. Invece nella finitura e nella conclusione del quadro i confini si dilatano senza creare distanza.
Ci si muove sempre più avanti, sempre più in là, fino alle Montagne, il Margine invalicabile da cui però tutto discende, senza subire la distanza. Straordinariamente descritto: «Mentre si allontanava scoprì una cosa strana: la Foresta, ovviamente, era remota, eppure poteva avvicinarlesi, persino entrarvi, senza che essa perdesse quel suo particolare fascino. Mai gli era riuscito prima di entrare nella distanza senza trasformarla in semplici dintorni immediati. E questo aggiungeva considerevole piacere alla passeggiata in campagna perché, mentre procedeva, nuove distanze gli si spalancavano dinanzi, sicché si avevano distanze doppie, triple e quadruple, doppiamente, triplamente e quadruplarmente incantevoli. Si poteva andare avanti e avanti, e avere un paese intero in un giardino o in un dipinto (se così si preferiva chiamarlo)».
Tradurrei queste annotazioni in termini siffatti: se ci si muove solo sull’asse orizzontale ci si affanna e disperde. Ma se ci si muove sull’asse verticale (della profondità o del senso), allora la distanza non crea dispersione ma apertura. E più ci si inoltra, più tutto appare in spazi godibili.
La terza: l’eccedenza del reale sorprende sempre. Nonostante la banalità quotidiana, non solo delle azioni ma anche dei pensieri, il grande si gioca nel piccolo, l’importante nell’insignificante e così via. Per questo non è possibile attingere l’assoluto che nella contingenza più concreta, spesso percepita ostile o fastidiosa, percorsa in quell’ andare “più in là” nella dimensione della profondità del segreto di senso che non dipende mai da quella contingenza ma unicamente dal cuore che vi si apre, nell’alleanza con il suo Dio.
La materialità della vita, nelle sue contingenze di situazioni penose o comunque difficili, sembra giocare spesso a nostro sfavore nel realizzare quello che portiamo di grande; eppure, l’unico modo per esprimere la grandezza è quello di affidarsi, di sottostare alla Provvidenza per noi nelle minime cose, in tutti gli eventi, esteriori e interiori, per far fiorire lo splendore del Regno.
Niente è limite; tutto è porta di accesso. Se la realtà della vita non fosse percepita in questa eccedenza che apre sul Regno resteremmo soffocati o illusi e incapaci di vera solidarietà in umanità. In altre parole, incapaci di adorare e di vivere in letizia.
Non lo testimonia pure la storia del buon ladrone (cfr. Luca 23, 39-43) al quale, nel vortice atroce dell’agonia sulla croce accanto a Gesù, si sente dire da lui: «In verità ti dico, oggi con me sarai in paradiso?». Eppure, lo ricordiamo così poco a questo ladrone, solo quando capita ogni tre anni quella pagina del Vangelo nella solennità di Cristo Re! Soltanto nella chiesa di Gerusalemme c’è la sua memoria liturgica (il 12 ottobre). Il resto della chiesa cattolica, ahimè, assurdamente lo scorda (essendo poi, ironia ancora più cruda, l’unico santo canonizzato in direttissima da Gesù stesso). Scordare la sua storia, non è un simbolo della nostra dimenticanza di riconoscerci intessuti nella sua stessa storia? Ma non vogliamo forse che anche che la nostra storia abbia un finale analogo, un happy ending davvero tale?
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 28 maggio 2020)