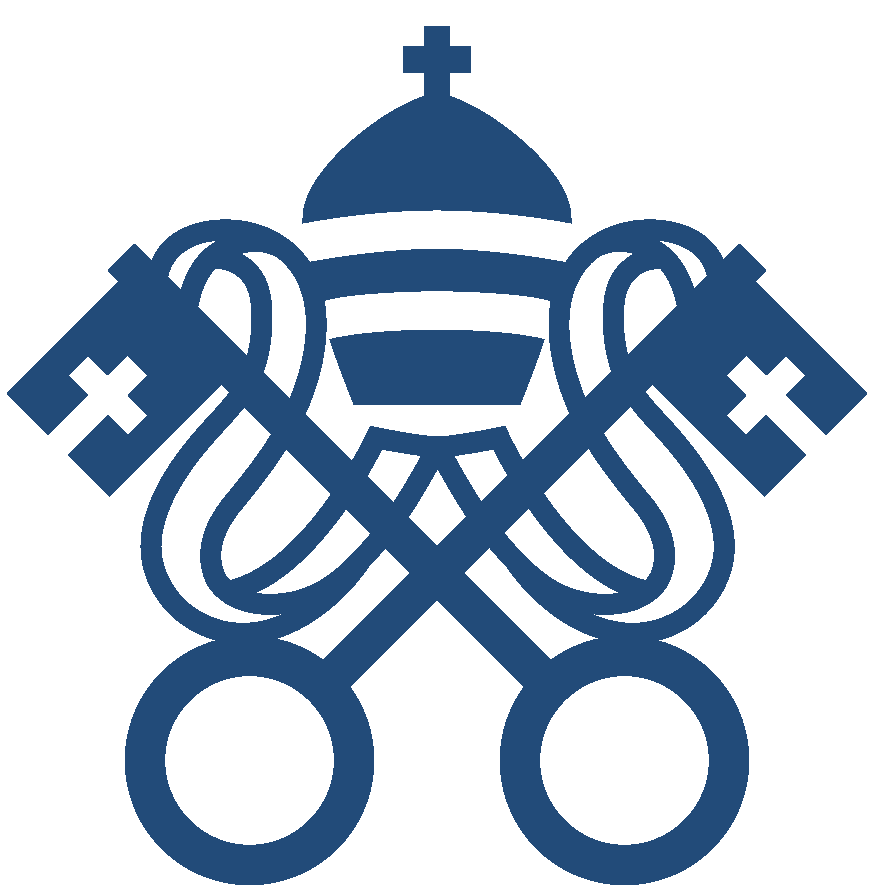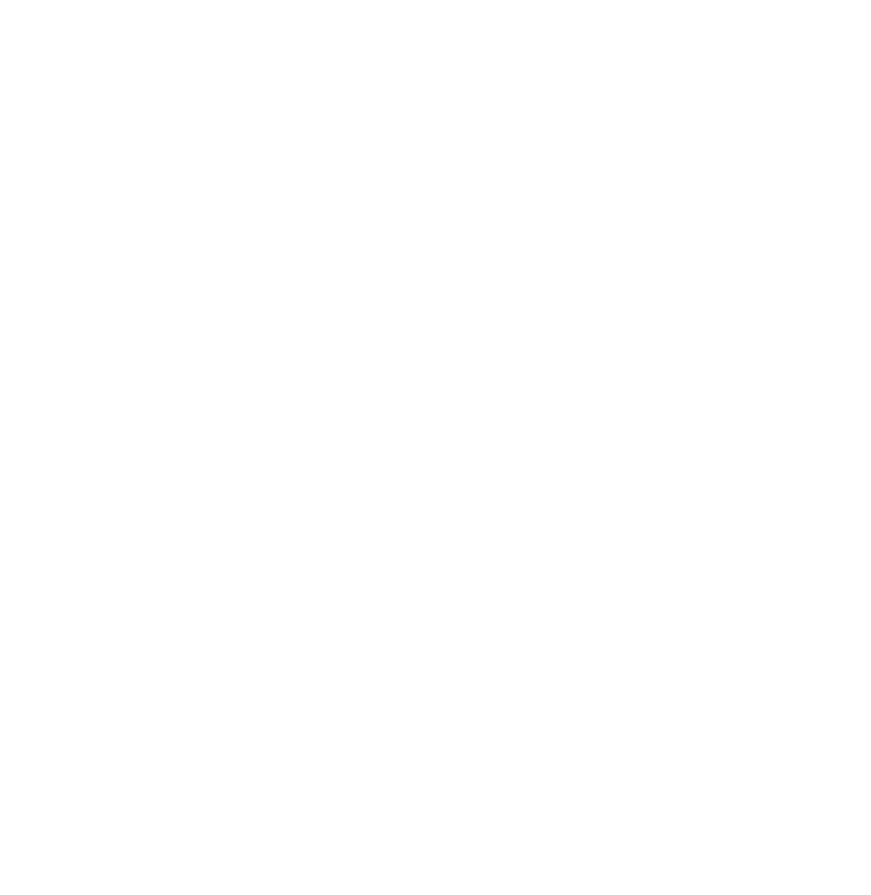di Piero Pisarra
Racconta, ricorda. È il doppio comandamento che percorre tutta la Bibbia. In un ordine che dà la precedenza al racconto. Perché non c’è memoria senza racconto. Così è anche nel brano dell’Esodo (10, 2) da cui prende avvio il Messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni sociali: «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria». Raccontare i prodigi del Signore, tramandare di generazione in generazione le sue gesta. Memoria viva, dinamica. Che ha nel racconto la sorgente principale.
La Bibbia è fatta di racconti, intessuta di storie, anche, forse soprattutto, nei libri poetici, un repertorio di storie narrate e di altre intraviste o sognate, materia di incipit strepitosi («Mio padre era un arameo errante», Deuteronomio 26, 5) e di altrettanto strepitosi colpi di scena, peripezie, svelamenti. È il Grande repertorio delle passioni, in cui troviamo in nuce i generi della nostra letteratura.
L’apologo sul potere? Ecco, nel libro dei Giudici (9, 7-15), gli alberi della foresta che prendono la parola come nel romanzo di Richard Powers, Il sussurro del mondo (La nave di Teseo, 2018), premio Pulitzer 2019. Il mystery enigmistico? Un difetto di pronuncia, una password detta male, può costarvi la vita, se siete dalla parte sbagliata (ancora nel libro dei Giudici: 12, 5-7). Il racconto di spionaggio? Uno fra tutti: le spie mandate in avanscoperta a Gerico e nascoste dalla prostituta Raab (Giosuè 2, 1-24). E poi, ovviamente, l’epica, le guerre, i drammi passionali, le vendette, argomento di romanzi di appendice e di chi sa quanti film hollywoodiani. #MeToo? C’è già tutto nella storia di Susanna e i vecchioni (Daniele 13, 1-64).
Gli studiosi di narratologia hanno analizzato nei dettagli la costruzione del testo, le peculiarità della retorica biblica, l’uso dei simboli e delle metafore, le sapienti strategie narrative. Ma nelle Scritture c’è un’altra sapienza — patrimonio condiviso della grande letteratura sotto qualsiasi cielo — che fa leva sul nostro bisogno di storie per raccontarci un’altra storia, di un’alleanza, un patto inaudito tra Dio e il suo popolo.
«L’uomo è un essere narrante», ci ricorda il Papa. E non è necessario che sia scrittore di professione per dar vita a nuovi personaggi e a nuove trame, viaggiare nella memoria o in territori inesplorati. Ma allora perché — se raccontare è una facoltà comune — questo intervento in difesa della narrazione, questo messaggio sul valore delle storie?
Forse perché i nostri racconti si sono corrotti, le nostre storie inaridite, i nostri canti spenti sulle labbra. E profeti improvvisati annunciano la fine del romanzo o della narrazione, come ieri la fine della “storia”. Sfondati i muri delle utopie novecentesche di cui abbiamo visto i risvolti illusori, è venuto, quasi senza accorgercene, il tempo di altri muri. E di altre illusioni propagate in nome di un “cattivismo” rivendicato come realismo e spacciato per virtù. Dimenticando che, da Erodoto in poi, le storie nascono dall’incontro e dal dialogo con l’altro, l’intruso, il clandestino, il diverso, colui che ci ostiniamo a chiamare barbaro, perché si esprime in un idioma diverso dal nostro. Nello spazio lasciato vuoto dalla politica intesa weberianamente come professione e come vocazione, si insinuano così i falsificatori di storie, gli imbonitori, i maestri di fake news, moderni nel lessico ma da cui già la Bibbia metteva in guardia: «Non spargerai false dicerie; non presterai mano al colpevole per far da testimone in favore di un’ingiustizia. Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo così da stare con la maggioranza, per ledere il diritto» (Esodo 23, 1). Sembra storia di oggi ed è storia di sempre.
Complottismo, trionfo dell’irrazionale e costruzione del nemico insidiano l’etica, anzi l’èthos, del racconto, alimentano storie parallele, narrazioni sgangherate, sono l’anti-storia, anti-lògos. Perché, aveva ragione George Steiner, «nelle parole, come nella fisica delle particelle, c’è la materia e l’antimateria». La parola che cura e il discorso che inganna, ferisce. Un narrazione che avvince e che esalta il piacere dell’ascolto e della lettura. E una che ci conduce verso il basso. Non per i contenuti, o non solo per i contenuti, ma per la sciatteria dello stile, la banalità delle strategie narrative, l’inconsistenza dei personaggi.
L’anti-lògos minaccia il racconto e la stessa arte del narrare, come nell’affascinante Harun e il mare delle storie di Salman Rushdie (1990). In una città triste triste, così triste da aver persino dimenticato il proprio nome, le fabbriche della tristezza riversano sugli abitanti il fumo grigio della monotonia. E anche nell’unica isola di buonumore, un quartiere vecchio e in rovina, dove abitano il cantastorie Rashid Khalifa e il figlio Harun, si infiltra il veleno del tedio. Rashid, giocoliere di parole, che incantava con i suoi racconti di intrighi amorosi, le saghe di vigliacchi e di eroi, di «principesse, zii malvagi, zie obese, gangster baffuti in pantaloni gialli a scacchi», si accorge di non aver più nulla da raccontare, la sua vena si è inaridita, qualcuno ha contaminato la sorgente di tutte storie.
Mettete al posto delle ciminiere di tristezza le fabbriche dell’odio, i troll, le officine di disinformazione, cambiate il nome del Principe del silenzio con quelli degli apprendisti dittatori tornati in circolazione, ed eccovi in territorio familiare, perché, secondo la vecchia regola, mutato nomine de te fabula narratur, anche quella di Rushdie.
Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a sentirci nel mezzo di una crisi epocale, davanti all’abisso, i primi ad assistere al ritorno sulla scena pubblica di pulsioni primitive, di logiche tribali, e alla distruzione della natura, al diffondersi di nuovi virus e di nuove malattie. «La lucida coscienza disperata di stare nel mezzo di una crisi decisiva è qualcosa di cronico nell’umanità», ricordava Walter Benjamin. Ma l’orizzonte è cambiato. Questa volta la potenza di distruzione accumulata negli arsenali di guerra, il disastro ecologico, le disuguaglianze sempre più stridenti, minacciano la stessa sopravvivenza del pianeta e la possibilità di una storia comune, di un racconto condiviso.
Ecco perché il richiamo del Papa ad aver cura delle storie giunge nel momento opportuno. Le storie sono un bene fragile, da custodire. La loro arte richiede pazienza, ascolto, la capacità di far scorrere in esse il soffio, il ritmo della vita. Arte povera, che non ha bisogno di amplificatori potenti, di strumenti sofisticati. «Ridatemi i narratori di villaggio: “In un paese lontano lontano”», esclama un personaggio del bel romanzo di Cees Nooteboom, Il giorno dei morti (Iperborea, 2001).
Ma se è necessario custodire la memoria del passato, coltivare la biblioteca dei ricordi — bene ancor più prezioso nelle culture che privilegiano l’oralità — a ogni generazione è chiesto di inventare i propri racconti, resistere ai prìncipi del silenzio che vorrebbero controllare o prosciugare il mare delle storie. E anche per la Chiesa si apre ogni volta un cantiere immenso: narrare la fede nella lingua del tempo. È l’aggiornamento indispensabile, in fedeltà a Gesù di Nazareth, il Rabbi che insegnava in parabole, Maestro delle storie..
(Da L'Osservatore Romano, giovedì 16 luglio 2020)